Traiettorie dell’anticomunismo
di Bruno Bongiovanni
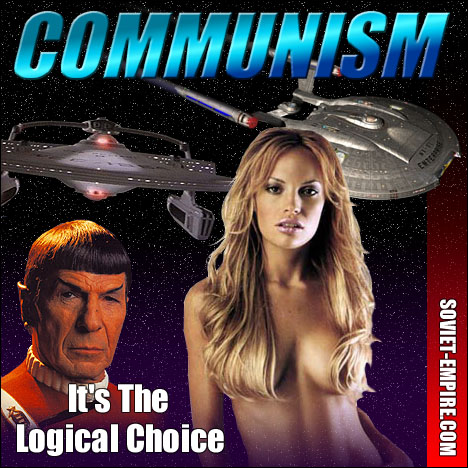 L’anticomunismo è un fenomeno che ha certo un cuore antico. Ha tuttavia avuto tante anime. Ed è stato declinato, nel corso del tempo, in modi storicamente e concettualmente diversi. Non va d’altronde passato sotto silenzio il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, il termine comunismo è comparso per la prima volta nel 1569, in ambito religioso, e in lingua latina, come atto d’accusa, e quindi con significato negativo, contro la setta protestante dei fratelli moravi. Questi ultimi, a quel che sosteneva l’anonimo anabattista anticomunitario che per primo produsse, proprio contro di loro, il termine “comunisti”, pretendevano, mettendo in comune i beni, di trasformare la vita quotidiana in vita conventuale. Annullavano così, a suo dire, la necessaria distanza tra esistenza laicale ed esistenza monastica. Alle origini della sua accidentatissima vicenda semantica, il comunismo germinò dunque da un’evidente intenzionalità anticomunista. Si può così quasi dire che il sospettoso anticomunismo sia nato prima del paventato comunismo.
L’anticomunismo è un fenomeno che ha certo un cuore antico. Ha tuttavia avuto tante anime. Ed è stato declinato, nel corso del tempo, in modi storicamente e concettualmente diversi. Non va d’altronde passato sotto silenzio il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, il termine comunismo è comparso per la prima volta nel 1569, in ambito religioso, e in lingua latina, come atto d’accusa, e quindi con significato negativo, contro la setta protestante dei fratelli moravi. Questi ultimi, a quel che sosteneva l’anonimo anabattista anticomunitario che per primo produsse, proprio contro di loro, il termine “comunisti”, pretendevano, mettendo in comune i beni, di trasformare la vita quotidiana in vita conventuale. Annullavano così, a suo dire, la necessaria distanza tra esistenza laicale ed esistenza monastica. Alle origini della sua accidentatissima vicenda semantica, il comunismo germinò dunque da un’evidente intenzionalità anticomunista. Si può così quasi dire che il sospettoso anticomunismo sia nato prima del paventato comunismo.
Dopo varie peripezie lessicali, il termine, inteso principalmente come movimento reale della società, si affermò definitivamente intorno al 1840. Suscitò grandi passioni, e divenne per un decennio popolarissimo, anche se il significato pareva tutt’altro che chiaro. Il comunismo era infatti appunto il movimento della società, oltre che il fine ultimo, e immanente, di tale movimento, e poi, ma non sempre, e non subito, il programma politico – il partito comunista organo del proletariato – di chi tale fine auspicava. Il comunismo restò insomma semanticamente indeterminato. Anche quando lo fecero proprio Marx ed Engels. I quali, peraltro, a parte le ristampe del Manifesto, non utilizzarono quasi più il termine dopo il 1852. Fu invece il “socialismo” che si volle “scientifico”. Il comunismo fece però al suo apparire paura perché si diceva che era rintracciabile, come la loro natura nascosta, in tutti i movimenti liberali, democratici, e “di progresso”. Proprio per questo divenne uno spettro. Il 2 agosto 1847 Honoré de Balzac scrisse a Madame Hanska: “l’Italia sta per cominciare la sua insurrezione, ma questa sarà una cosa terribile, dal momento che non si può neppure immaginare la strada che sta facendo il comunismo, dottrina che consiste nel tutto rovesciare e nel tutto dividere, persino le risorse alimentari e le merci, tra tutti gli uomini considerati come fratelli”. I moti non inattesi dei patrioti italiani contenevano dunque, senza che i patrioti neppure lo immaginassero, una possibile deriva “comunista”. E quest’ultima era considerata, da chi la temeva, lo spettro che si celava nel processo rivoluzionario in quanto tale. Tale processo, come la rivoluzione francese aveva messo in evidenza, non era arrestabile. Sulla sua strada si sarebbe comunque insinuata la guerra sociale. E poi il comunismo. L’anticomunismo fin dall’inizio fu dunque legato al conservatorismo giacché ogni scavalcamento di quest’ultimo, anche se aveva di mira le costituzioni liberali o l’indipendenza nazionalie, poteva trascinare, innescando un processo inarrestabile, verso il confusamente temuto spettro comunista.
Il comunismo, trasformato a tal punto da essere un’altra cosa, tornò poi nel 1918, nella Russia arcaica, sotto le vesti del bolscevismo leninista, destinato poi a trasformarsi in bolscevismo stalinista. Questa volta si ebbe a che fare non con il movimento della società, ma con uno Stato che si autodefiniva operaio. E il partito comunista non fu più un mero programma di un drappello di democratici internazionalisti, ma un organismo rigidamente coeso e centralizzato. L’anticomunismo assunse allora diverse forme: fu fascista (e subì in qualche circostanza il fascino dell’odiatissima URSS rivoluzionaria), fu liberaldemocratico e libertario (opposto ai sovietici come ai fascisti), fu liberalconservatore (disponibilie talora ad essere indulgente con i fascisti in chiave antisovietica), fu clericale (e in questo caso fu irriducibile), fu liberista (e pronto a scorgere nell’URSS il capolinea antieconomico del processo statalista contemporaneo), fu infine socialista e socialdemocratico (e pronto a negare, con sfumature di volta in volta diverse, il carattere “socialista” dell’URSS). Nel periodo tra le due guerre l’anticomunismo fu accesissimo nel 1917-’21, si attenuò un poco nel 1922-’28, fu ambivalente nel 1929-’35 (quando l’URSS lanciò la politica “classe contro classe” e tuttavia suscitò ammirazione per il fatto di eludere con i piani quinquennali la crisi del ’29). La politica dei Fronti popolari riaccostò ai comunisti i democratici e i socialisti. Il patto nazisovietico allontanò nuovamente questi ultimi e rappresento anzi il momento culminante dell’anticomunismo-antifascismo liberaldemocratico. La guerra e la Resistenza nuovamente riaccostarono ai comunisti, contro il comune nemico fascista, gli antifascisti democratici e socialisti. L’anticomunismo fascista ritenne dunque – per ricapitolare – che lo Stato sovietico, parentesi del 1939-’41 a parte, fosse un rivale che andava eliminato. L’anticomunismo conservatore, così come quello clericale, anche quando le repliche della storia gli imposero di deporre ogni indulgenza nei confronti del nazifascismo, ritenne che l’URSS e il comunismo fossero per sempre perduti dal punto di vista dei valori, laici e religiosi, della civiltà cosiddetta “occidentale”. Democratici e socialisti, invece, ritennero, soprattutto nel 1941-’45 (pur essendo stati delusi in Spagna), che la comune battaglia antifascista avrebbe democratizzato inevitabilmente se non l’URSS, almeno i comunisti di tutti i paesi, sempre in primissima fila, e con enormi sacrifici, nella difesa della comune libertà e nello stesso processo della ricostruzione dell’Europa democratica.
L’URSS staliniana, anche con il perseguitare i soldati che tornavano dalla guerra antifascista, rimase, fino alla morte del tiranno, e anche oltre, uno Stato totalitario. In Italia e anche in Francia, invece, i comunisti erano diventati, pur nel permanente legame con l’URSS, socialdemocratici nei fatti ed inseriti a pieno diritto nella vita costituzionale e nazionale dei loro paesi. La scommessa liberaldemocratica, insomma, era stata vinta a metà. La guerra fredda, tuttavia, incrudelì sì con nuove e feroci repressioni ad Est, ma riscoprì ad Ovest un anticomunismo primario che non faceva distinzioni. Un anticomunismo che ebbe punte ossessivo-paranoidi con il maccartismo e che non esitò a trovare sponde nelle dittature militari assassine e liberticide, nell’estrema destra antidemocratica e nel clericalismo. Lo spazio dell’anticomunismo democratico e socialista si ridusse. Anche perché i democratici e i socialisti che si volevano indipendenti non di rado vennero accusati di essere a loro volta comunisti.
Vi fu dunque, nella seconda metà del ‘900, un anticomunismo n. 1, diplomatico-militare e geopolitico, tutto giocato sulla divisione del mondo in blocchi e sul “contenimento” dell’espansionismo sovietico. Vi fu un anticomunismo n. 2, politico-culturale, proteso nella difesa del “mondo libero” e suddiviso ancora, nella pur comune alleanza autoproclamatasi antitotalitaria (ma non sempre con le carte in regola), in diverse famiglie: la reazionario-dittatoriale (come in Portogallo e in Spagna), la conservatrice (o anche clericale), la liberaldemocratica e la socialdemocratica. Queste due ultime, in taluni casi, cercarono di porsi, talora coraggiosamente e intelligentemente, come “terze forze” tra conservatorismo-clericalismo e sinistre radicali e comuniste. Vi fu infine un diffusissimo e spesso prevalente anticomunismo n. 3, che utilizzava il comunismo come alibi per sabotare le riforme, per frenare l’emancipazione sociale e per rallentare il grande processo della decolonizzazione. Chi chiedeva diritti civili e politici per i neri dell’Alabama, tanto per fare un esempio, era sistematicamente accusato di essere “comunista”. L’anticomunismo, d’altra parte, non cercò mai di liberare le vittime dei regimi comunisti esportando la democrazia (vedi Berlino 1953 e Ungheria 1956) e talora, invece, distrusse la democrazia – con relativo bagno di sangue – là dove non vi erano regimi comunisti (vedi Indonesia 1965 e Cile 1973). L’anticomunismo n. 1 e quello n. 2 furono dunque fortemente condizionati, e qualche volta addirittura travolti, e danneggiati, dall’anticomunismo n. 3, vale a dire dall’anticomunismo parassitario degli interessi. L’anticomunismo sopravvissuto e tenuto in caldo dopo la caduta dei comunismi – l’anticomunismo grottesco di Berlusconi, che non esita ad assolvere Mussolini – è, oltre che una ripetitiva retorica da rispolverare nei non rari momenti di disperazione, il residuo populistico-demagogico del n. 3. Senza più né la realtà, né la foglia di fico, del n. 1 e del n. 2. Siamo tornati al punto di partenza. Non è il comunismo che genera l’anticomunismo. È quest’ultimo che, senza più alcuna serietà, inventa il comunismo. E definisce comunisti quelli che non lo sono mai stati o che non lo sono più da decenni.
————————
Pubblicato su Aprile del novembre 2003