I demoni e la pasta sfoglia
di Michele Mari
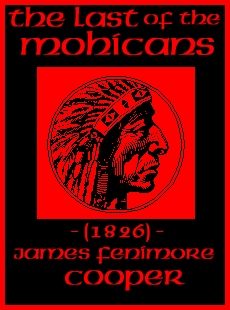 [Esce da Quiritta questo bellissimo libro di Michele Mari, I demoni e la pasta sfoglia, di cui pubblico la prefazione e uno dei capitoli. Ho scelto il brano su James Fenimore Cooper nella ricchissima orgia letteraria di Mari per motivi di indianità. Ringrazio Michele Mari e Quiritta per la loro disponibilità. DV.]
[Esce da Quiritta questo bellissimo libro di Michele Mari, I demoni e la pasta sfoglia, di cui pubblico la prefazione e uno dei capitoli. Ho scelto il brano su James Fenimore Cooper nella ricchissima orgia letteraria di Mari per motivi di indianità. Ringrazio Michele Mari e Quiritta per la loro disponibilità. DV.]
——
I demoni e la pasta sfoglia
Céline, Gadda, Gombrowicz, Kafka, Borges, Conrad, Canetti, Manganelli, Perutz, Melville, Landolfi, Maupassant: molti dei nostri scrittori prediletti sono degli ossessi. Ossessione è da assedio, ma il suo nome scientifico, anancasma, è da destino, ananké. Scrittori al servizio della propria nevrosi, pronti ad assecondarla e a celebrarla: scrittori che hanno nell’ossessione non solo il tema principale (e insieme il metodo con cui anche la più semplice esperienza è assottigliata in pasta sfoglia verbale), ma l’ispirazione stessa, sì che nessuna interpretazione mi pare fuorviante come quella che ne riconduce l’opera a un intento salvifico, quasi la scrittura sia solo un surrogato della pratica psicoanalitica. Al contrario, è proprio scrivendo che essi finiscono di consegnarsi inermi agli artigli dei demoni che li signoreggiano, finché, posseduti, essi diventano quegli stessi demoni. Così, nelle loro pagine, quelle visioni, quegli stravolgimenti, quell’eccitazione verbale, quegli avvitamenti retorici, quelle torsioni espressive (insomma quell’altissima maniera) non sono offe stilistiche gettate nelle fauci del mostro, ma lo stile stesso del mostro (uno stile paradossalmente naturale). Questo significa che lo scrittore-ossesso parlerà della propria ossessione anche quando non ne fa un tema esplicito, anche in àmbiti insospettati: il Gadda delle norme radiofoniche, ad esempio.
Come sa chi ci sta, l’ossessione è soprattutto una forma, come lo schema molecolare di un cristallo o un retino ottico. A quella forma soggiacerà tutto, dalle “cose” di cui si vuole scrivere alle parole con cui scriverne alla sintassi alla punteggiatura (i tre puntini di Céline, “l’invention du siècle”, certo la più necessaria che io ricordi). Per questo motivo trovo folle che, prima ancora di interrogarne la coerenza interna, si riconducano alla categoria dell’inautentico i capricci e le acrobazie espressive, il manierismo e il barocco, il calligramma e il pastiche, laddove la stessa natura esibitoria di tali direzioni ne fa qualcosa di candido e ignudo, di impudicamente autobiografico, di oscenamente realistico. Poco tempo fa si è discusso della presunta naturalezza di Comisso appo (non voglio dire versus!) la “maschera” di Gadda o Manganelli o Landolfi: mi sembra evidente che la questione sia da rovesciare, e che ci si debba chiedere: può mai un Comisso, senza il fastoso dispiegamento di artifici stilistici di quegli altri scrittori, parlarci di sé (cioè della vita) con la precisione e l’assoluta coincidenza con cui ce ne parlano loro? Witold Gombrowicz è quel biascicamento di nenie dementi, Tommaso Landolfi è quella fuga di stanze in palazzi vetusti e autore e fuga sono quella lingua inattuale, Manganelli è veramente il “nuovo commento” a un necrologio, Conrad è quell’estenuante indagine (im)morale che a sua volta è i vapori di quel mare ammalato: e per non dare l’impressione di onorare soltanto i virtuosi della penna aggiungerò (nominando forse il più amato di tutti): Jack London è quelle zanne e quella solitudine.
Certo all’origine di ogni creazione artistica è l’ossessione-angoscia della morte: su questa passione dominante (che l’artista condivide con il collezionista, il cleptomane, il libertino, il fondatore d’imperi, il mistico) s’innestano più speciali affezioni, come l’insoddisfazione della vita (quel senso di un’“esistenza mancata” cui Binswanger attribuisce ogni appetito di risarcimento formale) o all’opposto il senso di un traboccante excessus vitae. In entrambi i casi si dà virulenza, morbosità, necessità fisiologica, perché non c’è operazione più violenta e arbitraria di quella che imprime una forma alla propria vita. Se non ho mai capito la distinzione fra lo “scrittore” e il “narratore” è solo perché non concepisco letteratura che non parta dalle viscere e non passi per le idiosincrasie e le ossessioni, e dunque che non rinvii a quel pieno (o a quel vuoto) anche quando inventa personaggi e destini apparentemente “oggettivi”. Chi più di Robert Louis Stevenson merita il titolo di narratore? Egli è la voce, è lo spirito di affabulazione fatto persona e poi penna, è colui che anche all’adulto impone la posizione del bambino: e al tempo stesso, se passiamo a considerare quell’inezia che è lo stile, chi più di lui merita il titolo di scrittore? Stevenson è oggettivo perché è soggettivo, è magnanimo perché è autistico, è epico perché è autocentrato, ha una fantasia inesauribile perché parla solo di sé, perché sa parlare solo di sé e perché vuole parlare solo di sé. Lo stesso vale per Conrad e per Céline, scrittori così diversi eppure così simili nella loro coerenza, nella loro felice monomania, nella loro provvidenziale presunzione di essere un mondo. Accettando questo mondo, abbiamo immediatamente l’impressione di entrare in un paesaggio esotico: le nevi di London come le nenie di Gombrowicz, l’animismo di Guimarães Rosa come le teleogie bibliografiche di Borges, gli asteroidi di Saint-Exupéry come i mostriciattoli di Hoffmann, tutto è ludicamente avventuroso perché tutto partecipa di un’energia resa condivisibile dalla forma, una forma alchemica che della debolezza psichica dell’autore ha tratto il suo stesso sfarzo. La letteratura in questo senso è lusso ed è vendetta, e soprattutto non inganna mai: perché ci costringe a credere solo quello che crede l’autore, e nessun autore, come nessun uomo, crede in qualcosa come alle proprie passioni, alle proprie idiosincrasie e alle proprie ossessioni.
***
Cooper
Rileggere L’ultimo dei Mohicani parecchi anni dopo l’entusiasmo delle letture infantili (la traduzione è sempre quella storica di Fernanda Pivano) può essere un’esperienza sconcertante. La convenzionalità dei personaggi (specie di quelli femminili), la meccanicità delle trame, l’abnorme prolissità nei dialoghi e nelle descrizioni sono limiti che nessun lettore educato può trascurare, e che giustificano l’insofferenza con cui quasi tutti gli scrittori contemporanei dotati di un alto senso della forma, da Poe a Twain, hanno parlato di Cooper. Certo da questo punto di vista egli è un “minore”, e non sarà l’impressionante mole della sua produzione (un centinaio di libri) ad accorciare l’immensa distanza che lo separa da un narratore d’avventura altrettanto popolare ma di ben altro talento come Jack London. Probabilmente ha ragione Leslie Fiedler quando riconduce il successo di Cooper non a particolari meriti letterarî ma all’istintiva capacità di dar corpo «ai miti di fondo della vita americana»: la frontiera, la lotta per la sopravvivenza, la wilderness, l’orgoglioso e insieme sgomento distacco dal vecchio mondo.
L’ultimo dei Mohicani (1826) appartiene a un ciclo di cinque romanzi scritti nell’arco di diciott’anni (da I pionieri, del 1823, a Sterminatore di daini, del 1841): intuendo che il destino letterario del mito è l’epopea, Cooper aveva infatti capito che un solo libro non sarebbe stato sufficiente per incarnare memorabilmente quegli archetipi. E come Ulisse è un guerriero fiorente nell’Iliade e un uomo maturo nell’Odissea, così in ognuno dei cinque romanzi il protagonista, Natty Bumppo, ha un’età diversa: questo non solo consente le citazioni interne che collegano le cinque storie come scatole cinesi, ma anche regala ad ogni avventura la dimensione della memoria, una memoria che estendendosi oltre i confini convenzionali del singolo libro risulta illusoriamente “oggettiva” e quindi, appunto, epica. Del resto, cos’altro sono i numerosi soprannomi di Bumppo, da Leatherstocking (“Calza di cuoio”, reso però dalla Pivano con «Occhio di falco») a La longue carabine a Deerslayer (“Sterminatore di daini”) a Pathfinder (“Scopritore di sentieri”) se non il corrispettivo moderno degli epiteti omerici? (Così Uncas, «l’ultimo dei Mohicani», è anche Le cerf agile, «il Delaware», «il Figlio del Sagamore»; così gli odiati Irochesi sono anche gli Uroni, i Mingo, i Maqua, in una moltiplicazione onomastica che fa della prosa di Cooper il teatro di un ricchissimo gioco combinatorio). E sarà solo un caso se, come l’Iliade termina con il rogo funebre di Ettore, L’ultimo dei Mohicani si chiude con le esequie di Cora e di Uncas? Chi ancora avesse dei dubbî legga le citazioni che Cooper appose ad ogni capitolo a mo’ di epigrafe: scoprirà che la fonte più sfruttata, insieme a Shakespeare, è la versione dell’Iliade di Alexander Pope.
Stando così le cose, ne consegue che il romanzo tanto più è convincente quanto più l’autore si abbandona a una fantasia barbara, indulgendo a rappresentazioni di estrema efferatezza (una lezione appresa da Cormac McCarthy come da nessuno): sì che tutta la nostra gratitudine di lettori va al perfido Magua dai lineamenti «malevoli, biechi e feroci» e dagli occhi lampeggianti «come quelli favolosi del basilisco», capo di una banda di indiani che dopo ogni spargimento di sangue «si inginocchiano a terra e bevono abbondantemente, diabolicamente esultando, dal mare purpureo», e che con i loro «riti infernali» (paragonabili a quelli dei Thugs salgariani) sono la più potente incarnazione della wilderness. Si legga L’ultimo dei Mohicani con ingenuità fanciullesca o con la più scaltrita consapevolezza, si dovrà ammettere che fra tanti personaggi animati da nobili sentimenti è solo lui, Magua, a tenere in piedi la narrazione, e a conferirle il suo senso più vero: non esserci avventura che non sia attraversamento della morte, non darsi ritorno alle origini che non sia doloroso.
—-
da Michele Mari, I demoni e la pasta sfoglia, Quiritta, Roma 2004, pp. 476, ? 19,00
Semplicemente meraviglioso, e grazie per Cormac McCarthy!
Però è anànke, non ananké. Non lo direi se nel pezzo di Mari non ci fosse una etimologizzazione continua, intelligente e divorante.
Una parentesi: questa specie di coazione a trasformare le ossitone in parossitone è stranissima, e contagia solo intellettuali di rango. Sia Gianni Bonina che Piero Sorrentino, su “Stilos”, hanno ripetutamente scritto techné per téchne. Mi sto domandando, seriamente e senza un briciolo di ironia (nessuno dei nomi citati la merita, anzi!) se questo non significhi qualcosa.
mi sembra un esempio tipico di ipercorrezione: téchne, anànke sono le pronunce (o grafie) “comuni”, per cui inconsciamente il parlante/scrivente è portato a correggere (ad “alzare”) in techné, ananké, percepite come più rare e preziose, per adeguarsi ad un fantomatico standard culturale elevato.
è un fenomeno molto studiato in sociolinguistica – facilmente incrociabile con la psicanalisi – e tipico, peraltro, dei ceti colti. di solito lo si osserva meglio nella lingua parlata che in quella scritta, il che rende doppiamente interessanti gli esempi rilevati da montanari.
Sgrunt! :-)
(Il libro di Mari sembra proprio succoso, e il Mari saggista è ancora meglio del narratore)
Ne approfitto per chiedere: c’è qualcuno di questa nazione che ha la pazienza di segnalarmi qualche lettura davvero “fondamentale”?
Mi sembrano parole “definitive”, che fanno piazza pulita del bla-bla su inesistenti conflitti tra realismo, ovviamente penitenziale, e stile, inevitabilmente inautentico. Avendo stampato il pezzo, ho cominciato a sottolineare i passi “buoni e giusti” e ho finito per inchiostrare tutto.
A proposito delle ossessioni di Gadda, tutto da riconsiderare sarebbe il suo “Eros e Priapo”, il più bel libro “politico” italiano, la madre di tutti i pamphlet. Di una biliosità da ridurre Celine, col suo “povero” turpiloquio, a un boy scout piagnucoloso. Si potrebbe prenderlo per un libello antifascista, come se Gadda, in nome di chissà quale classe volesse attaccare un sistema socioeconomico, “un” preciso regime. E’ tutt’altro, naturalmente. E’ l’erompere delle sue idiosincrasie (misoginia ma anche insofferenza per il machismo, odio per i generali e per ogni cialtroneria – degli alti ufficiali ma anche di tanti altri italiani) solo apparentemente indirizzate a Mussolini. In realtà ce l’ha con l’utero delle Italiane.
A ognuno le sue ossessioni. E la sua valigia di trucchi, occorrerebbe aggiungere citando Borges, che si rassegnava, avendo raggiunto l’età del disincanto, a non poterne acquisire altre, di valigie. I migliori scrittori sono autori di un solo libro. Essere “autori di un solo libro” è stato spesso usato come un insulto (Amoruso contro Kerouac, ad esempio). Ma uno scrittore non sceglie i suoi temi, né può forzare più di tanto la sua “voce”. Se il talento fa quel che vuole, il genio solo ciò che può (C.B.).
A proposito di incarnazione della wilderness, trovo che l’interpretazione di Magua nel recente film omonimo costituisca uno dei rari esempi in cui la rappresentazione immaginaria del lettore non viene mortificata dalla banalità, dalla “restrittività”, del volto di un attore.