El boligrafo boliviano 4
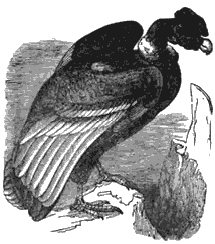 di Silvio Mignano
di Silvio Mignano
12 febbraio 2007
San Francisco si trova in un angolo di una grande piazza irregolare, tra le ultime rampe del Prado, disordinate e rigurgitanti di folla, e uno spiazzo usato indifferentemente per i comizi, i concerti, lo struscio e i piccoli traffici. Un cinema semidistrutto, negozi di fotografie, polli allo spiedo, brutte case, lustrascarpe e la montagna che in quel punto è brulla di polvere e in quel punto cambia rotta e comincia a salire ripidamente. Per noi europei è come se mancasse qualcosa, forse la piazza avrebbe bisogno di un quarto lato, una quinta che resta vuota.
San Francisco è bella, a modo suo. Il campanile coloniale, con due ordini di monofore e una cupola a ogiva, è allo stesso tempo tozzo ed enorme, alto ma soprattutto largo il doppio della chiesa. Nella facciata il sincretismo ha vinto un’altra delle sue tante battaglie. Il santo di bronzo apre le braccia al creato (Laudato sie, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fior et herba) in una nicchia persa tra colonne, cornicioni e timpani fittamente e finemente istoriati con l’intervento di oggetti, figure e personaggi del misterioso mondo di prima, quello che gli Incas avevano nascosto ai conquistadores e i Tiwanaku, i Quechua e gli Aymara avevano nascosto agli Incas, ma che gli uni e gli altri devono essere riusciti a commissionare agli anonimi scalpellini, sotto il naso delle autorità religiose. Fiori, serpenti, arpie e draghi si affacciano tranquilli dall’alto, senza fretta di imporsi. È questo il segreto che ha permesso loro di resistere alle conquiste: non urlano, non esibiscono colori brillanti o forme spettacolari. Se non vogliamo vederli, continueremo a passeggiare sul sagrato percependo solo complessi e gradevoli arabeschi incisi sulla pietra. Se proprio siamo interessati, alziamo lo sguardo, arrampichiamoci idealmente sulla facciata e allibiamo.
Se la Cattedrale, in plaza Murillo, seria e severa, è la chiesa delle classi colte e di potere, San Francisco è la più amata dal popolo. All’interno l’intelligenza cede il passo e non riesce a trovare definizioni: pieno e vuoto, caldo e freddo, luce o buio. Tre navate alte, immense, sovrastrutture senza uno stile determinato sul barocco meticcio, ori, tessuti, colori e candele: eppure ci si sperde. Brusio, fedeli in ginocchio, parole e preghiere: eppure ci si sente soli. Luci elettriche, lampadari e fiammelle, eppure sembra di essere immersi in un’oscurità che cela le distanze e confonde i rumori, come se qualcuno ci stesse chiamando da lontano e faticassimo a capire dov’è, e il grido può diventare sommesso bisbiglio.
Poi comprendo: dovunque mi giri vedo decine di statue di santi, colorate, come cere a grandezza naturale di una madame Tussaud, affacciate a balconi illuminati sulle pareti laterali, su quelle che dividono le navate, lungo il transetto, con i loro vestiti in vera stoffa. Sei, sette, otto finestroni l’uno accanto all’altro, l’uno sopra l’altro, a dieci metri di altezza, rischiarati da lampadine accese, con questi uomini e donne quasi in carne ed ossa che mi guardano e sembrano commentare tra loro. Ci sono molti più pulpiti di quanti ne abbia mai visti prima, due grandi di pietra istoriata nella classica posizione quasi all’entrata del transetto, altri più semplici, ai lati della navata centrale, e non sono vuoti, in attesa che un predicatore vi salga, ma occupati da altri santi, assisi su tanti piedistalli.
Ecco che cos’è che mi viene in mente: un teatro. Mi trovo nella platea di un teatro, al buio, e sono circondato da decine di loggioni illuminati, e gli spettatori guardano in basso, mi osservano e probabilmente parlano di me, nel segreto della chiesa meticcia di San Francisco, La Paz, Bolivia.
Lo stesso giorno
Chissà se la chiesa e i suoi abitanti sono proprio come li ho descritti o se invece sono io che li ho sognati. Devo tornare a controllare.
A pochi metri ci sono las brujas, il mercato delle streghe. Non è un posto definito, uno spazio deputato alla compravendita, ma nemmeno un luogo segreto. È un’area incerta tra le vie Sagánaga e Linares, alle spalle della piazza ma almeno cento metri più su, come sempre dovrà accadere in questa città rovesciata. Si percorre un vicolo che ricorda un San Gregorio Armeno in ripida ascesa, la stessa folla, lo stesso luccichio tremolante nell’opalino dell’ora che segue il tramonto. Ai due lati porticine aperte, ricoperte di tessuti andini, mantelli di lama e alpaca, sfondi rugginosi su cui sono ordite strisce bianche, nere e verde vescica, reticolati, spine di pesce, losanghe e uccelli stilizzati che gridano dal tempo dimenticato.
Un corridoio interno dà su due file di botteghe aperte sul davanti, sotto un solo tetto comune. All’ingresso, a sinistra, una ragazza siede tra stoffe e cuscini e fa poco per nascondere la sua profonda noia. Un’altra, di fronte a lei sulla destra, osserva impotente la sua bimba di due anni che non smette di piangere. La piccola, coperta da un cappotto e un cappuccio di lana, continua a gridare e singhiozzare disperata, rossa in viso, congestionata. Chiedo alla madre che cos’abbia, se sia sonno o fame (spero che non si tratti d’altro). Lei sorride senza rispondermi, poi si alza e scompare nel budello, dove la solidarietà degli altri venditori fa materializzare un bricco di latte o qualcos’altro di caldo.
Una vecchia mi prega di aiutarla a staccare una borsa di pelle da un gancio dove non arriva, nonostante sia montata su una pila di stoffe ripiegate. Mi assume, le propongo consegnandole l’oggetto. Eh, figlio mio, risponde, il problema è che mi sa che poi dovrei pagarti uno stipendio, e come faccio? Invece mi riempie di minuscole marionette di lana filata a mano. Si infilano sulle dita, come falangi di un guanto, e rappresentano lama, condor, orsi, vacche e contadini, curati nei minimi dettagli. Cerco di pagarla, ma lei quasi mi caccia via a spintoni.
Un altro vano senza battenti conduce a un corridoio stretto e da questo a un cortile interno insospettabilmente arioso – ancora Napoli? L’Avana? – sul quale si affacciano botteghe tutte uguali e allo stesso tempo diverse, come possono essere diversi dei gemelli, per qualcosa che non ci sfugge ma che non sappiamo descrivere razionalmente. Sono ormai le nove di sera ma è tutto ancora aperto, illuminato e pieno di gente. Quasi tutti boliviani, pochi turisti e stranieri, e questa è una netta differenza rispetto a Cuba o a Napoli. Anche i prezzi sono decisamente bassi, appropriati all’economia locale. Questo posto è stravagante come i meandri di un sogno. Salgo una ripida scaletta a chiocciola di metallo e mi trovo al piano di sopra, ballatoi con altri negozietti, un nuovo corridoio, una porta e sono in strada, la stessa di poco fa ma dieci o quindici metri più su, dopo aver attraversato l’edificio in verticale e non in orizzontale. La Paz di Escher.
Fuori, sul marciapiede, una fila di bancarelle sghimbesce dove si espongono immagini e oggetti dei riti che mi verrebbe di definire precolombiani ma che non sono tali, se è vero che sopravvivono ancora oggi – e come sempre, come quando all’Avana mi invitavano con fare circospetto alla cerimonia di affiliazione a un orisha, finisco per chiedermi quanto vi sia di reale credenza e quanto non sia semplice e legittimo attaccamento cerebrale alle proprie origini culturali.
Una signora mi offre una statuetta di pietra. È la pachamama, vedi?, mi dice. Sono confuso. Non più di poche ore fa un poliziotto della nostra scorta mi ha garantito che la pachamama non si può raffigurare. Ella è tutto e dappertutto. La venditrice nega, difende la sua mercanzia, dice che si tratta forse di diverse interpretazioni, come dire, diverse scuole di pensiero, e a sostegno della sua tesi mi cita i due quadri coloniali di Potosí e del museo de La Paz che rappresentano la pachamama sincretizzata con la Vergine e trasfigurata nel Cerro Rico. Soppeso la scultura e pago gli otto boliviani, deciso a non pensarci più. Alle mie spalle, sugli scaffali sbilenchi di legno grezzo, due occhi enormi mi guardano – non è così, perché sono occhi chiusi o mai aperti, dalle palpebre sigillate da una cispa secca, biancastra, esistenziale.
Sono teste grosse, lanuginose, come di enormi implumi caduti dal nido. Attaccati ai crani colli lunghi ed esili, corpi secchi prima che disseccati, macabri manici d’ombrello, non è chiaro se bipedi o quadrupedi, gli arti anteriori aggricciati a uncino, quelli posteriori stirati a continuare il torso filiforme. Lama, dice la donna al mio orrore. Feti di lama, per caso ne vuoi uno? No, per carità, e per farne cosa? Se hai un terreno e pensi di costruire, non dimenticare di seppellire uno di questi nelle fondamenta, proteggerà la tua futura casa.
Ho bisogno di qualcosa che mi protegga adesso, questa notte, le rispondo, guardando oltre la schiena d’asino dell’acciottolato, oltre i tetti, oltre la massa oscura della roccia dove so, senza motivo, che da qualche parte l’Illimani sta aprendo le sue ali di condor innevato.
in foto è Jò Condor l’avvoltoio? se è così entro senza timore….
La Paz sarà la mia prossima meta!
La descrizione così ricercata delle architetture mi invita,
la nicchia persa tra colonne, i campanili, cattedrali e via dicendo,
quale delizia per gli occhi è più luminosa?
Mi è molto piaciuta l’espressione:
-luccichio tremolante nell’opalino dell’ora che segue il tramonto.-
e il finale è lungo brivido…
@Gianni
me lo fai volare questo condor?
voglio vederlo con le ali aperte!
:-)