Idillio Forsennato: Arno Schmidt
C’è una poesia di Günter Eich, poeta e drammaturgo tedesco tra i fondatori del Gruppo 47, che è considerata emblematica dell’istanza rifondatrice del linguaggio poetico della Trümmerliteratur, la «letteratura delle macerie» che si sviluppò in Germania nell’immediato dopoguerra. S’intitola Inventario e comincia così: «Questo è il mio berretto, / questo è il mio cappotto / qui la mia roba per fare la barba / nella borsa di lino». In una lingua semplice e scevra da patetismi, soltanto nominando i pochi resti personali, l’io lirico del soldato prigioniero ritesse le fila della propria esistenza nel mondo, fino a riaffermare la propria identità poetica: «La mina della matita / è ciò che amo di più: / di giorno mi scrive i versi / che ho pensato di notte».
Pur nell’unanime disorientamento, la poesia di Eich è forse il testo che più di ogni altro dovette prestarsi al parallelismo allorché nel 1951 Arno Schmidt, scrittore refrattario ai movimenti letterari e alle velleità pubbliche dell’engagement, già noto per i racconti cavati «dalla cassa di bile» del Leviatano (1949), pubblicò il suo secondo libro, che conteneva appunto l’avventura minima, appena oltre la soglia della sopravvivenza, di un reduce e scrittore alle prese con la ricostruzione di un proprio, individualissimo spazio vitale. Schmidt, tuttavia, non era annoverabile nel panorama nazionale della letteratura tedesca postbellica se non a prezzo di un pesante sacrificio della complessità e della forza innovativa della sua prosa, e il fatto che si sia dovuto aspettare qualche decennio perché alla sua opera si rendesse giustizia editoriale anche oltre i confini dell’area tedescofona, riconoscendone a tutti gli effetti il valore nel più ampio contesto della Weltliteratur, non è che l’ironica conferma del suo lungimirante ingegno artistico.
In Italia, dopo la «discontinua fortuna» di cui già rese conto a suo tempo su queste stesse pagine Stefano Gallerani, l’onore al merito spetta all’editore Lavieri di Caserta e a Domenico Pinto, giovane e talentuoso traduttore di Schmidt, il quale proprio lo scorso 21 febbraio a Roma, presso il Goethe Institut di via Savoia, è stato insignito del neonato Premio italo-tedesco per la traduzione letteraria. Il libro che ha valso a Pinto il prestigioso riconoscimento è Dalla vita di un fauno (Lavieri 2006), romanzo breve che uscì in Germania nel 1953 e che dieci anni dopo Schmidt avrebbe raccolto in volume con altre due opere simili nella forma e nello stile, scritte subito prima del Fauno, nella trilogia Nobodaddy’s Kinder (Figli di «Babbonemo», se si sta alla versione di Ungaretti, che tradusse così l’omonima invocazione in versi di William Blake al dio padre che non c’è). Ebbene, l’opera che costituisce il tassello mediano della trilogia, tra il Fauno e la distopia post-atomica di Schwarze Spiegel (Specchi neri), è precisamente la storia del reduce e scrittore citata più sopra: s’intitola Brand’s Haide e la sua traduzione in italiano («Arno», Lavieri 2007, pp. 128, € 13,50) è il più recente servizio reso da Pinto a Schmidt nella collana che prende il suo nome.
L’intreccio è semplice: nella Germania occupata dagli alleati, il protagonista Schmidt, ex-prigioniero di guerra, giunge in «abiti sbrendolati» e con un misero bagaglio a Blakenhof, un piccolo centro rurale della Bassa Sassonia, dov’è albergato in uno «stambugio» presso l’insegnante della scuola locale. Il suo obiettivo di scrittore è quello di esaminare i registri parrocchiali alla ricerca di notizie su Friedrich de la Motte Fouqué, l’autore romantico alla cui biografia sta lavorando; le sue energie, tuttavia, sono assorbite in gran parte dalla cura dei beni di prima necessità, che egli condivide con le due giovani coinquiline Grete e Lore, e dalla passione che si accende tra lui e quest’ultima. Si tratterà però di un amore di breve durata, perché Lore finirà per scegliere più o meno a malincuore chi potrà garantirle una maggiore sicurezza materiale. Anche a prescindere dall’omonimia di autore e personaggio, i prestiti autobiografici sono diversi: dall’esperienza bellica all’ambientazione della storia in quella Brughiera di Luneburgo dove Schmidt visse la maggior parte dei suoi anni adulti, dal suo amore per Fouqué all’affetto riconoscente per la sorella Lucy Kiesler, che entra con nome e cognome nel romanzo come colei che dall’America invia ai «sopravvissuti» i beni introvabili da consumare o barattare in una Germania vessata dalla penuria. Ma non è certo in questi spunti personali il vero valore del libro, in ciò assai lontano da qualsivoglia intento testimoniale, né questo primo livello “storico” del romanzo basta da solo a svelarne il senso. La forza e l’originalità dell’opera stanno invece, innanzitutto, nella sua fattura poetica: quella che nell’introduzione al Fauno Pinto aveva chiamato la «prosa intermittente» di Schmidt, fatta di brevi paragrafi indipendenti, governati da un’interpunzione alterata ad hoc e giustapposti l’uno all’altro ad assemblare una vicenda cui è negato ogni respiro epico, si presenta anche qui come una forma perfettamente funzionale a restituire il mosaico esistenziale di un io frammentato, il cui sguardo allergico e visionario è l’unico punto di vista sul mondo concesso da una narrazione che ha definitivamente revocato l’onniscienza. L’espressionismo che ne sortisce è uno stile ambizioso, un realismo paradossale che, mentre rispecchia e somatizza le condizioni storiche e culturali dell’epoca («prosa atomica nell’età della fisica» la definisce ancora Pinto), permette a Schmidt di rivelarsi un inimitabile poeta dell’idillio forsennato: «Presso il kraal d’argento della luna stava raccoccolato un astro giallo leone, boscimano. I nostri miseri abiti da profughi volavano, divinamente drappeggiati dal vento; giù per il sentiero nero della chiesa, tutti i cristiani riposavano alloppiati nel chiuso delle loro stanze : libertà, libertà : con le mani incatenate saltammo sulla strada per Blakenhof. – «Lore» : pose subito gli avambracci sulle mie spalle, oh Nymphe Cannae, barbugliammo e ficcammo lo sguardo più a fondo dentro i visi tersi, a fondo dentro la notte. Noi, lumi degli occhi.»
Una prosa del genere, solo apparentemente ardua, inizia a entusiasmare una volta inteso, a dispetto della pedanteria di certi “schmidtologi”, che per leggere Arno Schmidt non serve essere Arno Schmidt e neppure assomigliargli il più possibile. È sufficiente invece attivare quella disposizione allo sforzo che tanta merce editoriale non richiede, ma che ogni grande autore invoca ancora e sempre per essere gustato e compreso. Nel caso di Brand’s Haide, poi, il cimento è ampiamente ripagato dallo svelarsi progressivo di un senso che, di primo acchito, rimane cifrato nel dialogo oscuro tra il verismo soggettivo della narrazione “storica”, già di per sé atomizzata, e gli inserti “documentari” che a cadenza irregolare ne spezzano ulteriormente il corso. Il fatto è che questi “documenti” – siano essi registrazioni fedeli dei sogni di Schmidt, citazioni dai registri parrocchiali in cui risalti una collettività prigioniera della superstizione e soggiogata dagli archetipi o excerpta dell’opera di Fouqué che aprono squarci su medioevi fantastici popolati di eroi e spiriti –, disposti come sono in contrappunto a un racconto di miseria e sopravvivenza, anziché comprovarne la veridicità hanno l’effetto di aprirlo a una dimensione “altra” e persino utopica: la sola, in fin dei conti, a tener viva nel personaggio la duplice fiamma della coscienza e della poesia.
(Questa recensione è apparsa su «Alias» del 1 marzo 2008.)
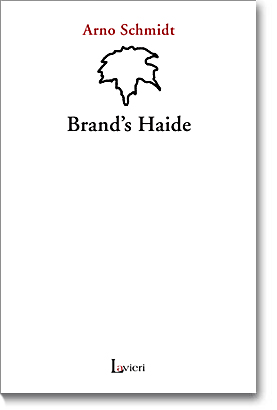
Bello, si impara molto così (allora Domenico è stato un buon acquisto davvero!:-) ); mi spieghi il titolo? E’ il nome di un posto? a.
“una lingua semplice e scevra da patetismi, soltanto nominando i pochi resti personali, l’io lirico del soldato prigioniero ritesse le fila della propria esistenza nel mondo…
ottimo pensiero!
ciao :-)
Molto bello. Mi sono già innamorato di Schmidt da queste poche righe. E anche della traduzione, invero…
A furia di cornate (e in NI siamo in tanti, per fortuna, ad avere la testa dura), c’è da sperare che finalmente la kultura italiana si renda conto di avere a che fare, qui, con uno dei fari del 900, in traduzioni a dir poco magistrali.
Gran bel pezzo Stefano, complimenti.
Sì Sparz, Brand’s Haide è la località nella Brughiera di Luneburgo dove è ambientata la vicenda.
Grazie Andrea, sottoscrivo la prima parte del tuo commento.
Premetto che non ho letto il libro, anzi non l’ho punto (.) Su google ho trovato
http://nona.net/features/map/placedetail.518764/Weißkeißel/
da cui parrebbe che Haide e Brand sono due frazioni: perché allora quell’*’s*? una frazione ha fratto l’altra?
Più in generale, prima di comprarlo, chiedo: il libro è come il titolo, o è tradotto?
E più in particolare avverto: tante incornate sì, ma non saranno certo le ultime.
Brand’s Haide è il titolo originale, ma all’interno del romanzo il toponimo è presente anche come Brands-Haide, il diavolo sa perché.
In ogni caso, che io sappia, vari luoghi della topografia schmidtiana oggi – voglio dire ufficialmente – non si chiamano più così.
Sì, e appare anche *brandshaide (dio sa perché. Comunque ho conservato le oscillazioni grafiche). Si tratta di una foresta (‘la foresta dalla fama cattiva’), il cui nome avevo scelto di non tradurre, così come compare nei disegni cartografici dell’autore. Il titolo, però, è anfibologico, forse vi è celato il nome *Huldbrand, un protagonista dell’Ondina di Fouqué, figura che potrebbe essere alla base del contadino, o spirito elementare, che accompagna il poeta-personaggio Schmidt attraverso il romanzo.