“Forse Esther” di Katja Petrowskaja
di Ornella Tajani
«[…] E io pensai che fosse stato il charleston a far tornare in mente a Rosa Trockij e la sua mucca: in punta di piedi lei s’addentrava ballando nella storia universale». È in punta di piedi e con una splendida grazia narrativa che Katja Petrowskaja entra nella storia del Novecento e compone un mosaico di vicende storiche e frammenti autobiografici, un tappeto della memoria intessuto di documenti d’archivio, ricordi personali e alcune fotografie in bianco e nero, che sin dalle pagine iniziali richiama il Sebald di Austerlitz.
Forse Esther (Adelphi, trad. di Ada Vigliani) è il primo romanzo dell’autrice e giornalista, nata a Kiev nel 1970 e trapiantata a Berlino. Il tedesco, imparato alle soglie dei trent’anni «a suo rischio e pericolo», è la lingua che Petrowskaja adotta per la scrittura, la «lingua del nemico» che rappresenta al contempo una via di fuga, un amore inesauribile e un modo solo apparentemente illogico per riallacciarsi alle proprie radici, quasi come una «bacchetta del rabdomante». La genealogia tentacolare della famiglia sovietica in cui l’autrice cresce è un crocevia delle culture russa, ucraina, tedesca ed ebraica: è per questo che l’indagine intrapresa alla ricerca dei suoi avi non può che essere anche una ricostruzione storica composita, un viaggio attraverso Germania, Russia, Polonia e Austria, fino a quei luoghi bui dell’anima che gulag e lager sono per ogni europeo.
L’indagine e l’attenzione alla lingua come strumento d’analisi sono condensati già nel dubbio onomastico del titolo: Esther è forse il nome di una bisnonna mai conosciuta dall’autrice; suo padre tuttavia non ne è certo perché l’ha sempre chiamata semplicemente«babuška». Accanto a Esther, però, Petrowskaja traccia i ritratti di vari membri di una famiglia in cui «c’era di tutto. Un contadino, parecchi insegnanti, un agente provocatore, un fisico e un poeta. Un rivoluzionario e un eroe di guerra, ma in particolare c’erano leggende». Gli insegnanti sono perlopiù logopedisti e forse è proprio da loro che l’autrice ha ereditato un legame viscerale con la lingua («per gli ebrei la parola è tutto»). D’altronde per gli scrittori le cui radici si snodano attraverso diversi paesi è naturale che la narrazione di sé si accompagni a una intensa riflessione linguistica, come se alcune tracce del vissuto si nascondessero fra le parole usate, in modi di dire dimenticati e recuperati che vanno a costituire un Erlebnis polifonico; si pensi, ad esempio, al complesso rapporto con il russo che Emmanuel Carrère dimostra di avere in Un roman russe, altro romanzo che è un viaggio verso le proprie origini, nel quale la difficoltà di ricordare la lingua imparata da bambino è un’eco della confusione in cui è avvolto il passato.
È questo legame che porta Petrowskaja a farle notare come, nei pressi della chiesa di San Cirillo a Kiev, non lontano da dove ebbe luogo il massacro di Babij Jar, una targa reciti «Anche qui nel 1941 furono fucilati degli uomini»: le tombe non autorizzate si riconoscono da una congiunzione. O che le fa sottolineare come, in quello stesso anno, i manifesti che richiamavano all’adunanza si rivolgessero a «tutti» gli ebrei in russo, e a «tutti senza eccezione alcuna» in tedesco, quasi che nella traduzione si fosse perso un grano di enfasi omicida.
Così ogni movimento, ogni «andò» diventa epico. La babuška Rosa, Esther, poi il nonno che fu fatto prigioniero e tornò dai gulag dopo quarant’anni, e il misterioso prozio Judas Stern, processato nel ‘32 in seguito al tentato omicidio di un diplomatico tedesco: questi lontani parenti, magnifici personaggi, danzano nella mente dell’autrice «al ritmo della storia universale», mentre lei prova a tenere i fili di ogni vita al fine di visualizzare un centro, capire qual è il suo posto all’interno della narrazione. Per tessere la sua tela Petrowskaja si avvale degli strumenti più vari: Google, miti greci, fiabe tradizionali, contatti Facebook, letture assortite, tra cui Thomas Bernhard; tutto diventa «materiale storico» che per lei somiglia a «velluto, raso, crêpe de Chine». Ma allora dov’è il centro? Che sia quel ficus al quale sostiene di dovere la vita, un ficus che appare d’improvviso verso la fine del libro, abbandonato in mezzo a un marciapiede vuoto, sulle note di Šostakovič, e che, salvando la vita al padre, si trasforma per lei in una specie di angelo custode? Può darsi, ma in questo romanzo – il titolo era esplicito – la memoria è un fantasma intermittente: il padre non ricorda nessun ficus, così la pianta diventa per l’autrice un «oggetto letterario», o piuttosto un correlativo oggettivo della Storia.
Il viaggio che Petrowskaja compie travalica i confini temporali e geografici, lo dimostra un lapsus nelle ultime pagine: mentre l’autrice è diretta a Mauthausen, una passeggera del treno la saluta dicendole «Gute Weltreise!», Buon giro del mondo, invece di «Gute Weiterreise», Buon proseguimento. Di nuovo la lingua offre un indizio; «Così […] ha messo a nudo la mia megalomania», commenta l’autrice. Ma più probabilmente ciò che spinge alla ricerca ha origine non tanto dalla megalomania, quanto da un irriducibile istinto alla sopravvivenza: «Facciamo tutto nel tentativo di allontanare la morte a colpi di interpretazione, come se non si trattasse di scomparire, ma solo di accogliere e giungere alla meta». La meta non può che essere fantasmatica: nell’ultimo frammento una donna anziana e sconosciuta, avvolta dal candore, sparisce a un semaforo di Kiev, subito dopo aver sorriso all’autrice, lasciando un’epifania di luce a sigillare con mistero questo racconto bello e profondamente europeo.
Katja Petrowskaja
Forse Esther
(tit. or. Vielleicht Esther. Geschichten)
Traduzione di Ada Vigliani
Adelphi, 2014
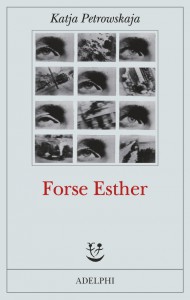
Questo è un libro che leggerò sicuramente, e ho il sospetto che lo amerò. Grazie per averlo recensito.