Tre montagne
di Matteo Meschiari
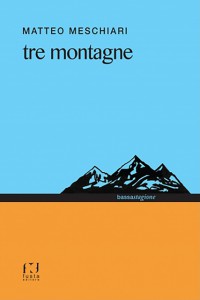 La donna e il cacciatore salirono a Ospitale, a Croce Arcana, svalicarono il crinale, scesero nelle regioni deserte ed entrarono nel castagneto. Il verde era liquido, i rovi sembravano alghe.
La donna e il cacciatore salirono a Ospitale, a Croce Arcana, svalicarono il crinale, scesero nelle regioni deserte ed entrarono nel castagneto. Il verde era liquido, i rovi sembravano alghe.
Sara vide Enrico e il cacciatore le disse, guarda, è lui, ecco, spogliati, sciogliti i vestiti, va’ da lui.
Sara sciolse i vestiti, ed Enrico giacque su di lei. Per ore rimase su di lei, e lei lo abbracciava con forza, non respingeva il suo ardore, gli regalava tutto quello che sapeva.
Il verde era liquido, i rovi sembravano alghe, il seno era nudo, i fianchi battevano come onde.
Quando Enrico fu sazio guardò indietro, sopra la spalla. I merli schioccavano lontani, i daini intimiditi si nascondevano, nessun animale era sceso. Il castagneto, stanco, era un ciuffo di alberi vuoti.
Enrico guardò sopra la spalla, vide i castagni, ma quelli che vide erano alberi senza valore, il verde non era liquido, la donna sotto di lui era burro, molle, come il mare a Livorno.
Si alzò, le gambe erano dure. Perché questo silenzio? La forza del bosco si era sciolta come brina. Cos’era questo silenzio?
Enrico guarda la Sara che comincia a vestirsi, vede la donna nell’erba, le chiede di parlare. La Sara gli parlò.
Chinati verso di me, ascolta. Perché ti ostini a cercarli? Vedi? Non tornano a bere con te. I merli schioccano lontano, i daini intimiditi hanno paura del tuo odore. Perché vuoi mangiare con loro? Sono bestie. Ecco, tu sei un uomo, devi mangiare con gli uomini. Senti questo pane, bevi il vino rosso che ti manda Guglielmo. Giù a Fanano, nel villaggio dalle mille stalle, c’è lui, c’è l’uomo migliore del mondo, è Guglielmo, è forte come un toro selvaggio, tutti lo vogliono con sé.
Enrico ascoltava come chi ascolta le lodi di una donna. La ascoltava, perché voleva un amico, cercava qualcuno che potesse capirlo.
Sentimi Sara, portami da lui, voglio battere quest’uomo, vengo dai boschi, ho bevuto con gli animali, a Fanano crescerà il convolvolo, le mura di pietra crolleranno.
La Sara sorride, lo prende per mano, lo prende e lo porta via dai crinali.
Enrico si chinò sulla donna, le chiese di parlare.
Chi è questo Guglielmo, che faccia ha? Cos’è Fanano dalle torri come pollai e dalle donne che ti stringono con vigore? Chi è questo Guglielmo che sta sveglio nei letti degli altri e profuma di vino e formaggio? Portami da lui, vedremo se è più forte di Enrico.
La Sara sorride, lo porta giù dal crinale, gli mostra l’intreccio delle valli.
Vedi quella costa laggiù? Laggiù c’è Ospitale. E laggiù, dietro quel monte? Laggiù c’è Fanano, e a Fanano Guglielmo. Non cercare di competere con lui, lui ti aspetta. Questa notte farà un sogno, ti sognerà mentre scendi dalle montagne, domani sarà fermo in piazza, è là che ti aspetta. Non competere con Guglielmo, nessuno è più forte di lui.
Le ombre si allungavano tra le nevi. I boschi e i campi in pendio erano viola e scuri nella sera. Un vento gelato aveva spinto le cime, increspandole come onde.
NdR: questo frammento, rappresentativo di quella che mi sembra essere la scrittura particolarissima e molto bella di “Tre Montagne”, di Matteo Meschiari, è tratto dal secondo racconto della raccolta, Primo Appennino – Canovaccio di Piazza, e precisamente da (delizioso già questo): Tavola Seconda, 9. La civiltà di Sara.
Il libro è il secondo volume della collana dell’editore Fusta “bassastagione”, curata da Marino Magliani (e Fernando Guglielmo Castanar). Chi apprezza la scrittura di Magliani può secondo me apprezzare con ogni probabilità anche quella di Matteo Meschiari.
Qui sotto riporto un passo della postfazione di Gian Luca Picconi (Un deserto di segni: proustfazione geoanarchica):
2. Tre montagne si presenta come un trittico di racconti. Nel primo, Svernamento, un vecchio – così chiamato per tutta la narrazione – si accinge a una arrampicata, tra ricordi, descrizioni, paesaggi e frammenti di un taccuino. Da subito va detto che in uno studioso di paesaggio come Meschiari, diversamente da quanto ci si potrebbe attendere, le descrizioni di paesaggio non vanno assolutamente nella direzione di frammenti e squarci lirici che inframmezzano l’azione, secondo la misura classica della descrizione di paesaggio nel romanzo ot-tocentesco e novecentesco. Piuttosto, gli elementi descrittivi mostrano una sorta di autonomia ed evidenza del paesaggio che trascende la funzionalità di corrispettivo o correlativo delle emozioni dei personaggi: il paesaggio è dato, deleuzianamente, come se fosse lui a guardare i personaggi, e non come se ne fosse guardato. La base stilistica è la terza persona di un narratore esterno, ma a momenti la voce precipita nella prima persona, e questa mescolanza di istanze di enunciazione sembra quasi realizzare un passaggio dalla rappresentazione di un soggetto forte alla costruzione di una soggettività diffusa, che si fa carico, attraverso le varie posizioni della voce, di realizzare una correlato oggettivo dell’io autoriale. Ma il paesaggio non fa parte di questo correlato oggettivo: anzi, vi si oppone quasi, in una sua autonoma e assoluta potenza di essere sfida l’uomo ad esistere, guardandolo da fuori.
Nel secondo testo, Primo appennino, sorta di oratorio teatrale, una riconoscibilissima riscrittura dell’epopea di Gilgamesh ambientata nell’Appennino modenese (di cui Meschiari è originario) fa muovere Gilgamesh ed Enkidu al tempo dei partigiani. La scelta della struttura teatrale sembra impiegata con il fine di creare un enunciatore collettivo, simboleggiato nella figura del coro, e superato dialetticamente o comunque sussunto dalla dinamica degli spazi della vicenda; la scelta del mito dovrebbe dimostrare come il funzionamento della mente umana si basi su una serie di invarianti: se ne desume che la mente dell’uomo è abitata e modellata dal paesaggio; è una mente che, direbbe Meschiari, «si fa paesaggio».
Il terzo racconto, Pace nella valle, narra un’uscita a caccia di un uomo e del padre. L’enunciazione slitta continuamente dalla prima singolare (dell’uomo, e del padre, in quanto narratore di secondo grado) alla prima plurale. C’è, dietro questa problematizzazione della voce che la variabilità delle istanze di enunciazione produce, l’idea di enunciatore complesso.
Un passaggio dall’individualità solitaria del primo dei racconti – sempre in procinto di cancellarsi, presentandosi alla lettura come già scomposta e diffratta – alla capacità di dire noi dell’ultimo racconto induce a credere che Meschiari abbia voluto mostrare la parabola di una narrazione come sorta di dispositivo epico di costruzione di un’identità collettiva e comunitaria, parzialmente mutuato, anche nell’uso della prima persona plurale – in una personale declinazione tragica, tuttavia – da autori come Atzeni, Maggiani, Chamoiseau, Derek Walcott. Ma si tratta forse di una parabola a ritroso: dal vecchio, agli uomini adulti, al bambino, il punto di partenza è il punto di arrivo e in tutte e tre le storie l’unico elemento con cui veramente fare i conti fino in fondo è la morte. La conquista del noi è una conquista tragica, o che si basa su una determinazione tragica. Il minimo e sobrio sogno/desiderio di comunità sociale che Meschiari affida alla narrazione è sempre destinato a infrangersi contro la dimensione della morte. La morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare, direbbe Benjamin: una lezione da Meschiari appresa nel profondo, e applicata di seguito anche alla vita in comune: epica dunque, ma secondo una sua formulazione potentemente tragica.
E per finire riprendo dal risvolto anche la biografia dell’autore:
Matteo Meschiari (Modena 1968) è autore di saggi e testi letterari. Professore di Antropologia e Geografia all’Università di Palermo, ha studiato il paesaggio in letteratura (in particolare Campana, Biamonti e la Linea ligustica) e svolge ricerche sullo spazio percepito e vissuto in ambito europeo ed extraeuropeo. Ha formulato la Landscape Mind Theory, con cui sostiene che la mente dell’uomo è geneticamente e culturalmente paesaggistica, e ha proposto nuovi modelli interpretativi per l’arte paleolitica franco-cantabrica. La Wilderness, la città e il camminare sono al centro della sua scrittura. Scrive regolarmente su pleistocity.blogspot.it.
Meschiari e Benozzo me li caldeggiò Ezio vent’anni fa e il loro “Imram” mi piacque, molto. Quasi esattamente dieci anni fa Ezio moriva sotto una slavina sul monte Crostis. Quest’articolo mi ha ricordato tutto ciò.