Le maschere dell’Impero nella poesia di Bruno di Pietro
di Daniele Ventre
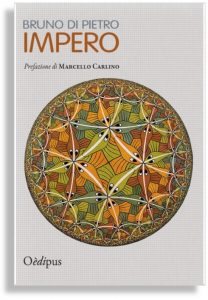
L’immagine dell’Impero Romano come metafora politica dell’Europa, quale compare nella nuova raccolta di Bruno Di Pietro (Impero, Oedipus, Salerno/Milano 2017), è connotata da una plurivoca unità tematica. Le molte voci che la compongono rappresentano a tutti i livelli le dramatis personae della società antica, riproposte in una dimensione lirico-narrativa connotata da un caratteristico trompe-l’oeil storico ed esistenziale.
In tal modo la poesia di Impero rappresenta “i chiaroscuri di chi ha governato” in antico “i luoghi più belli e civili della terra” come recitano i versi del Proemio con la loro più che evidente citazione gibboniana. A parlare sono, di volta in volta, sia gli attori primari della politica dell’Impero, cioè quei principi che con le loro bizzarrie e il loro modo più o meno deforme, più o meno equilibrato, di incarnare la sovranità popolano la memoria storica del mondo latino, sia personaggi più defilati o meno noti, quando non inventati (ma di un’invenzione quasi più verosimile del vero).
Con la loro luce ambigua, questi personaggi proiettano la loro immagine sul presente, contribuendo a costituire un sistema figurale atto a interpretarlo, sul piano culturale, politico, economico e giuridico (particolarmente caro all’autore quest’ultimo aspetto, data la sua formazione originaria). In tal modo, tappa dopo tappa, attraverso un percorso tramato di una necessità implicita, frammento per frammento, si delinea una mappa interrotta del vasto arco dell’ordinato impero, a valle della sua rovina storica, in cui come nota nella prefazione Marcello Carlino, “gli io narranti appaiono recare in sé la premonizione della fine, quasi che il loro sguardo abbia gli stigmi di una condizione postuma”.
Questi narratori, parti integrate di una costellazione di voci e di focalizzazioni, eppure di volta in volta portatori di singole infra-storie in sé concluse, divengono così, proprio per tale condizione postuma, voci profetiche: “Si indebita il popolo, si indebita Roma, l’impero cresce/ su un cuore d’argilla pulsante di debito/ di monete appena coniate e già inflazionate.// Fortunati i mercanti!”, un quadro in cui la correlazione fra debito ed economia, con l’oraziano compiacimento dei mercatores/traders, lascia ben intendere de quo fabula narratur; “Per risanare l’Impero servono tasse e lavoro/ (è bandito l’alloro)”, un fulmen in clausula in cui detona stridente, in una delle rime facili parcamente soffuse nel trompe-l’oreille dei versi solo apparentemente liberi, l’opposizione fra l’immagine mediatica del potere (l’alloro) e la sostanza e l’effetto dell’organizzazione politica (tasse e lavoro); “quale filiazione, quale adozione, quale legione/ l’Impero necessita di una Costituzione”, gnome in cui si condensa per contrasto la critica alle forme di dominio liquide, non formalizzate giuridicamente, dunque incontrollabili e non migliorabili, proprie dell’egemonia delocalizzata contemporanea. La cifra costitutiva delle fulgurazioni ideali che si materializzano in ciascuna delle maschere balenanti fra gli spazi bianchi di Impero, nell’assoluta semplicità e nudità della forma fisica che il libro assume, appare in buona sostanza l’enucleazione, dal cuore antico dell’Occidente, di quel che manca al costrutto sociale mondialistico contemporaneo per assestarsi in una durata storica degna di questo nome. La capacità di finalizzare la tassazione a un sistema gestionale che non sia mera predagione; la potenzialità del dominio di farsi diritto, e di assimilare e integrare pienamente una pluralità di etnie, tacitando la gratuità becera dei razzismi (“Ci pensi, Aboudat: un iberico e un ellenico!/ Siamo chiamati a costruire l’Impero/ (forse è questo il suo segreto/il suo mistero)” ) e dei fanatismi religiosi: tutte le molteplici sfaccettature di auctoritas e ius che l’imperium, al di là del suo centro geografico e della sua antropologia oppositiva fra civiltà e barbarie, al di là del crogiuolo di ferocia che lo origina, finisce per assumere; tutte le molteplici strutture costitutive di un ordine politico sovranazionale decente, o quanto meno responsabile, che mancano al tempo attuale e ai suoi poteri onnipervasivi e irresponsabili.
Ne risulta, espressa attraverso il dettato di una lingua semplice, venata di ironia e di ottimismo tragico, e volutamente estranea alle mode letterarie, una visione della storia che se non tocca propriamente l’ucronia o l’utopia, prefigura quantomeno una proposta di inquadramento dell’orizzonte culturale di cui la modernità liquida, nel suo buio denso, difetta; se ne ricava al contempo, per esemplificazione concreta più che per arida enunciazione critica, una proposta di poesia fortemente radicata nel senso forte della storia, pur fra la complessità degli slittamenti di prospettiva che la tecnica della maschera e dell’eteronimo, tipica da sempre dell’opera di Bruno di Pietro, di per sé stessa comporta.
______________
Da Bruno di Pietro, Impero, Oedipus, Salerno/Milano 2017 (pref. di Marcello Carlino).
V. Publio Quintilio Varo. Teutoburgo
“Lentamente il giorno è andato via
Ora dopo ora avanza la mia notte a Teutoburgo.
Nel novilunio il buio rimanda il buio
mentre il presagio della cometa s’invera
il disagio nelle parole di Segeste
Guardati dalla selva, guardati dalla belva germanica
oggi romana per convenienza
Piove e la palude ingoia se stessa
la luna è nella palude
non si distingue terra
non si distingue cielo
al di là del silenzio il precipizio.
Sono ai margini nell’interstizio
fra l’eco e il suo spegnersi
fra il suono e il suo svanire.
Nell’infanzia mi dicevano
che la sera la paura va a dormire
ma qui a Teutoburgo la paura non ha sonno.
Ho paura di avere paura.
Ora che devo combattere
scopro che non ne sono capace
vedo un arcano in me che mi sfuggiva.
Sarò l’imbelle, il responsabile, il perdente
ma quello che sta per accadere
è il compimento di quanto già scritto:
l’Europa romana è morta nei pugnali di Cassio e Bruto
né vi sarà mai una Germania latina:
altri percorreranno la via dell’ambra
dal Baltico all’Egeo”.
Così Publio Quintilio Varo
avvocato, generale improvvisato
perse la vita le aquile e le legioni
ma ebbe in dono dalla paura
il privilegio raro
di vedere in anticipo la sciagura.
* * *
XIII. Nerone
Al mio nome è legato il vilipendio
al mio nome è legato un incendio
che non ho mai appiccato
Se davvero lo avessi fatto
avrei distrutto tutto
sopra tutto questa idea dell’Impero
Spero di essere ricordato come artista
come l’Imperatore esteta
magari come poeta:
gli artisti devono pur avere qualche vizio
(così dicevo davanti al precipizio)
* * *
XLV. Gnosi
Eupsichio di Alessandria
cristiano dalla fede traballante
deciso a farsi gnostico approdò nell’Urbe.
Conobbe Valentino e lo sentì affermare
che Gesù non evacuava gli alimenti:
così che lui cominciò a non mangiare
pensando che la via della gnosi
fosse fatta di stenti.
Dopo meno di venti giorni
si diede fuoco al centro del Foro.
Nulla di grave gli era accaduto,
salvo il digiuno forzato,
né altro che lasciasse presagire tale gesto.
I più dicono avesse appena evacuato un testo
(quello di Ireneo, contro le eresie)