Tempimorti

di Filippo Polenchi (testo) e Andrea Biancalani (foto)
(#Ufficio, 2017) Ho sentito prima M. che sospirava. Un rilascio di aria veloce, rapidissimo epperò pieno di respiro, al colmo di una boccata d’ossigeno catturata nei polmoni e poi rimessa in libertà, alla svelta, perché forse aria già avvelenata, già corrotta dall’anidride carbonica che dovrebbe essere l’ultimo passaggio dell’atto. E invece no. Invece qui tutto t’avvelena. Mi rendo conto che tutti sospirano. Sospira M. come oggi, ma più di tutti sospiriamo io e E. Me ne sono reso conto da poco: E. sospira tantissimo, soprattutto quando cammina e quando sta seduta, quindi sospira praticamente per tutto il tempo che rimane in ufficio. A volte la sento mollare questi pacchetti d’energia sotto forma di respiro, tutta questa accelerazione quantica d’infelicità fin da qui, da questa stanza. C’è lei che sembra sempre così sola e che sospira. Inspira aria ed espira questo mix tossico di cose andate storte. Poi invece cammina qui, accanto a me, per contingenza, nel corridoio. Replica la stessa solenne liturgia nera. Non si sfugge dalla sua vita, dal suo appartamento solitario (lo immagino: non ci sono mai stato), dal suo pendolarismo cittadino e automobilistico, abbastanza irritante perché accumuli qualche minuto di ritardo ogni giorno: un paio di minuti al lunedì per una coda sul Piazzale, un paio il martedì per i lavori della tramvia eccetera eccetera. Dai suoi piccoli malori isolati e senza nessi, grappoli di sintomi senza significato e conseguenze, che però le fanno aumentare il ritardo mattutino. Mi sono sentita male, dice a volte, non spesso, ma talvolta sì. Non riesco a immaginarne una vita oltre a questo recinto di sospiri e di fastidi. Non riesco a vederla al cinema, con gli amici, a bere, a fare l’amore. Ora ha attaccato il telefono: una chiamata a una collega che lavora a distanza (beata lei), una conversazione cordiale, gentile, su aspetti legati a un singolo lavoro, ma insomma, quella che diremmo una telefonata tranquilla e quando ha attaccato, salutando la tipa di là dal telefono con un “ciao cara” ha sospirato. Non uscirà mai dai suoi sospiri. E anch’io sospiro. Lo faccio spesso, per rabbia. Il sospiro è il lamento, il lamento è vento biblico di impossibilità ad agire. O sospirando si agisce?

(#In coda, 2019) In auto, per andare a lavoro: grande anello di auto imbottigliate intorno. I soliti paesaggi di vegetazione disfatta, cementizia, indistinguibile. Case e villette costruite su questa porzione di Chiantigiana che è trafficatissima. Qualche volta, soprattutto negli anni scorsi e in inverno, ho percorso questa strada a piedi, per andare a lavoro (30 minuti da casa), ma è un percorso pericoloso, senza marciapiede, senza protezione, affogato nel gas di scarico delle auto. È un tragitto che fa ammalare ai polmoni. Ci sono case arroccate contro la massicciata del raccordo autostradale che passa proprio qui sopra, che designa dunque uno spazio-di-sotto con manifesti teatrali di spettacoli sfranti e disperati, stratificazioni di carta e colla, volti di attori ormai bolliti che si rincorrono nei teatri di provincia (Firenze è tutta provincia) per darsi un’ultima occasione di rilancio – faranno battere le mani a un pubblico anch’esso sfinito dall’inedia e dall’abitudine a ricevere il Nulla – ma anche cassonetti divelti, detriti di ogni genere, l’onda di comparsa-e-scomparsa delle siringhe per terra, un materasso mezzo bruciacchiato, sassi e resti di cemento sgretolato dalle colonne del viadotto: e quella casa che apre la finestra proprio sulla strada. Chi viene prima? La casa o la strada? Poco importa, per chi apre la finestra, fa entrare CO2 fra le stanze, espone le coperte della notte all’aria velenosa, poi le ritira, le rimette nel letto, ci dorme, le respira nottetempo. Questo paesaggio non lo capisco: è una giungla; liane e alberi infestanti, verde scuro, spugnosi, appiccicosi. C’è poco da capire: è così e basta, disordinato e rampicante, così proliferante che mi sembra una buona approssimazione dell’angoscia che si prova nei sogni, quando non si riesce a divincolarsi dalla prigionia di una stanchezza ottusa. C’è apparente vitalismo in questa vita che si riproduce incessantemente. È il selvaggio? È terzo paesaggio, biodiversità, dovrei amarla, rispettarla. Osservarla in maniera empatica, ma non ci riesco. Su Novaradio, al mattino, ascolto sempre un programma di musica soul. Non danno mai notizie, al contrario delle altre emittenti, solo musica soul. È una scelta de-responsabilizzante, forse, sebbene il momento delle news sia solo rimandato di poco. Adoro, però, ascoltare Otis al mattino: quando lo passano alzo il volume. Ma non stamani. Stamani non trasmettono niente che riconosca.

(#Area di sosta Q8, 2019) Ho fatto pausa pranzo, come spesso il venerdì, in auto: sportello aperto, gamba sul telaio del finestrino, all’ombra del cubo di cemento, ora vuoto, che ospitava prima il bar Luisa poi il bar Arcangeli e ora, appunto, niente. La successione ereditaria di quei bar è un romanzo naturalistico. Ora attraverso le pareti della zona-pranzo del bar, che sono tendoni di nylon trasparenti, ma sporchi perché da un anno e mezzo nessuno li pulisce, s’intravedono ancora un paio di tavoli, chiaramente vuoti; una bottiglia di acqua piena posata per terra, il bancone con la spina della birra impolverato, le marche delle birre – italiane, artigianali, non filtrate: tentavano anche di usare la ‘qualità’ come estrema salvezza, ma senza esserci riusciti a quanto pare – che sono ovali sbiaditi, come fotografie sulle tombe. Il vento della strada accanto fa sbatacchiare i tendaggi a ritmi sonnolenti. Ho gli occhi chiusi, tento di dormire per quei pochi minuti di pausa. Piccoli svenimenti per recuperare ore di sonno perdute a causa del raffreddore. Davanti a me, per tutto il tempo, un furgone porta-valori. Bianco, Fiat, con scritte sulle fiancate (“Spuma antiscasso” o qualcosa del genere, non ho preso appunti, non ho trattenuto la nota di colore che poteva essere decisiva). È stato tutto il tempo fermo di fronte a me, il motore acceso, i due passeggeri dietro i vetri blindati e chiusi, che sonnecchiavano. Un refolo di aria condizionata a congelargli il naso, l’ordine di non aprire per niente al mondo lo sportello o anche soltanto il finestrino. Prigionieri criogenizzati. Ho pensato: fossimo in un libro pulp o in un film poliziesco – l’atmosfera pare essere quella: stasi catatonica che prevede l’esito di un lungo percorso di male e di morte proprio qui, nel redde rationem del Far West urbano; minaccia incombente che spesso alita su ciascun nostro giorno, su ciascun nostro spostamento – se fossimo insomma in una pellicola di exploitation arriverebbero dei rapinatori, ucciderebbero i passeggeri, farebbero esplodere la lamiera blindata del carro e ruberebbero tutto quanto racchiuso nel ventre di piombo del bestione. Corpi crivellati, buchi di fucile enormi, corpi sventrati, lo stupore del sangue carnoso, delle buie budella riversate sui sedili, schizzate sui vetri anch’essi infranti dalle esplosioni e dai proiettili rinforzati o qualcosa del genere. L’oscena crudeltà di una messinscena che di fatto ripete su scenario urbano scene di guerra che abbiamo visto/non visto sui Tg della sera. Di fatto in quei servizi giornalistici non abbiamo visto il sangue, le frattaglie, le trippe umane sversate. Abbiamo annusato la minaccia, la precarietà, la sabbia, il report delle vittime, il conteggio delle risorse umane; eravamo nel pre e nel post, ma non nell’atto: impossibile da svelare per limiti tecnici o forse solo moralistici. Ma un regista pulp ha abbastanza forza e la cattiveria da trasportare effetti-di-guerra in landscape metropolitani. Insomma, alla fine della mattanza i rapinatori se ne sarebbero andati. Naturalmente io sarei figurato fra le vittime collaterali. La mia sola sfortuna sarebbe stata trovarmi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Anch’io sbudellato dai proiettili. Anch’io irriconoscibile come dopo un incidente automobilistico, come dopo un banchetto di zombi.

(#Ufficio, 2019) Ore 17.28. Due minuti non bastano a raccontare la noia, il feroce disprezzo per ogni manufatto dell’umano, la letargica e depressa voglia semplicemente di uscire, il basso voltaggio dell’esistenza, l’incredulità che un’altra giornata sia trascorsa così.
(#In coda, 2019) Sulla E78 appena dopo Siena, verso Grosseto. Ai lati campi di grano, un casolare diroccato con ferraglie e cocci in vendita e un grande cartello appeso alla facciata che dice: “Vendita permanente antichità”. Qui vicino c’è un posto che si chiama Orgia. Scorriamo a passo lento su due file, disposti nelle nostre auto. Nella mia: canzoni di bambini scozzesi, nursery rhimes scaricate da internet con un gruppo che rielabora antichi canti scozzesi. Molto bello, ad A. piace un sacco. Forse è un modo per imparare l’inglese, già adesso balbetta qualche suono a memoria. Impossibile acchiappare la teoria delle auto che mi sfilano accanto e che io sorpasso e poi loro mi sorpassano, il tutto a una velocità follemente ridotta. Ci sono le automobili coi finestrini sigillati per l’aria condizionata; la ragazza che sporge i suoi piedi – unghie smaltate di rosso, sandali marroni legati fino alla caviglia, le gambe lisce di fresco dall’estetista, abbronzatura leggera, cittadina, in direzione mare per perfezionarla; le auto pulite, quelle, come la mia del resto, pigmentate dalla pioggia di sabbia che ormai è l’enzima dell’estate (dimenticarsi le estati degli ultimi miei 36 anni, ormai solo estati post-clima, quelle di cielo avvolto dalla lastra per radiografie, oppure di cielo color polvere di caffè, che poi piove per tre minuti e sulle auto, per strada, sui vestiti, sulle tele degli ombrelli, sui cornicioni, sui fiori, sui ferri delle altalene nei parchi comunali si deposita una macula di sabbia desertica: è il soffio del millennio, la profezia pasoliniana ch’è tanto liberazione quanto incubo e così ogni liberazione dev’essere, distruttiva); un telefonino acchiappato dalla morsetta di gomma a sua volta appesa al bocchettone dell’aria: una mappa GPS disegnata sul display. Il cielo è grigio uniforme, appena ondulato, morbido, è la prima giornata da un mese a questa parte in cui il tempo sembra brutto. Sono dominato da un’angoscia senza nome: è l’angoscia dell’estate, è l’ansia di una stagione sfibrante, di pura sopravvivenza, tanto più difficile per me perché si suppone ci si debba divertire, liberare, vivere esperienze rilassanti e rigeneranti dopo un anno intero di lavoro: invece mi sfianca l’estate. Ora l’estate è per me il piazzale del lavoro, di cemento, battuto dal sole; l’odore di zucchero e petrolio dei tigli nella villa che ci ospita; il ventilatore in ufficio, le finestre sbarrate, chiuse, alle 9.30 del mattino, l’ondata di calore per raggiungere casa. E ancora: gli inciampi, la pelle appiccicata di sudore, l’afa che mi restringe i bronchi e non respiro; ogni impegno è un limite insopportabile, ogni azione è definitiva e devastante.

(#In cucina, 2019) Aspetto che il caffè sia pronto. Per viaggiare per strada, sui viadotti, nelle gallerie, quando si apre la vertigine orizzontale della strada, in discesa magari, quando appare l’inevitabile, l’Incontrollato, il potenzialmente distruttivo, bisogna avere fiducia: fede che il ponte non crollerà, che le tue mani continueranno a tenere stretto il volante, che un colpo di sonno, un malore, un attacco di panico, una respirazione selvaggia, una aritmia burlesca, non ti faranno perdere i sensi e volare, in un bolo di lamiera e controsole, nel vuoto. Per prendere l’aereo devi aver fiducia che il pilota non sarà come quell’Andreas Lubitz che, quietamente, si è blindato nella cabina e ha diretto l’aereo – colmo di gente, ça va sans dire – contro le montagne. Un lavoro svolto pazientemente, lucidamente: una lenta degradazione verso la morte esplosiva. Bisogna avere fiducia nel mondo. A me, invece, viene da pensare d’avere sempre la casa infestata di formiche.

(#Ufficio, 2019). In attesa che G. mi dia relazione per una email. Tutte le nostre piccole morti.

(#Pausa pranzo, 2019) Importanti novità all’ombra dell’ex-bar Luisa. Dentro il bar tutto smembrato: portato via il bancone, la spina, i tavoli, le sedie, abbattuto parte del muro. Calcinacci in giro, cavi scoperti, forassiti. E un cartello affisso: Proprietà privata.
(#Ufficio) I minuti che passano tra l’accensione del computer – la macchina che ansima e ritorna alla vita, si sgela dal suo sonno notturno ibernato – e l’apertura del programma di posta elettronica. L’ansia per quello che arriverà, le richieste da sbrigare, le email con l’etichetta urgente, il carattere urgente del servizio che va esplicato il prima possibile. Per me – e presumo per tutti quelli come me – che non abbiamo una mansione precisa, che viviamo di piccole quantità di tempo che si sommano l’una all’altra, senza particolare valore, dove magari troviamo il tempo per fare piccole cose nostre, bazzicare siti internet che ci piacciono, interessarci alle cose che c’interessano, come se il tempo di lavoro, libero dalle tenaglie dei ritmi serrati, fosse un tempo di semi-libertà vigilata, nel quale troviamo il modo di proseguire i nostri commerci illegali. E allora, per quanto odiamo la nostra giornata di lavoro, ne siamo avvinti: siamo legati alle piccole povere occasioni di clandestinità (l’illusione di portare avanti un discorso-altro, di fare il nostro eroico lavoro sottobanco, di nascosto, al nero, approdare alla mitologia dello scrittore che lavora di giorno ma scrive di notte o scrive nelle pause: è una mitografia). Quando si sta per aprire la posta e l’emergenza – ci chiederanno documenti importanti, servizi di complicata burocrazia, roba da sfasciarsi gli occhi su Excel, sarà tutto dominato dal foglio verde di Excel – è potenza vitale, è viva, è un non-ancora ma tuttavia un è-presente, anche ora, foss’anche solo in forma di angoscia, vorrei fuggire. Smetterla con tutto. È tempo morto nell’angoscia.

(#In ufficio, 2019) Aspetto il temporale. L’hanno dato per certo, ovunque: sul sito dell’Aeronautica militare lo danno al 50%. È poco, mi rendo conto. Spero che arrivi presto, però, che spacchi la calura alogena, che incendi il cielo saturo di polvere esplosiva come una miccia, nella distrazione degli altri, mentre scatena un nubifragio che stronchi i balconi e rovesci le radici. È da questa radice che nasce la Reazione: immobilità, decelerazione emotiva, urla delle carni. Come fare a non vedere che siamo chiamati a diventare Insubordinati di noi stessi? Presto chiederemo un sorso d’acqua ai paesi scandinavi. Sono ossessionato dalla Fine. Sono già nella Fine, mi comporto come se dovessi affrontare – pur sapendo di non farcela – un Post. E così immagino, ma per rassicurarmi, che la Fine del Mondo arriverà per depressione. Una parola per oggi: psicosocialismo. C’è questa specie di pioggia di afidi sulle nostre carni.
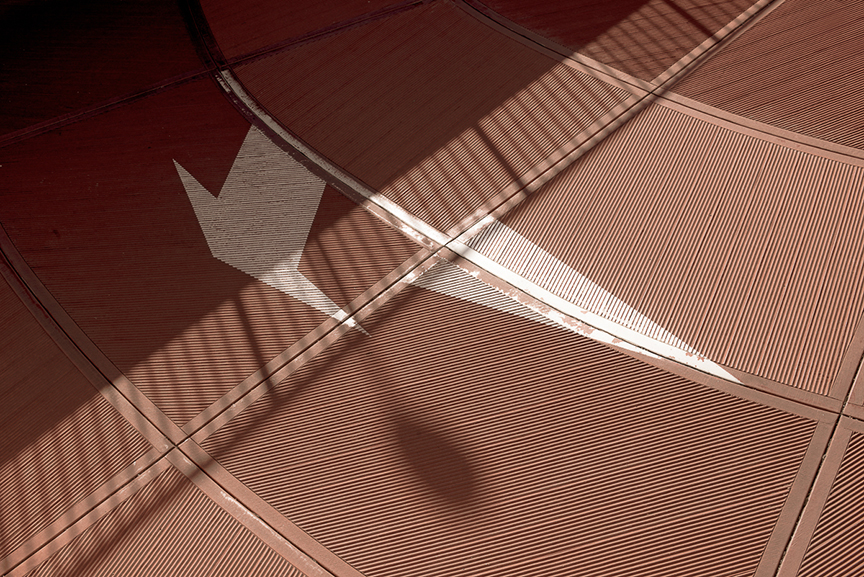
(#Ufficio, 2019) Non ti riposi mai, non acceleri mai: è un tempo uniforme, terribilmente uniforme; un tempo glaciale, di premorte, intessuto d’ideologia e superstizione.
[…] Tempimorti di Fabio Polenchi su Nazione Indiana […]