Meditazioni barocche: la trista consapevolezza
di Sergio Beltramo
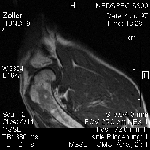
La conoscenza è tutto fuorché organica: si conoscono ormai meccanismi vertiginosamente specifici di alcuni campi del sapere, ma il bandolo della matassa, l’insieme e il suo senso ci sfugge più che mai. Eppure il livello dei saperi tradizionali ha cagionato delle trasformazioni psichiche di enorme portata. C’è una nuova “trista” consapevolezza: nell’arco dei fatti, fra i suoi estremi segnati all’infinito dall’estremamente piccolo e dall’estremamente grande, il nostro spazio di percezione è per sua natura mediano, è una minuscola frazione, quella più o meno della fisica meccanica…
E’ il minuscolo teatro dove esistono le forme, il tempo, lo spazio tolemaico. Una dimensione fittizia che è trascesa da un lato dall’atomistico, il molecolare, il cellulare; dall’altro dalle fantomatiche evoluzioni del colossale, spazio non spazio, dimensione atemporale di un inimmaginabile scatenamento di forze. Una dimensione, la nostra, sempre trascesa dal tutto, uno spettacolo che è finzione della nostra percezione e rielaborazione neuro-sensoriale, ma che è invece un microscopico passaggio della corsa tra infiniti; un punto, come infinitamente altri, dove si incrociano e si scontrano appunto le azioni del microscopico e del macroscopico, un punto del continuum.
Ma gli uomini poi, nella loro maggioranza, hanno questa consapevolezza? Probabilmente sì, sebbene a tratti, magari nel momento di un esame clinico, di un’operazione, di una statistica… Sebbene volgarizzata, la percezione c’è: non c’è più morte (e con essa assenza significativa, che diventa exemplum, memoria, lezione; oppure anche tensione benigna al ritrovamento…) ma solo un ignominioso deperire di cellule, un modificarsi di sostanze per effetto di choc o entropia. Ma non c’è neppure più uomo, natura, bellezza (e va da sé, meno che mai hanno senso idola di vetusta tradizione: decoro, decenza, giustizia, onore ecc.)
E’ una consapevolezza mantenuta allo stato inconscio, che è semplicemente divenuta lo sfondo al vivere di ogni uomo, anche se a livello conscio prevale l’illusione dello spettacolo, il canto delle sirene della civiltà, con bellezza, gioventù, felicità. Ma forse gli effetti di questa consapevolezza aggallano quando l’uomo getta via la propria vita, la brucia, o brucia quella di un altro. Intanto di valori fondanti che inibiscano un gesto no ve ne è più: l’attimo di follia dell’omicida o del suicida segna un momento, michelstetterianamente di persuasione, di chiaroveggenza; un atto distruttivo (e penso anche a quello di tutta una civiltà che distrugge le sue stesse condizioni di esistenza, risorse, habitat ecc.) che si consegna volontariamente all’infinito dei fatti trasformativi che sono la norma dell’universo; che si traduce in un fatto tanto infinitesimale, per l’ottica esterna che traguarda tutto l’essere dalla distanza, da non distinguersi dallo spostamento di un granello di sabbia, dal processo che avviene in una lontana galassia, o ancora dalla fuga di un elettrone dalla propria orbita. Cos’è il morire di una “persona” se non una leggenda superstiziosa? In realtà nessun essere individualizzato muore, ma solo si muta in altro un anello della catena chimico-biologica; qualcosa che poi non ha quel viso, quei gesti che ce l’hanno fatto distinguere, ma che è un inconosciuto, che, per il nostro sistema di allestimento teatrale, ha assunto per un certo arco di tempo quegli illusori tratti, quella maschera. Nulla ci distingue davvero dal tutto e dal niente, nulla vi è che dica inequivocabilmente che siamo noi, noi e non altro.
Ebbene, possedere questa trista conoscenza ha qualcosa di traumatico. E’ come se un’ombra si insinui nell’anima e si proietti su ogni pensiero, ogni sguardo, ogni azione: la vita, la bellezza fragile delle cose, diventano fantomatiche figure di un falso ontologico, maschere dell’insussistenza. E si finisce per vivere (abbastanza faticosamente poi) dovendo rispettare le infinite macchinose clausole di una finzione, tendendo per istinto verso cose che non esistono in quella forma e sostanza che spinge a tendervi, lottando per tenere in piedi una scenografia da telenovela, sapendo che è una scenografia, che quello che vi è dietro è il paesaggio spoglio di uno studio, cavi, prese, pannelli ammonticchiati, mazzi di fari alogeni.
Il sentimento che ne deriva è quello della nostalgia: nostalgia per ciò che si ha di fronte, per ciò che è presente, ma che sempre, sottilmente, suggerisce che il tuo amore è un amore mal riposto, indirizzato a qualcosa che in realtà (se realtà si può dire) non è lì di fronte, non è lì presente, non c’è in nessun luogo e tempo. Può accadere con il paesaggio dei tetti della città appena rosati dal tramonto, con un lago alpino, con una margherita sotto ad una panchina, con una bambina che ride. Si prova nostalgia per quello che essi sono e che in verità non sono, per il loro assoluto reso possibile dalla probabilistica (o arbitraria) ricostruzione dei sensi e dei neuroni, dall’abitudine a concepire un cosmo antropocentrico, ad assegnare valore metafisico alle cose, a vivere fra significati, e non processi.
Una nostalgia di questo tipo è in verità un sentire contraddittorio di amore-odio. Si cerca in modo indefesso i piccoli segni per cui la vita possa prendere dignità di un racconto leggibile e, nello stesso tempo, si tende a voler bruciare i tempi, ad avere con quei segni solo un incontro fugace, perché il racconto in fondo è di fantasia, ed è meglio che finisca presto: che la messinscena abbia termine. Perché dopo un po’ è odioso dover permanere nel teatro, seduti scomodi, assonnati, a sollazzarsi con un inesistente “paese dei campanelli” o “cavallino azzurro” che trilla è motteggia là sotto sul palco. Meglio andare subito a dormire, come faranno più tardi gli attori.