Sangue
un racconto di Stefano Di Leo
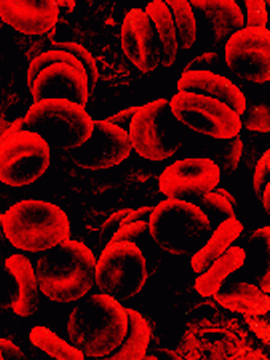
primo giro
Arrenditi che sei cascato, dico, eppure ho ancora voglia di combattere.
Ieri, tornando, ho comperato due polpette di filetto al macellaio. Trippa. E una polpetta l’ho regalata ai gatti. Ho mangiato una pentola di minestra intera, l’altro ieri, con patate e fagioli: le patate le fai fine e i fagioli devono essere freschi da scafare. Domani mangerò trippa al sugo e mio figlio dice metti la mentuccia, ma va bene anche sedano e carote, dico io, il sedano va bene.
Dormo solo alle tre se prendo il Tavor, e il catetere rende la notte spinosa, meglio di prima, sì, ma comunque notti insonni e tu mi svegli o le tue amiche e io debbo fumare ancora. Ho ridotto a dieci sigarette, comprese le notti, e non mi aiuti a mantenere la linea di difesa se desti il mio sonno: non ho che fare e fumo e accendo la televisione. Ma io voglio esserti amico, come coi gatti, ché siamo tutti creature di Dio e a noi nessuno ci aiuta. Io mi difendo, però. E tu lo sai.
Giorni addietro, ero appena uscito, è Taleb a costruire la cucina: due assi di lamiera ripiegata fermi al muro con stop e viti da dieci, quattro mensole tagliate a proposito, fuori misura, otto staffe che vanno dagli assi a sostenere le tavole in legno. Su una tavola, la più profonda, fissata all’altezza delle anche di un uomo né alto né basso, una cucina da camping tre fornelli e un budello gommato che la congiunge alla bombola del gas. Ha fatto un buon lavoro: è capace e abile con le mani come non lo è a far di conto e con le parole, le nostre, che proferisce rare e mal assortite. Tu capisci che intendo: è silenzioso, non più di me, ma con pensieri marocchini e liquidi che scivolano in questo mondo e non fanno pozza.
Taleb è mio figlio e mio schiavo, se vuoi: più capace di mio figlio che lavora impiegato e si arrabatta affilando parole al sindacato, e mio schiavo perché ho soldi e lui no, e sono generoso soltanto se voglio.
In ospedale ieri o ieri l’altro c’è una vecchia, te lo voglio dire, una vecchia in barella allineata in corsia e una dottoressa che cerca una donna e le passa affianco e la guarda bene. Poi continua a cercare e torna a guardarla. Effettivamente la vecchia è calva ed effettivamente sembra un uomo e non può parlare perché ha perso i sensi e nessuno parla per lei, e anche se un paziente grasso e schiumoso dice che la donna che cerca non può essere che la vecchia in barella, la dottoressa continua a pensare che è un uomo e se ne va.
Arrenditi che sei cascato, dici, eppure hai ancora voglia di combattere.
Amo i ristoranti e nei ristoranti non uso posate, amo la carne di agnello e le polpette ancora quasi crude. Ristorante è giorno di festa, Pasqua e Natale, tovaglia bianca e pulita, bicchiere dell’acqua e bicchiere del vino, grande occasione, pranzo d’affari. Se digerisco lo faccio sentire e anche se ho aria nelle viscere, non me ne frega – mio figlio mi guarda come hanno fatto mia moglie e mia madre, ancora desso che mi ha ritrovato.
Ristorante è sera galante, corteggiamento, è giovane donna che guarda fiera e dimessa. Ristorante è cena e dopocena, strategia di conquista, volontà di potenza.
Ricordo le donne, e tu non sai quante, giovani gorgoglianti, giro-vita e piquet.
Dimmi che vuoi esser legata, stasera, dimmelo amore mio, con gli occhi bendati perché è la sorpresa che conta. Fissata a questa sedia di contenzione come durante l’inquisizione, cosa immobile fatta di carne. Dimmi che vuoi la tortura, bendata (e, credimi, non è la fortuna), chiedimi di inzupparti di urina o che spenga cicche sui tuoi seni. Implora sudici insulti, merda di porci, di regalarti ai miei amici.
Donne di vincitore, rosse su scarpe in equilibrio, occhiali-gatto, onde laccate.
Dopo quelle partite – quelle in cui i denari si fermano al mio giro, quelle che iniziano la notte e finiscono un uomo, dove i giganti cadono in mucchi di argilla, ad ogni tavolo, già implorando il perdono di figlie gravide, di mogli annientate e i grandi sono i migliori strateghi, che non hanno bevuto, che non hanno fumato, che odiano il giuoco e le carte e il tavolo verde, come me servi fedeli della vittoria – dopo quelle partite me ne andavo in giro spesso nel fresco della notte con la donna rossa del vincitore, passeggiando o sgommando e derapando con il coupè noleggiato.
La cartella e i vari allegati dicono che ho un cancro alla prostata, sangue denso come purea di catrame, qualcosa al fegato e diverse ulcere in diversi tratti intestinali. Non voglio andare, tuttavia, se mi ricoverano firmo e me ne vado. Loro lo sanno, stappo l’ago e sono una fontana – l’ho già fatto – strappo il catetere piegato di dolore ma alla fine vado via. Un taxi e vaffanculo.
Mio figlio preoccupato chiama mia madre che chiama mia moglie. Ma loro lo sanno, ho degli impegni e non posso mancare. I soldi girano e devo star lì a intercettarli, sennò la giostra è finita. Questo finché sono in piedi, poi si può capire. Sono un guerriero ferito e tutti sanno che ho combattuto, se cado mi aiutano ma non avranno pietà. Non c’è pietà per i gatti: non ce n’è per i figli di Dio.
Non è scemo come il marocchino: sa e lavora, e si fa posto nella vita. Matura – mio figlio – una pensione (buon per lui) e ha scritto un libro sui mestieri della televisione. È un po’ cazzaro, ma che gli posso rimproverare? Ora sta tutti i giorni con me, un giorno sì e uno no: ci diamo appuntamento in bisca o alla scuola occupata dove viene a prendermi con il suo jeeppone sedili in pelle rossa.
So che deve essere un buon oratore, almeno a giudicare dal suo mestiere, ma con me è silenzioso: parla lo stretto necessario – hai prenotato l’ecodopler, hai ridotto il fumo e il Tavor – e allora, per rompere il ghiaccio, dico delle mie giocate, di come ancora vinco nonostante la statistica vorrebbe il contrario. Descrivo interminabili poker, corse truccate, calcio-scommesse. Storie che detesta, immagino. Storie che hanno fatto la mia storia.
Se siamo al ristorante – e, se non siamo in ospedale, ci stiamo – mi guarda ponendo la massima attenzione a quello che dico. Lo fa per non farmi ripetere, per ridurre il rischio che i nostri vicini possano ascoltare e appena termino cambia discorso: si arrabatta con argomenti che non è abituato a trattare, si porta in zone neutrali né di sua né di mia competenza.
Prima stavo morendo, il novanta per me era già uscito. Avevo gambe come palloni da rugby, non pisciavo, non cacavo più. Svenuto, mi ritrovo in ospedale. Un tossico irrompe in corsia, minaccia strage di medici. I pazienti dapprima approvano sarcasticamente ma poi, quando sono scaraventati qua e là, si lamentano e alcuni muoiono di paura. Interviene il vigilantes, quello della mattina: basso e magro, poveraccio. Il tossico lo scaraventa e lo prende a calci: in bocca, al fegato, sui coglioni. Chirurgico, in un certo senso. Finché arriva la squadra antisommossa… Quarantotto ore in corsia d’emergenza ed è come se pisciassi benzina e aghi, nessuno mi parla, nessuno mi dice quanto mi resta da vivere. Se devo morire, comunque non qui e stappo l’ago e strappo il catetere, firmo, prendo un taxi e torno alla scuola occupata, nel mio quarto d’aula.
Dopo quelle partite me ne andavo in giro spesso nel fresco della notte con la donna del vincitore, passeggiando o sgommando e derapando – come ho già detto – con il coupè noleggiato.
Grotte nere e abbaglianti a tempo alterno, afrore di pelle e musica da ballare. Vino per bere.
Facevo il giro dei locali di provincia dove il sesso è straniero e il tradimento home-video, pagavo ciò che mi toccava e godevo delle gioie della vita. La donna che portavo con me aveva sempre un nome diverso: Tania, Violetta, Rosanna, comunque diverso da quello di mia moglie. Alla fine – in genere all’alba – ce ne andavamo in un qualche motel: autostrade o strade provinciali. Si pagava in anticipo, ricordo, la donna e la stanza sguarnita: un letto, un armadio e una sedia: tutto quello che serve per mettere in scena trenta minuti di ardore. Spendevo in una notte il salario di un buon impiegato e se il mondo ha un culo – dicevo – allora, per Dio, in culo al mondo.
Sfilo l’ago e vedo il sangue schizzare dalla vena, un corso deviato nel vuoto che non oppone resistenza. Chiazze frastagliate sul pavimento, macchie assorbite dalle lenzuola, gocce che scivolano sulla mia scarpa destra.
Strappo il catetere, firmo, prendo un taxi e torno nel mio quarto d’aula. Taleb è lì che mi aspetta, fiducioso, fedele come un cane. È rimasto nella stanza per due giorni interi, due giorni interi uscendo solo per respirare aria di pioggia da lui tanto odiata.
Ha vegliato seduto sulla sedia, come se fossi nel letto moribondo, e ha costruito questa strana cucina-libreria. È come un figlio per me e mi accudisce come avrebbe fatto con suo padre.
Nella sua lingua a gocce mi racconta il tempo della scuola, che parla bene il francese, meglio che l’italiano, e che non ha desideri: ma allora sognava di diventare un grande marinaio o addirittura un capitano.
La sua famiglia è a Rabat: ci sono madre e sorella, e il padre che é morto dopo che se n’è andato. Si chiamava Mokhaar e andava in Moschea ogni mattina, ed era alto e grasso, intelligente e calmo. Sapeva attendere il tempo di parlare e non si arrabbiava, anche se lui e sua sorella litigavano in continuazione. Dice del suo modo adeguato, degli occhi neri e lucidi e il viso tondo che sorrideva quando, dopo il lavoro, portava a casa cioccolata e semi di girasole.
Al suo funerale uccisero vitelli e montoni e l’Imam disse: fate il bene ed evitate il male e poi fu lavato, e profumato e vestito di bianco, e portato alla Moschea e, infine, al cimitero.
secondo giro
Gira il sindacalista, cammina su e giù come un forsennato. Non ha parole con me che sono il padre e spera in quelle di sua nonna e sua madre.
I loro sguardi sono un plotone d’esecuzione, minacciosi chiedono il mio ultimo desiderio. Mi hanno sempre guardato così, anche al di là delle circostanze attuali.
Prima mia madre da quando scoprivo impazzito il giuoco delle carte. Matto, con il talento mnemonico del vincitore. A fine partita, dopo otto ore di gioco, sapevo i punti scartati e se c’erano assi nelle maniche. Memorizzavo figure e scale, semi e colori: Come Quando Fuori Piove è stato il motivo di tutta la mia vita.
Mia madre non può amare: non ha tempo da ragazza, e per di più non sono certo il suo unico uomo. Deve far soldi, mia madre: svelta ribaltare la vita che l’ha voluta regina nella famiglia dei diseredati. È tempo di guerra, tempo di borsa nera, quando alla solidarietà dei poveri si è contrapposto il volo degli avvoltoi. Zucchero e farina a cento lire, ed era un affare. Mangia gatti e bucce di patate. E lei è bella e veloce, e gli uomini perdono il senno, disposti a giuochi crudeli con rivoltelle lucide sotto la giacca. Spendono quello che hanno, anche se hanno molto da spendere.
E così la ricchezza fa cerchio attorno a questa donna minuta e lei non dà corda, tira la lenza fino tagliarsi le mani. Riempie falle aperte da una famiglia sbagliata – la sua – che vuol veder denari prima che l’educazione.
A qurant’anni mia madre ha due lauree – ed erano tempi in cui le donne pulivano casa – e uno studio avviato nel centro storico della città della Storia.
Per lei sono un ricordo lontano: il – come si dice – il frutto di un letto sbagliato. In più son diventato gaglioffo e ho il ghigno che mette paura.
Mai ammetterò il mio amore – ora con te – ma mai ammetterò il mio amore per mia madre: un volto lontano, spesso di circostanza, che si allontana via via che cresce il desiderio.
Così tutti i giorni in strada a farmi antipatico nemico, sperando che una guerra personale possa irradiare un poco di luce sulla mia misera ribalta. Opposto all’apprezzabile, al desiderabile; nemico degli altri e mio per un poco di luce. Scoreggio e bestemmio e rutto e mangio con le mani, bisticcio appena posso, non ho ragioni. Istinti, cibi guasti, dormo vestito, non uso dentifricio: sono in tutto e per tutto un animale.
Sarebbe bastato poco, forse solo un rimprovero e un abbraccio, e chissà cosa sarei diventato, chissà dove sarei arrivato.
E poi mia moglie (seppure) che ha avuto pietà di me e io non l’ho perdonata: non direi sposalizio, più sincera coesa amicizia: non sostenibile in ricchezza come in povertà, in salute come in malattia.
Tutto un gioco, all’inizio, a nascondere verità: il gioco dei mimi in cui si posa la parola facile e si tralascia quella spinosa. Non è dormire freddi e vuoti, in vero, ma è svegliarsi soli nella notte che sconfina ogni dove. E quando procreammo, infine, lei si diede tutta al lavoro – responsabile più di me del nuovo nato – come una monaca a Dio.
La sua impareggiabile modestia, la sincera umiltà piacque ai cesari del boom economico che la plasmarono presto in una specie di suora in carriera, pronta ad assumere responsabilità per poco più di un pezzo di pane, a dare tutto e chiedere zero.
Così sono in guerra di nuovo, stretto tra una donna santa e un neonato insonne che trasuda necessità.
E torno quindi ai miei falsi amici, coltivati al tavolo da gioco, di cui disprezzo il tempo che regalano alle carte cercando rifugio dal resto delle cose, e il loro andare in pari ed esser contenti, e il mettersi in berlina a fine partita. Tuttavia torno a loro, ad inalare odio per i miei modi bruschi e il parlare strano che ho da quando sono bambino.
Informe, il tempo trascorre compresso o dilatato, decenni che invecchiano gli oggetti – pensa alle sedie – e muoiono i gatti e cambiano le mode che io, in me, percepisco accozzati in uno, o due, o tre minuti di vita rilevante: atti-fantasma che hanno deviato il corso naturale della mia semiseria esistenza e seminato futuri ricordi.
Tra questi ce n’è uno: sono io che salgo le scale: stanco, semi immobilizzato come in un sogno, ho gambe corte, cortissime: venticinque, al massimo trenta centimetri, e incontro la signora del terzo piano: bionda massaia ossigenata. La sua mano scorre la ringhiera, smalto rosso increspato, rughe di troppo fumo. Ci incrociamo al piano, io devo salire ancora e lei dice: buongiorno. Semplicemente. E mi guarda come. Non saprei dire come.
Questo è un atto.
E dietro si è svolto il dramma di cui ho vaghi ricordi: salgo ancora un piano, mia moglie mi aspetta sulla porta, con lei nostro figlio che adesso ha più o meno dodic’anni. Mia moglie dice: ha telefonato Rosanna. Mi ha raccontato. Sono annientata. Te ne devi andare.
Rosanna è cugina a mia moglie. Le loro madri sorelle di sangue: figlie dello stesso partigiano che ha ringhiato contro il regime del ventennio fino a rimanerne ucciso.
Avevano pattinato insieme – le cugine – e saltato alla corda, e scritto le prime incerte parole tra le righe di quaderni rilegati a mano, ballato il twist e condiviso gonne e camicie bianche strette in vita.
Da sempre, da quando la mia futura moglie ed io filavamo, sin dalle prime volte, Rosanna era per noi un’imprescindibile appendice; ed era mia moglie a volerla: intercapedine tra i nostri corpi, direi ora col senno di poi. Dappertutto: cinema, pizza, domenica sera, Rosanna era la nostra cugina del cuore.
E quindi intimità non ce n’era: mia moglie, la mia futura moglie, non era allora una persona fisica, non lo è mai stata che io sappia: una santa donna, sì, e anche femmina provocante a suo modo, ma assolutamente imbambolata.
Deve aver vissuto qualche spiacevole episodio – e me ne dispiace – una violenza o chissà cosa, fatto sta che le sue fantasie non trovavano la strada: inibita, sessuofobica direi, esattamente il contrario di me e sua cugina che ci guardavamo già torvi secondo un codice di primitiva istanza, di popolare bassezza che avevamo stampato nel DNA.
Eravamo amanti già prima del matrimonio: consumavamo i nostri amplessi come blatte, nelle melme di vicoli ciechi, nei portoni, sotto camion-rimorchio parcheggiati ai mercati generali.
Ho tradito mia moglie sempre, e lei mi fronteggiava con la pietà che ha sempre avuto e che non ho perdonato.
________________________
(1 – continua nel post successivo)