Sangue (#2)
seconda e ultima parte del racconto di Stefano Di Leo
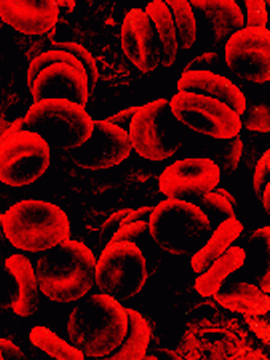 A scuola è muto, dicono: forse gran pensatore – mio figlio? – o forse è scemo. Robusto – diciamo grasso – e non mette il grembiule. E non piange e i suoi capricci sono in forma di coriacee ostinazioni. Non che sappia molto di lui, solo che è un ragazzino distratto e chiuso e – come dice sua madre – patologicamente solo.
A scuola è muto, dicono: forse gran pensatore – mio figlio? – o forse è scemo. Robusto – diciamo grasso – e non mette il grembiule. E non piange e i suoi capricci sono in forma di coriacee ostinazioni. Non che sappia molto di lui, solo che è un ragazzino distratto e chiuso e – come dice sua madre – patologicamente solo.
Finché ero suo padre spesso andavamo al fiume, pescando nulla pur confidando nella pastura che ci preparava un bagnino di Fregene. La lenza avrebbe tirato anguille e trote se avessimo avuto passione, ma il nostro momento era piuttosto il panino al formaggio che divoravamo stesi al sole schernendo il consesso civile che studiava o era al lavoro.
Non ero un buon padre, prima, ma lo ero.
Finché me ne andai di casa lo iniziavo alle cose strambe che la vita non regala: la libertà di avere poco o nulla, il non-rispetto, lo sguardo cattivo.
Lo imparavo a guidare: seduto sulle mie ginocchia a girare il volante, a prendere il posto al parcheggio anche se un’altra macchina stava prima. Gli insegnavo a non perdonare gli sgarbi, ma ad aggredire l’uomo e non le sue cose (non sopporto chi, per vendetta, sgarra fiancate di automobili o fora le ruote, o sparge benzina sulle serrande e gli dà fuoco: è l’uomo il nemico e va fronteggiato: occhi negli occhi, petto a petto, con la paura nel sangue in un surplus di adrenalina).
Questo ho cercato di dargli, senza sforzo, nel corso naturale delle cose.
Per quindici anni ho saputo di lui in virtù di resoconti sintetici: il ragazzo ha studiato bene e l’uomo che è adora il suo lavoro. Al fianco donne alte e raffinate di quella società di cui d’istinto ho sempre diffidato.
Se non fossimo così stretti: padre e figlio: più che fratelli forse, saremmo nemici.
Lo siamo stati, comunque: per anni ha ringhiato contro il vuoto che ho incarnato, grato diceva di aver perduto il padre che ne avrebbe impiombato il volo. Il figlio che non dà ragione all’abbandono e straparla e congiura come Bruto.
Questo è stato il figlio perché quello era il padre, lo so. Ma io che non so dire sentimenti o fare carezze, ho curato il mio rancore col metodo veloce del fuggiasco. Sapevo chi era e dove andava, sapevo la scuola e, quando crebbe, conoscevo il suo posto di lavoro: potevo incontrarlo per caso, se volevo; ma non avevo parole ed era troppo caro il suo perdono.
Così per anni siamo stati nemici a distanza: due Stati in guerra di spie: i conoscenti comuni che riferivano a entrambi in succinti rapporti top secret. Ed eccolo qua, adesso: a camminare su e giù indispettito dal mio matto rifiuto.
Eccola la famiglia, riunita in questa ballata di morte stonata: mia madre mia moglie mio figlio, gli occhi puntati sulle mie gambe gonfie di sangue malato: ad implorare, e minacciare la mia ostinata irresponsabilità.
Ma ora ho cento gatti da accudire e i gatti schifano l’incuria. E poi ho mille impegni, perché i soldi girano e devo intercettarli: sennò, ti dicevo, la giostra per me ormai è finita.
Vorrei parlarti dei gatti, se vuoi. Se vuoi te ne parlo. Non voglio annoiarti anche se sei in mio potere: potrei schiantarti, con questa scarpa armata farti – fare di te – una macchia di sangue sul muro. Lo stesso non voglio annoiarti.
Il primo capitò comunque che stavo arrivando alla scuola. Avevo le mie due valige e zoppicavo, te lo dico: ero un relitto come lo son sempre stato. Estinto un debito, non avevo più la mia casa e un gruppo di giovani a sinistra mi offrirono – Dio li protegga – un posto alla scuola occupata: un’aula divisa in quattro – e quindi per me un quarto d’aula – dimora, oltre che me, tre altre famiglie straniere.
La gatta, che è nera, mi sfila avanti ad annunciar sventura. Ma tanta è la sfiga che porto che, passa un secondo, e sento una frenata e vedo il gatto che vola cento metri dal botto. La gatta rimane lì, inebetita, pronta a scattar d’istinto ma con le zampe andate, che si trascina come può al ciglio della strada. L’auto non s’è neanche fermata, neanche ha rallentato e due passanti – voluti da Dio a testimoni – atterriti, occhi coperti da bianche mani, tirato dritto, fuggono il dolore del povero animale – attraversando la strada – che si contorce come un pesce sulla riva.
Pensa all’assurdità delle cose: hai una prospettiva, dei programmi per la settimana (ma perché te li fai?) e invece un’auto sbanda e per te è finita: niente più programmi, niente più domande.
Così poso le valige e raccolgo il gatto e lo porto nella stanza che mi assegnano i ragazzi del comitato.
Qui – col tempo capisco – un problema è che devi partecipare ad assemblee e manifestazioni, e un altro problema è che odiano i gatti. Li farebbero morire di fame se non ci fossi io a dar da mangiare.
Le assemblee si fanno in palestra: un seminterrato originariamente pensato per il basket e la palla a volo e oggi ingombro di armadi, brande e divani degli attuali residenti di passaggio. Ci sono anche le mie cose lì in mezzo (lo dico così, non si sa mai).
Nelle assemblee si parla di avere una casa, del diritto di averla, e a me sembra una cosa giusta anche se debbo dire faticosa. Non capisco quello che dicono, parlano di antichi valori, di unire le forze. Ma per una casa ci vogliono soldi e la gente fa il servo una vita per farsi i soldi e comprare la casa, non capisco perché la dovrebbero dare a me che non ho mai avuto un padrone.
I ragazzi del comitato sostengono che la casa è un diritto a prescindere, dicono.
A prescindere.
Io ho cercato di fargli capire che la cosa non va in questo modo: che sei un padrone solo se hai un padrone: che è un percorso, una carriera: l’ho visto così spesso nella vita. C’è chi ci nasce con quella camminata: all’inizio sei un morto di fame e alla fine puoi mandare i tuoi eredi alle scuole private dei preti; ma se nasci per essere libero…
Per fortuna hanno capito che non sono adatto, che sono troppo zoppo per stare alle assemblee e mi hanno detto: sei persona anziana, dai retta, stattene a casa tua quando ci vedi, che è meglio: che Dio li protegga i ragazzi del comitato, che li abbia in gloria, te lo dico io.
Raccolgo la gatta e la porto nella stanza che mi hanno assegnato.
È morta all’inizio, scavare buca e seppellire; e invece rimonta la fine: con passo felino scarta l’oblio e si rimette in auge: dare la caccia a passeri e mosche grasse, sventra lucertole, cattura topi.
Ma non sarebbe andata così se Taleb non m’avesse aiutato.
Taleb, mio figlio il marocchino, si presenta il giorno che arrivo con tanto di valige e gatto morto: sta sulla porta mentre cerco di dar forma agli spazi e tempo al tempo: adagio la gatta sulla branda e verifico che respiri, penso a un bar dove mangiare e scompongo la vita in atti-fantasma: sono perché sono stato, mi viene da dire, e quando mi giro vedo quest’uomo così immobile e così al centro della porta che penso a un portiere alle prese con l’ineluttabile concetto di rigore.
Quando si scuote, imbroglia un discorso di auto-presentazione: come si chiama, che fa, da dove viene. Il reietto degli emigrati: povero, scemo e marocchino. Pastore e muratore, sembra voglia dire.
Ogni arrivo è speranza per lui: appena un poco di calore. E si precipita su ogni arrivo con l’ansietà dello sciacallo: a intercettare, prima degli altri, un possibile alleato.
Qui alla scuola tutti gli sono nemici: italiani, somali e tailandesi. E gli stessi uomini del luogo del tramonto: i maghrebini. E i marocchini, in particolare.
Anche se li dimostra, non puoi dire che ha quarant’anni, come non puoi dirne trenta: ha gli occhi nascosti del delinquente e un sorriso bianco da bambino; la barba rasata a scatti e i baffi del tentatore.
Mi rendo conto che può risultare schifoso: i suoi modi incerti, la sua traballante andatura ad uso esclusivo di rapide azioni: le auto e le case degli altri: non c’è aula che non abbia visitato, non c’è serratura che non possa penetrare.
Il giorno che arrivo viene al mio cospetto, vuol darmi a bere che è muratore, che è un tuttofare. Vuol far mostra di quel corpo instabile, di quel modo incerto che vuol prestare alla mia magnificenza: per pochi dirham signore: tolgo merda e caccio le mosche; lavo a terra e preparo il couscous bidawi alle sette verdure.
Ma io faccio parte dei giocatori e guardo un uomo e so tutto.
E lo vedo offrire vino per sviare la mano, lo vedo pesare i tesori con la coda dell’occhio.
Tuttavia ogni ladro ha un’occasione e io non posso oppormi, non dipende da me e lo lascio entrare. Con erbe calde ripara la gatta (che scarta la morte e si rimette a cacciare le mosche, a sventrare lucertole, a torturare di nuovo i topi) e mi lava i piedi e toglie le unghie incarnite e pulisce i fornelli dopo che ha cucinato ed infine diventa mio figlio, più di mio figlio che ama la vita chiara e convince gli altri parlando forte al sindacato.
Taleb fa acquisti al mercato la mattina, questo lo sai, e avrai notato che spende uguale che compri agnello o un chilo di patate. Sempre la stessa cifra: dieci euro. Sono i miei soldi, avrai notato, e io lo lascio decurtare per non farlo sentire un fallito: ché non puoi cambiar lavoro all’improvviso: se hai fatto il ladro, a quarant’anni non puoi farti servitore.
terzo giro
Ma tu, onomatopeica zinzala (tardo latino) zanzara che mi arronzi all’orecchio, sai com’è stato l’inizio?
Cerca d’immaginare: quattro per la partita di giorno; quella che è blanda schermaglia, dove in palio la posta è poca, che è più un allenamento di una vera sfida. Niente a che vedere con le guerre di notte dove la veglia è epica e sta a fronte della tua stessa vita; ma il campione è lì che affila la lama: è alla partita di giorno che trova i tempi del bluff e pesa gli sguardi.
Immagina la luce al neon e una finestra, adesso, che fuori è nuvoloso e dentro c’è un bagno di luce azzurrina, come natalizia. Guarda il casaro che s’addanna a portar sigarette controvoglia – se ne starebbe a casa se potesse, ma è questa casa sua – la casa-bisca – e lui la dà per soldi hai giocatori.
Ho due donne e due nove in mano, e ho già fatto lo scarto. E ormai lo so: aspetto la voce di un rilancio per dare fondo ai resti – quando fai i resti, qui, vuol dire che giochi all’ultima lira. Più che un rilancio è una minaccia, irreversibile: il rischio di rovina, di alzarti senza averi, è valore aggiunto: trascende il concetto di denaro: hai dieci e giochi dieci, voglio dire: ultimo sorso d’acqua nel deserto. Se giochi dieci e hai cento, va a sé, non è la stessa cosa – attendo dunque un rilancio per dare la botta dei resti. Avrò duecento euro davanti, e in mano due donne e due nove. Lo so come andranno le cose: so chi ho di fronte: lepri ferite che vogliono perire in fretta o ritornare a casa a raccontare la brutta avventura. Cercando la sfida con me hanno già perso, però, e lo sanno: sapere, non sentire, è la loro natura.
E poi.
E poi un’onda di nausea dal ventre, trapassa la nuca e gira la testa e ridiscende a peso sulle gambe che si afflosciano come lumache.
E cado svenuto.
Questo è l’inizio. Tutto è bloccato in me: sangue, intestini. Si gonfiano le gambe e non sto in piedi, e per quattro giorni svengo di continuo. Poi apro gli occhi e sono in ospedale: surreale corsia di emergenza, quella in cui irrompe il tossico proclamando la strage dei medici.
E infilano il catetere, e l’ago al braccio che porta nel sangue una miscela di …. e … . M’infilano tutto e mi lasciano lì, sulla lettiga, faccia al muro, schivando le domande che pongo su tempi e modi in cui trascorrerà la mia vita. Non danno risposte e sfilano: onde lunghe di camici bianchi, passi, piccole croci d’oro.
Qualcuno l’ha avvertito ed è arrivato in coda al suo lavoro: i nostri conoscenti comuni, probabilmente, o lo stesso casaro leggendo la mia rubrica personale. Non lo vedo da anni, quindici ormai, ma non sembra cambiato: gli stessi occhi scesi un po’ sugli zigomi, i capelli arruffati, la voce e le parole controllate. Si veste da uomo, adesso, non più da ragazzo: giacca pied-de-poule e sciarpa al collo. E ha il passo costruito sicuro, senza inflessione e lungo, quasi un granatiere; e arriva alle spalle come, forse, adesso è abituato.
Sembra sorpreso di vedermi vivo, mio figlio, d’altronde se è qui è perché morivo. Lo sai com’è la prole: non vuol lisciare l’ultima parola per tema di futuri legami non risolti, fantasmi febbrili che mangiano la notte piedi di figlio.
Invero è preoccupato il ragazzo: consulta medici e ferma infermieri. La diagnosi è triste, se lo guardi in faccia: sarà, sarò sul punto di morire.
E a me viene da ridere, e lui va e viene come un gatto nervoso, e tra i tanti si sofferma col medico teen-ager: bambina senza macchia che ha quindic’anni sì e no. Volano alti i due, attorno a frasi in comune: il repertorio dei primi della classe che non fanno copiare. Sprizzano simpatia da tutti i pori, educazione, e sono cortesi e parlano di me come se fossi altrove: una flebite ha messo a rischio la sua vita, dice la dottoressa, e l’ostruzione delle vie urinarie rende necessario il catetere.
Il sangue.
Denso come catrame.
Stenta nelle vie arteriose, venose.
Traffico di rientro a fine estate.
Si rivolgono a me, infine, provando a legiferare sul mio futuro: dovrai stare qui ancora per un po’, fa mio figlio, controllato a vista da un team selezionato, uno staff di medici preparato e pronto ad ogni evenienza. Angeli. Ti spiego: vedi la dottoressa? Ecco: simpatica e carina come lei, l’equipe medica. E avrai che ti serve: pigiama bianco e da mangiare, parole di conforto e il Tavor per dormire: non hai problemi in ospedale, dai retta, è luogo di certezza, tempio di amore e verità: manna dal cielo.
Che stronzo, mio figlio, diciamolo pure: un vero stronzo.
In ogni caso, puoi essere stronzo come ti pare, con me non ce la fai: e faccio uno sforzo e mi metto seduto, uno sforzo ancora e mi rimetto in piedi: sono il ventitre: morto che parla con la flebo al braccio; ma ho capito l’antifona: credono di avermi in pugno – povero vecchio straccione – ma capirai che non mi arrendo: sono come il cinghiale braccato e carico a testa bassa, ma appena mi alzo cado semisvenuto.
Non perdo i sensi e li vedo corrermi incontro. Così mi rialzo, non dico che saltello come Cassius Clay ma mi rialzo. Sfilo l’ago dal braccio e il sangue chiazza i pavimenti e le lenzuola (gocce rapide cadono sulla mia scarpa destra) e poi vado in bagno, passo passo muro muro arrivo al bagno degli uomini.
La dottoressa e mio figlio hanno cercato anche di fermarmi, poverini, ma il mio sguardo è cattivo e loro mi hanno seguito a distanza e una volta arrivati alla porta non hanno varcato la soglia.
Sfilo il catetere di botto, lì dentro, come fa il papà col dente da latte del pupo, o la ragazza che si strappa i peli con l’impiastro caldo di cera. Mi sfilo il catetere ed esco dal bagno piegato di dolore: me ne voglio andare, dico, via dall’ospedale: ché non credo agli angeli in camice bianco né alle piccole croci d’oro, non credo a niente, dico, e bestemmio un pochino.
Mi porto dunque alla porta principale, e dopo sono in strada: traffico e notte, fari senza ordine che bruciano gli occhi. Ho fatto chiamare un taxi a mio figlio che, infine, se ne torna offeso da dove è venuto.
Trascorro una notte di pianto, alla scuola occupata, ché ho nelle viscere guerre di gnomi che pungono con forchette acuminate: la notte non porta consiglio, semmai porta angoscia e pensieri d’insonnia per gli anni a venire. Il dopo è matassa imbrogliata, di notte, e c’è da impazzire se provi a ritrovarne il capo. Così punto tutto sull’alba, sul fatto che arrivi, e quando arriva sono quasi felice (per quanto) e mi faccio tre o quattro minuti di sonno vero.
Il giorno dopo comincia anche lui, coi suoi miasmi; ma non è per l’odore se do a vomitare, è che non spurgo dal culo e in qualche modo pure devo liberarmi. Mi svuoto di tutto e tra tanto perdo il senso delle cose e delle ore, ma esco comunque. Barcollando arrivo in casa-bisca: io, che noleggiavo macchine di lusso per andare a puttane, arrivo in bisca e mi siedo al tavolo piegato su di me e non do spiegazione. Gli altri un po’ mi guardano e un po’ ridacchiano all’inizio, ma poi la cosa si fa seria e Taleb si avvicina e dice di chiamare un dottore.
Col cazzo.
Imponente come nave tra i faraglioni, imperante, lento gigante mi muovo ancora. Sto di nuovo morendo, probabilmente, mentre sono di nuovo per strada. Dietro di me la coda dei bravi a cui ho insegnato il gioco vero, reverenti e gobbi condor chinati: chi muore è un coglione, tutti lo sanno, buono per ridere il giorno dopo.
E poi, improvvisamente, li vedo: mia madre mia moglie mio figlio: vedo il sindacalista che gira come un forsennato, nervoso come un gatto nervoso, che quando è a tiro non ha parole per suo padre; e poi vedo bene mia madre, mai così vicina: un secolo quasi di potente astuzia: cardinalessa in terra infetta: terra pesante che batte su scarpe con fibbie d’oro; abito viola su pelle avvizzita che non riesce a celare l’ardore di una vecchia concubina. E poi vedo mia moglie: lo sguardo umile e impietoso, sorella che condanna i peccati che non è legittimata a perdonare. La mia rispettabile famiglia, in coda tra insetti di bisca – Taleb in testa – e al mio cospetto.
Preparano il campo minato, prima: parole buone su cui potrei cadere se non fossi addestrato: i medici sono brave persone, tutto è chiaro in ospedale e poi ci siamo noi, così per mano, siamo con te e tu non puoi che chiedere, ché noi aneliamo ogni tuo desiderio.
E non mi fanno fesso.
Passano quindi a lanciare ultimatum: se non vai muori, te lo dico; e poi lo sai: che non ti guardi? Che non ti senti sfiancato? Non vedi che sei cosa informe e piagata?
Lo strazio così dura per ore, e se non fosse per tigna gli avrei dato ragione a questi esaltati: ché in effetti son messo maluccio e sento l’amaro del fiele.
Ma resisto un poco, ancora.
Mi godo l’amore di una madre che non si può dire, e quello ansioso del figlio, e l’amore nell’odio della moglie ancora innamorata. E mi godo il figlio acquistato, il marocchino, che mi guarda spaesato com’è lo sguardo di chi non ha paese.
(2 – fine)
___________
Ringrazio Massimiliano Governi per avermi inviato questo racconto.
T. S.
Comments are closed.
Un gran bel racconto. Un raffinatissimo pugno nello stomaco. Davvero complimenti!
Questo racconto ha l’andatura dei passi di mio padre quando si è azzoppato e ha cominciato a camminare per la casa tutto storto. Una strana e asimmetrica scrittura. Complimenti all’autore.