Italville
di Benedetta Centovalli
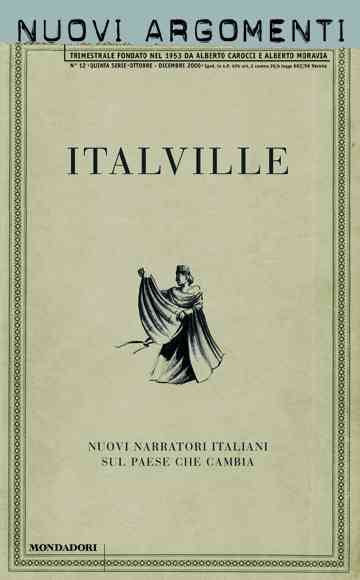
Strano periodo, questo. Si fa un gran parlare di letteratura che non c’è, di intellettuali afasici e vili, di scrittori italiani che non sanno raccontare il paese che muta, che non riescono a stare dentro l’onda di questo cambiamento. Di un paio di mesi fa la provocazione di Mauro Covacich sull’«Espresso», cui hanno fatto seguito risposte sullo stesso settimanale, su quotidiani e in rete. E insieme un fiorire come da tanto tempo non si era visto di raccolte di racconti italiani che lavorano a cancellare questa impressione. E non solo le antologie, certo.
Ognuno potrà declinare a suo piacere la lista di autori su cui scommettere. E questo va bene. Non è dal paragone con le altre letterature che potremo davvero ricavare utili indicazioni sullo stato della nostra narrativa. Serve a qualcosa questo continuo autolesionismo? Vogliamo cominciare a prendere sul serio il nostro lavoro, ciascuno dalla propria postazione? Forse è maturo il tempo che la nostra letteratura cammini sulle proprie gambe, se zoppica tanto meglio, vuol dire che sta imparando. Vorrei soffermarmi sull’ultimo numero di gennaio-marzo 2004 di «Nuovi Argomenti», Italville, che dedica una cospicua sezione della rivista al «confronto dello scrittore con la realtà circostante» attraverso la voce di alcuni giovanissimi narratori, secondo una dichiarazione di intenti di Enzo Siciliano che è anche espressione di una sua personale e sempre perseguita poetica, cioè chiedere alla letteratura di «occuparsi di quei fatti che assediano da vicino l’esistenza quotidiana, e che ci appaiono indecifrabili, lugubremente enigmatici».
Giro d’Italia o meglio Italville, a cura di Mario Desiati e Lorenzo Pavolini, è un vero e proprio libro di racconti che denunciano un paese allo sbando, la realtà difficile e in movimento dell’Italia di oggi vista da una generazione di autori nata tra i Settanta e gli Ottanta con alle spalle un esordio o qualche apparizione collettiva. «Letteratura delle cose» e ricerca sul campo a disegnare un paese forse meno crudele di quello teatrale di Lars von Trier, ma non meno denso di questioni e lacerazioni. Da Gorizia di Flavio Santi a Milano di Igino Domanin, da Torino di Martino Gozzi a Genova di Marco Mantello, giù giù fino a Napoli di Valeria Parrella, a Bari di Massimiliano Zambetta o a Palermo di Vanessa Ambrosecchio, sono quattordici storie di luoghi – città e piccoli centri – che prendono la parola e si raccontano. L’aria comune è quella di testimoniare una cancellazione, un azzeramento di paesaggio e di costume, una mutilazione o una mutazione che possiamo solo registrare, di cui non è dato vedere l’esito finale. Emana da questi racconti un’ansia di dire il presente che ci sfugge e che rischiamo di non riacciuffare, un sommerso che ci salva nello sforzo di catturarne il ricordo. Non saprei dire bene della qualità letteraria dei testi, non era questa l’urgenza nella lettura. Ma funzionano nel denunciare il deficit di memoria che assale il nostro paese, l’Alzheimer che galoppa nelle coscienze di troppi.
Schegge dei nostri giorni e di storia vicina e lontana: le foibe, l’integrazione difficile, Genova e i no-global, cos’è la verità, la provincia ammalata e quella infima, il terremoto in Umbria e la gente nei container, Mussolini e il Terminillo, Pasolini e la lingua di Mike Buongiorno, una zolfatara singolare, via Toledo e Bagnoli dimenticata, il business dei rifiuti tossici, un sud di precariato e di lavoro nero, le gare mortali di velocità tra ragazzi a Paola, la scuola dei più poveri. Come nel bel racconto di Marco Archetti, Brevi agonie sulla strada del ritorno, dove tutto è legato a un sasso che rotola via dall’oblò della lavatrice. Scivolato dalla tasca della camicia di chi narra, mette in moto il ricordo adolescenziale di un’amicizia amorosa nel paese di origine, Fabriano: «Fabriano, per me, vuol dire l’infanzia, tutta intera. Vuol dire mia nonna. Sono cresciuto sulla sponda della sua vestaglia, l’ho veramente adorata. La sera mi portava a dormire mentre tutti gli altri finivano di cenare e si acquietavano a sorsi di rabarbaro, e io stavo lì, sdraiato sotto le coperte, e le guardavo la manica, l’orlo, chiedendomi quanto mancava a una carezza». Poi tornarci un Natale dopo il terremoto, e trovare un mucchio di macerie, sparito anche il muretto dove i due ragazzi si incontravano con gli amici: «Non ho fatto nulla, non ti ho cercato, non mi interessa, va bene così. Ho solo raccolto un sasso e me lo sono messo nella tasca della camicia che avevo su, un sasso e nient’altro, perché forse – forse – è tutto qui».
Così La buca del dollaro di Sara Ventroni racconta quel che rimane di una vecchia zolfatara che somiglia a un campo di sterminio a Manziana, vicino Roma. E di un antro, buco foro o grotta mortale. Tra favola per bambini e riflessione sulle scorciatoie per il «recupero» di aree dismesse come depositi per scorie radioattive.
«L’essenza stessa della storia: acqua e roccia. L’acqua che i fatti fendono e modificano, a volte fino all’umiliazione; la roccia che non muta mai e si oppone ostinata a ogni prevaricazione» è un’immagine di Flavio Santi a cui ci piace affidare anche la nostra idea di letteratura. Scusate se è poco.
Pubblicato su “Stilos”, 23 marzo 2004
Approvo quello che sostieni (eccetto che Busi sia grande e che i canti del Caos siano un capolavoro), però sarebbe interessante discuterne più a fondo. (Su nazioneindiana tra l’altro compare un mio pezzo, archivio gennaio 2004 “Il poema del disoccupato”). Io penso che si debba tornare a parlare di collasso della società letteraria, di neutralizzazione del problema del valore estetico, di derealizzazione delle gerarchie estetiche, anche se gerarchie è una parola un po’ schifosa… Questo pone il dilemma: chi è che crea le liste OGGI? Chi sono invece gli autori veramente esclusi, veramente invisibili, e non quelli che si lagnano dell’invisibilità…
Fammi sapere se ti interessa che continuo…