L’origine del male
di Niccolò Ammaniti
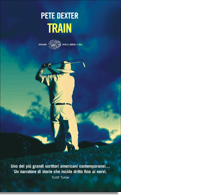 In Train dello scrittore americano Pete Dexter ho trovato un mucchio di cose che mi piacciono: una esaltante descrizione del mondo criminale nella Los Angeles degli anni Cinquanta, una storia d’amore silenziosa, un’amicizia disperata tra un pugile suonato e un caddy e una figura di detective così convincente che mi ha rimesso in pace con la categoria degli investigatori.
In Train dello scrittore americano Pete Dexter ho trovato un mucchio di cose che mi piacciono: una esaltante descrizione del mondo criminale nella Los Angeles degli anni Cinquanta, una storia d’amore silenziosa, un’amicizia disperata tra un pugile suonato e un caddy e una figura di detective così convincente che mi ha rimesso in pace con la categoria degli investigatori.
Da un po’ di tempo ho maturato un forte fastidio verso i detective, i poliziotti, i medici legali, gli antropologi forensi che infestano i gialli e i thriller e in special modo quelli che arrivano dagli Stati Uniti.
Incomincio il romanzo con le migliori intenzioni (aiutato da quarte di copertine che mi assicurano di avere il libro più importante dell’umanità dopo la Bibbia) e mi pianto dopo una trentina di pagine quando mi si para innanzi il detective.
Spesso è un ex poliziotto sfigato. La moglie lo ha lasciato. Qualche anno prima, durante uno scontro a fuoco, per sbaglio, ha accoppato un collega ed è diventato un alcolizzato. Ora tira a campare alla meno peggio con un buco di agenzia che non fa una lira.
Se non è uno sfigato allora è tostissimo, un bastardo corrotto e antipatico senza nessun ideale, che però alla fine ha il cuore tenero e s’innamora di una parente del morto.
Ma tra tutti, quello che non mi scende proprio giù è il detective pigro, pantofolaio, che ama solo il suo cocker, che soffre di problemi alla prostata e pensa soltanto a cucinare manicaretti e a non farsi troppo mettere sotto da una moglie obesa.
E’ sempre più raro trovarne uno che ti intriga. Sono tutti variazioni di una decina di esemplari che vanno dal Maigret di Simenon alla Clarence Starling del Silenzio degli innocenti. Alla fine, forse, quello che mi rimane più simpatico è quel pazzo tossicomane di Sherlock Holmes, che bastonava i cadaveri per scoprire se i lividi si formano anche sui morti.
Certo, oggi, non deve essere per niente facile mettersi lì davanti al tuo computer e concepire un investigatore che non sia zuppa riscaldata, con l’inflazione che ha avuto negli ultimi anni la letteratura gialla.
Se dovessi inventarne uno, sicuro che entrerei in una grave crisi creativa.
Nano. Con sei dita. Con il morbo di Kline-Felter (due cromosomi x e uno y), costruttore di macchinine radiocomandate, con la madre morta in casa…
No, è meglio lasciar perdere.
Il problema è che in un giallo canonico se c’è un mistero ci deve essere pure detective che lo deve risolvere. E’ lui che fa da intermediario tra il lettore e il mondo del crimine. E’ lui che ci guida con la sua morale attraverso le tenebre maligne. E’ lui che scova gli indizi, che spalanca e ci spiega la mente malata dell’assassino e che solleva la terra scoprendo cadaveri putrefatti. E quando finalmente, alla fine del libro, trova il colpevole (e lo trova quasi sempre) lo liquida ristabilendo la giustizia in terra.
La vita reale non è mai così meccanica. Il caso ci mette sempre le mani per scombussolare l’ordine delle cose. E se non è il caso sono le emozioni umani altrettanto imprevedibili.
Quanti omicidi non si sono mai risolti? L’assassino, felice di averla farla franca, rimane coinvolto in un incidente stradale e muore.
Ho amato molto La promessa di Friedrich Dürrenmatt. L’investigatore alla fine del romanzo non riesce a trovare l’omicida di una bambina nonostante la promessa fatta alla madre. Il caso, sembra dirci l’autore svizzero, è il motore di ogni fatto criminale.
Nei gialli, proprio per la sua dipendenza meccanica dal detective, l’assassino non ha vita propria, è solo un sacco pieno di segatura dove il nostro detective scarica le sue frustrazioni, un cruciverba dove esercita le facoltà mentali, in definitiva è uno specchio senz’anima.
E la vittima? E’ quasi sempre solo uno stratagemma narrativo per far scattare la storia e rendere più umano, più profondo il carattere del detective.
Anche per quanto riguarda la trama, lo scrittore di gialli è costretto ad omettere, a rimodellare la storia per arrivare attraverso una serie di colpi di scena che disorientano alla rivelazione finale che dovrebbe lasciare il lettore a bocca aperta. Per questo piacere è disposto a sacrificare la comprensione della mente dell’assassino, la verità, la passione.
Tutta questa mirabile sovrastruttura narrativa ha il solo scopo di tenere nascoste le dinamiche dell’atto criminale alla fine ne svilisce e ne rende astratte le cause.
Quello che invece lo scrittore, libero da espedienti teatrali, deve indagare è l’origine del gesto criminale stesso, deve entrare nella testa del marito geloso che uccide l’amante della moglie. Deve farci identificare con l’adolescente che violenta e finisce a coltellate la compagna di classe e poi, apparentemente tranquillo, va a ballare in discoteca.
Credo che tutti siano più interessati a capire in che modo un gruppo di ragazzotti di Somma Lombardo si trasformino nelle Bestie di Satana e seppelliscano vivi i loro amici, che a seguire il tortuoso percorso che ha portato le forze dell’ordine a scovare la banda satanista.
E’ proprio la ricerca del cause occasionali dell’esplosione del male, l’osservazione etologica dei meccanismi criminali, l’anatomia delle pulsioni umane muovono la penna di Pete Dexter liberando la sua scrittura da strutture preconfezionate e quindi, paradossalmente, a costruire una storia imprevedibile e ricca di atmosfere noir.
Leggendo Train, l’ultimo romanzo di Dexter, ho avuto la sensazione di immergermi proprio all’interno di quel mondo di emarginazione dove il crimine prospera e la violenza insensata può esplodere e colpire chiunque sia nel suo raggio di azione.
Per l’autore americano la violenza è come un organismo primitivo che cresce e si divide in maniera casuale e lentamente copre e inghiottisce ogni cosa.
La storia, ambientata nella Los Angeles degli anni Cinquanta, incomincia su uno yacht ormeggiato a Newport. Dentro c’è un riccone e la sua bella moglie, Norah. L’anziano si eccita facendola andare a letto con due caddy neri che ha rimediato al suo circolo del golf. Uno dei due va fuori di testa e così sparano al capitano, accoltellano il vecchio, violentano la donna e le affettano un capezzolo. Poi, dopo il bagno di sangue, cercano di sparire con lo yacht, ma vengono affrontati da Miller Packard, un detective della polizia che li ammazza.
Niente male come partenza. La lingua è asciutta, scarna, non si perde in chiacchiere, eppure mantiene qualche cosa di lirico che la solleva dal cliché della narrativa hard-boiled.
Dopo questa prima esplosione quasi gratuita che sembra dover indirizzare la narrazione verso latitudini pulp, la storia cambia marcia e si focalizza su tre protagonisti: Il poliziotto Miller Packard che scopriamo essere un grande scommettitore e appassionato di golf; Train, un ragazzino di colore che fa il caddy in un golf club e viene trattato dai giocatori come una specie di schiavo per due dollari al giorno; e la bella vedova Norah Still di cui s’innamora Miller.
Il romanzo, andando avanti, perde qualsiasi impronta di genere, e le sorti di questi tre personaggi così lontani, ma uniti dal caso, s’intrecciano diventando il perno di una storia che racconta l’America degli anni Cinquanta (una lunga parte del libro si sofferma a raccontare che luoghi di abuso fossero i circoli di golf).
Pete Dexter in Italia è quasi sconosciuto (Il cuore nero di Paris Trout è stato pubblicato nei Gialli Mondadori nel 1991, dopo che al cinema era uscito un film tratto dal romanzo con Dennis Hopper, Ed Harris e Barbara Hershey).
Nonostante Dexter venga riconosciuto come uno dei migliori scrittori noir americani contemporanei, su internet non ho trovato granché sulla sua vita.
E’ nato a Pontiac, Michigan, nel 1945. Ha passato gran parte della sua infanzia in Georgia. Suo padre era un insegnante. Si è laureato all’università del Sud Dakota. All’inizio della sua carriera si è arrangiato facendo qualsiasi lavoro gli capitasse, poi ha iniziato a scrivere su alcuni giornali come il Sacramento Bee. Ha scritto cinque romanzi, l’ultimo è Train, che in questi giorni esce in libreria per Einaudi, Stile libero. Lavora anche come sceneggiatore e vive a Sacramento con sua moglie e una figlia.
Train non e’ un giallo, non e’ un noir, e’ un grande atlante che disegna la geografia delle pulsioni umane. Buona lettura.
Pubblicato su Il venerdì di Repubblica, 24 settembre 2004.
______________________________________
Per inserire commenti vai a Archivi per mese – settembre 2004.
Comments are closed.
ho appena finito di leggere “Enigma in luogo di mare” di Fruttero e Lucentini (comprato nell’edizione di Repubblica) ed è stato interessante scoprire che il “Detective” si svela come tale solo verso la fine del libro e -pur essendo uno “sfigato” (in quanto depresso)- possiede una forte dose di ironia, che passa in tutto il libro, e gli dà un tocco di umorismo.
Andrea, e chi se ne fotte!