Giovanni Cossu: il chiodo, lo stivale e Goethe
Quando Franz K. ha deciso di lasciare Nazione Indiana, Giovanni Cossu gli ha dedicato una invettiva che valeva più di ogni ragionamento, riflessione, che pure quella decisione, improvvisa, per molti di noi ingiustificata, aveva provocato.
La voce di Giovanni Cossu trasmetteva infatti una rara forma di energia in cui l’umana incazzatura, nei confronti dell’amico, trascendeva l’umano per diventare qualcosa di naturale. Il processo esattamente agli antipodi di quanto accade quando si umanizzano gli eventi naturali e si dicono banalità del tipo, la furia del fiume, o peggio ancora – lo faceva notare lo scrittore Carlo Grande qualche tempo fa- la montagna assassina. Un fiume non può essere “tranquillo” e, a quanto ne so, nessuna montagna è in grado di di maneggiare un coltello o di impugnare un kalashniikov. Così sono certe voci. Naturali.
Io so che un chiodo nel mio stivale è più raccapricciante della fantasia di Goethe! Vladimir Majakovskij
Io so che quando i nostri scrittori e critici parlano di perdita dell’esperienza, fanno riferimento all’esperienza puramente letteraria ovvero alla capacità di un libro, ai nostri tempi, di trasmettere un’esperienza secondo quanto Walter Benjamin aveva già anticipato in “l’opera d’arte nell’ epoca della sua riproducibilità tecnica” quando analizza la “perdita dell’aura” delle opere d’arte.
Perché io so che l’esperienza del dolore, e la paura ad esso legata, continua a determinare l’esito delle nostre vite, fino a modificarne i percorsi e in taluni casi, il senso stesso delle vite che si vivono. E so che dove c’è esperienza del dolore deve esserci per forza cognizione.
Io so che quando leggo un libro l’unica cosa che chiedo all’autore è di farmi trovare un mondo. In altri termini, oltre alla esperienza che si fa racconto sento come il bisogno di orientarmi, anche a costo di seguire cartine illeggibili o totalmente inventate. 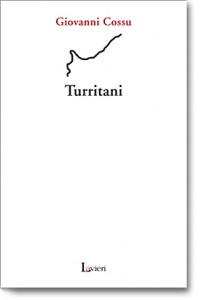
Sulla copertina del libro di Giovanni Cossu c’è una linea che è un profilo di costa tra terra e mare. Terra e Mare di Sardegna. E quando lo apri entri in un mondo che stenti a comprendere all’inizio come la lingua di chi lo abita ovvero gli unici a poterti guidare lungo quella linea di confine, i soli veramente in grado di aprirti un mondo. A farti capire che quella non è una linea ma una cicatrice. Un’esperienza, appunto, una storia.
” senza nemmeno immaginare che quell’episodio sarebbe stato il punto d’inizio di una grave fattura, segnando la sua vita come un presagio”
Arts et mètiers
La storia dei personaggi è essenzialmente una storia dei mestieri che li hanno determinati. Fornaio, scaricatore, barista, scalpellino, fino allo straordinario speaker della tombola sociale della casa del Popolo di un paesino delle Apuane. E oltre ai mestieri che determinano in ognuno dei personaggi le caratteristiche fisiche, l’andatura, i segni al punto di sancirne il soprannome – ovvero il nome al di sopra di tutto – ci sono gli sguardi, le occhiate, le visiere.
A cominciare dall’ “unica voce sembra recitare qualcosa, difficile da capire.” Baciccia, così descritto.
“Non è più giovane. Gli manca un occhio. Come potete osservare ha una palpebra chiusa. È massaggiatore e maestro di pugilato, amante discreto dei giovani allievi.
È anche un grande narratore. Certo il più grande di cui si conserva memoria in paese.”
Personaggio dallo sguardo menomato che incarna nella innaturale solitudine dell’occhio, la doppia identità di Omero e Polifemo. Entrambi ciechi. Perché non è vero che le sole esperienze siano quelle che si vedono. Così come non sono senza importanza le storie delle persone non importanti. Come aveva scritto un altro straordinario narratore dell’isola Sergio Atzeni
“Questo è il compito che si devono assumere gli scrittori piccoli; gli scrittori grandi creano le grandi metafore, i capolavori; gli scrittori piccoli hanno il compito più modesto di raccontare, così come sono capaci, le persone che hanno conosciuto”.
La ferita
“Ce qui peut être coupé, le coupable”
Georges Bataille
“Quando Gio’condo uscì sulla strada, l’orologio segnava le tre e un quarto. Ci furono due impressioni vivaci che gli si gettarono quasi addosso, come fossero state in attesa, la prima già nel momento in cui usciva dalla porta a vetri girevole del caffè, cioè un acuto desiderio di qualcosa di dolce, di
crema o gelato o frittelle o”
A metà libro il manoscritto si interrompe. In verità non lo sapevamo né lo potevamo immaginare che si trattava di un manoscritto. Il libro invece comincia solo a quel punto ovvero al “taglio” , la coupe, l’interrotto. Dicevo, all’inizio del post, del segno topografico in copertina, della cicatrice. Perché ve ne sia una occorre una ferita, un taglio, appunto. In questo caso è l’incursione del narrante nel narrato. Nella lettera che accompagna il manoscritto e le ragioni della sua traduzione, si racconta che, in un dettaglio apparentemente innocuo, una voce ( insisto, voce) di dizionario ” fu proprio quella la fessura attraverso cui si insinuò l’inaspettato.”
La conclusione – ma quando avevamo iniziato veramente?- è di una purezza disarmante, quasi un dispositivo geometrico, un modello matematico.
Una prova, I Turritani, così attesa , e allo stesso tempo, così inaspettata.
Oggi, alle ore 17:00 presso la Libreria Martelli , via Martelli 22r, Firenze
Giancarlo Paba e Simone Siliani presenteranno il libro di Giovanni Cossu “Turritani” (edizioni Lavieri)

Bella lettura. Impressione che ho fatto mia:
“Io so che quando leggo un libro l’unica cosa che chiedo all’autore è di farmi trovare un mondo.”
Entro in uno spazio diverso, in un tempo diverso. Il mondo del libro mi fa attraversare vite diverse. Come nella favola de “La belle au bois dormant”, il tempo della realtà mi aveva addormentata; leggendo la mia vita si sveglia alla luce di un’altra vita, trova il suo cammino.
La cicatrice delinea il passaggio del dolore vivo alla ricomposizione di un paesaggio nuovo, ferito, ma con altro disegno (dessin/dessein).
La scrittura ricama l’orlo di un dolore.
“Sulla copertina di Giovanni Cossu c’è una linea che è un profilo di costa tra terra e mare (…) A farti capire che quella non è linea ma una cicatrice.”
PS Se è pubblicato da Lavieri è un bello invito da leggere.
La perdita dell’aura in molti romanzi italiani deriva dal fatto che molti autori scrivono attingendo a un patrimonio già esistente di letteratura, cinema e televisione. Più rara è la tendenza ad esplorare e trasmettere la propria unicità, il proprio contesto e le radici. Radici non intese come folklore, ma come espressione dei propri strappi e della propria crescita individuale. Per fare questo occorre uno sguardo incandescente e attento sulle cose. A ben guardare, ogni storia è tutte le storie e ogni paese è tutto il mondo.
“Questo è il compito che si devono assumere gli scrittori piccoli; gli scrittori grandi creano le grandi metafore, i capolavori; gli scrittori piccoli hanno il compito più modesto di raccontare, così come sono capaci, le persone che hanno conosciuto”.
Che bello… Grazie, Francesco.
Questo è il compito che si devono assumere gli scrittori piccoli; gli scrittori grandi creano le grandi metafore, i capolavori; gli scrittori piccoli hanno il compito più modesto di raccontare, così come sono capaci, le persone che hanno conosciuto”.
per scoprire le innumerevoli varianti di un gioco di cuori comuni piccoli scintillanti brillii altre forme di vita di lati non sempre oscuri di altre facce di sole di spicchi luna di foglie che comunque si muovono al vento
è veramente bello
grazie effeffe
aspettavo questo libro e mi dispiace molto non essere stata presente alla presentazione e, ancor di più, non aver potuto incontrare Giovanni.
Ho ascoltato con gusto l’invettiva contro Franz, ne ho sentito tutto il sapore dell’amicizia viscerale, quella che ti fa “incazzare” e che si rafforza nell’esplosione dell’ira e nella quiete che ne segue, per- corso naturale, appunto.
Da quel po’ che sento di questo libro e dall’epistolare amicizia che ho con Giovanni, credo che Turritani oltre a raccontare la “cicatrice”, segni quella che io chiamo “linea di demarcazione insulare”, ovvero quello stato ancestralmente radicato, che ti fa essere “isola” ovunque e sempre.
Uno stato di cose che ti appartiene radicato, amato e visceralmente criticato ed odiato, che ti rende diverso, buffo a volte, estraneo, ma che ti costituisce nonostante tutto.
Una bella recensione come questa, Effeffe, non può che accendere ancor più la voglia di possedere l’atteso libro. Tnx.
in bocca al lupo Giovanni.
In bocca al lupo, Soldato Blu!
Avevo dei dubbi su quanto mi era dato di aspettare, prima di ringraziare Francesco per questa bellissima recensione.
Perché i ringraziamenti, nella forma da me immaginata, non mi sembravano all’altezza del dono.
Poi mi sono ricordato che proprio effeffe aveva postato, tempo fa un articolo sul dono.
Il dono, si diceva, deve svolgersi secondo precise regole, se si vuole evitare una corsa al superamento antagonista, che può diventare distruttiva per tutti. Quando si tratta di doni materiali.
Ma quando si tratta di donare amicizia – ho pensato – perché non si può mettere in moto un antagonismo di questo tipo?
Poiché io non ho altro modo di rispondere al dono di Francesco, allora in questo modo cercherò di di superarlo. Aumentando tanto la mia amicizia da fare sì che sia più grande della sua.
Naturalmente ringrazio anche tutti quelli che hanno dimostrato e dimostrano interesse per il mio piccolo libro, in particolare la cara amica Natàlia.
Giovanni Cossu.
venerdì 19 dicembre 2008
il manifesto numero speciale
a 50 euro!
Il 27 agosto del 1950, in una dimessa stanza dell’Hotel Roma di Torino, Cesare Pavese decise di togliersi la vita consegnando alla futura memoria di migliaia di lettori quel solitario e autodistruttivo simulacro che ancora oggi avvolge senza rimedio la sua figura artistica e umana.
Un albergo che esiste tuttora – a due passi dalla stazione ferroviaria Porta Nuova – e che dopo quell’ultimo gesto non ha avuto molte difficoltà a tramutarsi in meta per devoti pellegrinaggi da parte di quanti in Pavese hanno voluto scoprire non solo l’artefice di romanzi e poesie intramontabili, ma anche l’essenza di un disperante e fanciullesco mito della letteratura mondiale. Ed è proprio nel luogo in cui l’autore piemontese si suicidò 58 anni fa che Francesco Forlani immagina l’incontro tra Angelo e François, romantico concierge notturno il primo, ossessivo e scrupoloso scrittore il secondo. I complici destini dei due si incrociano proprio lì, al bancone della stessa reception che più di mezzo secolo prima aveva accolto la firma di Pavese, e che ora insiste a collezionare il solito perpetuo avvicendarsi di viaggiatori senza meta, amanti clandestini, cameriere discrete e tanti altri mostri senza patria né nome. Ne scaturisce un lungo, fitto e altalenante dialogo in cui trovano spazio racconti di vita, sogni infranti, ricordi legati a esistenze errabonde fatte di migrazioni, fughe e segreti nascosti in anfratti oscuri; ma soprattutto, tra una parola e l’altra, continua a insinuarsi l’inquieto spettro di un’anima in pena, l’anima, per l’appunto, di un uomo morto sotto quello stesso tetto molti anni prima. Un uomo che spese ogni energia al servizio della scrittura, della cruciale affezione per le Lettere, e che tuttavia non riuscì a gestire la potenza dei furori amorosi, maligni e impietosi nemici capaci di vanificare un’esistenza in mezzo battito di ciglia. La fallimentare resa di Pavese, a quanto pare, ebbe (anche) un nome di donna, Costance Dowling, ed è dietro questo nome che vollero guadagnare spazio la forma e l’essenza dei suoi fallimenti, della sua morte. E’ il nome dolce e ammaliante dell’attrice americana che lo abbandonò dopo un intenso teatrino seduttivo, e la cui presenza, ai limiti della morbosità, è testimoniata da lettere, versi, e scomposte annotazioni tracciate nel celebre Mestiere di vivere . Impossibile non provare tenerezza di fronte a un sentimento tanto feroce, buio e irrimediabilmente impari, così come appare impensabile l’idea di scindere la costernazione esistenziale di Pavese dal dato biografico, o almeno da ciò che di esso trapela attraverso le cronache più intime e scabrose giunte fino a noi, proprio quei fastidiosi pettegolezzi, per inciso, che vennero chiamati in causa nell’ultimo messaggio d’addio scritto sul frontespizio dei Dialoghi con Leucò . Ma un’ossessione è un’ossessione, e come tale consente licenze che travalicano etica, scrupoli morali e remore, da cui ne consegue la necessità di osservare le cose nel loro complesso: ed è qui che inizia a farsi strada l’inevitabile confronto con gli scomodi scheletri nascosti nell’armadio del nostro anti-eroe, nell’irrefrenabile impulso che costringe i suoi esegeti a seguirne ogni traccia, ogni testimonianza, anche la più piccola, anche la più insignificante. Traccia che, nel caso di Forlani, gioca a esistere e a non esistere traducendosi in qualcosa di più, qualcosa che, almeno in potenza, supererebbe di gran lunga qualunque altro feticcio testimoniante; dettaglio ulteriore, tessera assente, ecco ciò che davvero manca alla ideale biografia di un simbolo eterno: la sua eterea, ultraterrena voce di uomo. Perché in una voce – come annota François a un certo punto – ci sono scariche elettriche, e quel che ti illumina di un discorso è proprio il tono con cui vengono dette le cose. Peccato che Pavese se ne sia andato prima che il progresso sistemasse telecamere in ogni dove, praticamente a due passi dalla nascita della televisione, degli archivi radiofonici e delle infinite tecnologie di incamerazione dati che giusto un attimo dopo iniziarono a proliferare come funghi fino a raggiungere i parossismi informatici dei giorni nostri. Insomma della sua voce pare non esista traccia, e tanto basta per far nascere nel cuore di François l’ansia per una ricerca bulimica e inaudita, con ogni probabilità votata a desolanti rese. Ma è pur vero che cercando qualcosa, alla fine si rischia di trovare altro, e ripercorrere i solchi scavati da una chimerica preda significa in qualche modo sfiorarla, starle comunque vicino, e infine assimilarne i gesti e grazie a loro incontrare nuovi mondi, altri fratelli, insperate amicizie come quella di un portiere notturno rintracciato per caso. Ed è forse questo il senso definitivo dell’oscura indagine disegnata in Autoreverse : comprendere che anche una voce perduta per sempre può ostinarsi a parlarci, a costruire avventure mai esistite, insomma a inventare altri pianeti, altre storie.
Autoreverse
Francesco Forlani,
l’ancora del mediterraneo
pp. 160, euro 13,50
14/12/2008 – “Liberazione”
Solo in ritardo – pensavo che nessuno sarebbe più intervenuto – scopro questa recensione di Giorgio di Costanzo al libro di Francesco Forlani che, nel frattempo, anch’io ho letto.
Niente di più felice poteva capitarmi.
Due libri, sentiti con la medesima intensità – per l’importanza che l’oggetto di cui trattano ha nella vita dei loro autori – uniti nella stessa pagina del blog, Nazione Indiana, che è la loro casa naturale.
Io non saprei dire niente sul libro di Francesco che non sia stato già detto da Giorgio. Non sono capace di sintesi in questo modo superbo.
Me anche per un altro motivo.
Il legame che da decenni mi ha portato a interessarmi di Pavese e, quindi, la spinta ad indagarne i motivi della morte, ha preso strade diverse – partendo comunque dalla convinzione che l'”americana” avesse molto meno importanza di quanto non gliene venga attribuita.
Quando ho cercato di capire sino in fondo cosa abbia potuto pesare in modo decisivo, sulla decisione tragica di Pavese di togliersi la vita, sono rimasto colpito dalle vicende che riguardano la “Collana viola” [CollezionE di Studi REligiosi, etnologici e PSicologici] e portato alla convinzione della grave responsabilità politica e morale dei dirigenti della casa editrice Einaudi e del Partito Comunista.
Molti anni sono passati dal tempo in cui ho abitato a Torino, ma l’accenno alla ricerca della voce di Pavese negli archivi Rai, mi ha richiamato alla mente il mio sconcerto, il mio turbamento, nello scoprire, durante una delle prime passeggiate nel centro di quella città, che la sede della Rai, quella storica il cui indirizzo avevo sempre sentito ricordare dalla voce degli speaker alla radio nella mia adolescenza, era situata a pochi passi dal Cottolengo, un altro mito, ma questo doloroso, il cui ricordo – un racconto di una mia nonna che l’aveva visitato – era rimasto inciso in modo profondo nella mia mente, trovando, in seguito, anche una espressione “alta” nella “Giornata di uno scrutatore” di Calvino.
Sono questi i motivi per cui mai riuscirò a vedere in modo libero quella città. Letteratura e sofferenza, spettacolo e dolore ne costituiscono, per me, l’essenza.