Albacete
di Stefano Gallerani
Poco più che adolescente non trovai di meglio, per costringere mio padre a lasciarmi andar via da quella piccola città, che convincerlo della mia vocazione al sacerdozio. Sul momento, la mia risoluzione non ebbe che l’effetto di scatenare il suo disappunto: pareva volesse strapparmi dall’anima un segreto. A me!, che quell’anima volevo (o dicevo di volere) votare a uno scopo ben maggiore che non fossero gli angusti confini del nostro paesino. Ma niente, lui voleva ugualmente strappare quel germoglio maligno. A sua discolpa, un residuo di obiettività mi impone di precisare alcuni aspetti della mia indole filiale: certe volte riuscivo davvero a essere orribilmente meschino, il che sarebbe stato, però, veramente abietto da parte mia se solo l’abiezione della mia crudeltà, come d’altronde la sporadica magnificenza della mia bontà, non fossero stranamente prive di peso. Non vere. Finte. Irreali (in quanto embrione mi dichiaro innocente sia nella virtù che nel peccato). Fatto sta che per giorni non lo vidi affatto, ma lo sentivo girare e rigirare nella sua camera, meditando a lungo dentro di sé lo scandalo di quel figlio in seminario. Temetti di essere stato un poco avventato e finì che mi stancai presto di quell’inquietudine: mi ero accorto, durante le ore che passavo a origliare alla sua porta, che nella mia vita si era fatto un gran vuoto. Tutti i sentimenti che prima l’affollavano si erano dissolti. Cominciai a giocare, da principio a sere alterne, poi senza soluzione di continuità, dal tramonto all’alba, fino a ciondolare per quel sonno che, una volta coricato, non mi sollevava che a fatica. Il gioco mi distruggeva la salute, e mi odiavo per questo, ma allo stesso tempo non potevo non apprezzare la mia arte alla scacchiera, le mie finte e gli attacchi, eleganti e cariche dell’imprevedibilità del mio estro. La ruota della mia vita sembrava aver trovato il perno intorno al quale girare ed ebbi momenti di autentica felicità.
Ero talmente compreso nel mio ruolo di giocatore che per tutte quelle ore sopportavo anche quanto per me era solitamente insopportabile, ovvero il lambiccato e cencioso gergo mancego di Cide. Attraverso la fitta e soffocante pesantezza di quel linguaggio, traspariva uno spirito grossolanamente borghese (lo stesso che, rivelandosi a tratti, parlava una società volgare e materialista). Ma a quanto pare ero l’unico a nutrire dubbi sui fuochi d’artificio freddi di Cide, sulle pirotecnie verbali di un’intelligenza intelligentemente dotata di intelligenza, sulle piroette di un pensiero retorico e morto, incapace di produrre un’idea veramente vitale e, peraltro, del tutto disinteressato al “vero” pensiero. Insomma, odiavo Cide perché era il mio maestro ed io il migliore dei suoi allievi. Nulla di strano, allora, se in quell’angustia provinciale mi rifugiai tra sessantaquattro caselle di due colori. Che giocassi con minuscoli simulacri lignei. Che passassi ore al tavolo, osservando il mondo allargarsi intorno a me.
Poi venne una notte in cui mi accorsi sul serio che il mio letto era vuoto. Voci sussurravano dietro ai portoncini della corte. Imposte socchiuse venivano spinte di colpo. Della luna, scomparsa ogni traccia di colore. Non restavano, nell’ombra, che i legni inariditi dal sole. Mi irrigidii al pensiero di quella desolazione, ma la mia giovinezza impedì proprio a simili pensieri di mettere a lungo radice in un sangue sempre in fermento. Non avevo la sensazione del tempo che passava… (forse il tempo è soltanto un’illusione dei sensi e noi, vivendo, non facciamo altro che ripetere ciò che è già successo in un’altra misura del mondo o riscoprire ciò che è stabilito definitivamente, nell’eternità). Pian piano abbandonai il tavolo da gioco, sempre più di frequente trasportato da una volontà nemica che inscriveva la mia figura in un mondo dove tutto diventava irreale, vano astratto. Mi creai persino la convinzione che non ero io a decidere – del mio destino di giocatore come di quello di seminarista –, ma che un altro viveva in me; un altro che era me, sebbene del tutto separato dalla mia volontà; un altro che si era insinuato nel mio sangue ed era rinato per mezzo mio: grazie a me recuperato alla vita del corpo per qualche nefanda congiura dell’inferno. Il sovrapporsi delle due immagini annullava la prima impressione di comicità, dando un risultato infinitamente tetro di maschera assurda: orribile imitazione di vita che ci sottrae l’aspetto familiare dal momento in cui cominciamo a subirne il valore umano. E lo stesso poteva dirsi dell’idea che coltivavo della grande metropoli rispetto alla provincia. Mi tornò l’intima convinzione, così profonda e radicata all’epoca in cui leggevo montagne di romanzi metafisici e vedevo chilometri di film d’avventure coloniali allenandomi, come mi sarebbe tornato utile davanti ai piccoli riquadri bianche neri, al calcolo delle probabilità: ciò che fornisce immediatamente ricco combustibile alle fantasticherie ansiose… mi tornò, insomma, il convincimento che non avrei potuto rimanere nella piccola città per ridurmi a vedere solo caprai e processioni religiose tre volte l’anno. D’accordo, non sarei diventato un sacerdote né un soldato né uno studioso, ma avrei scoperto che il fondo della mia anima era triste e inquieto. Mi pareva che la mia vita fosse stata solo un perenne viaggio nell’astrazione e che neppure nel momento in cui tante cose mi si paravano dinnanzi per la prima volta con quella forza, decidendo di andarmene da casa, fossi approdato sulle rive del reale: che in nessun modo, cioè, riuscissi ad aderirvi.
Nei giorni successivi si accentuò, in me, l’idea di vivere in un mondo astratto (il resto, tutto il resto, era un dormiveglia informe, popolato di sogni senza senso). Ogni tanto, dall’acqua morta della mia noia irreale esalava una bolla iridescente che durava un attimo, ma era intensa come un fulmine (non volli mai il sangue). Giorni e notti si succedevano in un’assurda altalena di luci e di ombre. Non c’era nessuna cosa, tranne una, di cui vedendola potessi dire: “è mia, sono nato per essa!”, ma nemmeno quell’una poteva esplicarsi, e quand’anche, non sarebbe servita a niente e a nessuno.
Naturale, dunque, che dopo poco immaginai di essere fuori dal paese, con nessun bagaglio e meno soldi in tasca, frastornato e disorientato perché gli avvenimenti erano stati assai più rapidi delle mie speranze, dei miei segreti pensieri.
Alla fine dell’anno quello scenario fisso cominciò a girare su se stesso. Il tempo s’avvitava e del mondo non si intravedeva quasi nulla, ma provvisoriamente si istituì per la domenica un rito simbolico: commemorazione del paese familiare scomparso, della sua modestia e splendore sostituiti dall’estraneità minacciosa della grande città i cui sinistri personaggi, da tanti anni, ci si ingannava ad imitare perché parevano eleganti. Fu così che le sue pesanti porte mi si chiusero davanti e mi immaginai di nuovo nel suo seno, spaesato ed evanescente quel tanto che bastava perché la vita collettiva mi assorbisse. Divenni infingardo, sia pure studiosissimo, attento anche quando si sarebbe detto che la mia mente divagava. Ripresi a giocare, meno forsennatamente di prima ma ripresi a giocare. Dopo le mosse d’apertura, le caute avvisaglie della battaglia che si sarebbe scatenata di lì a non molto, il mio corpo si trasformava in un asciutto fascio di muscoli, una macchina perfetta, lo strumento divino di un terreno schermidore. Gli avversari non mi bastavano, ma nemmeno mi mancavano. E non è neppure del tutto esatto dire, come feci in più di un’occasione per cavarmi d’impaccio con mia madre, che non potevo tirarmi indietro, che erano gli altri a cercarmi. Solo gli altri. Anch’io avevo ogni tanto da dimostrare qualcosa. Qualcosa che io stesso non avrei saputo dire. Tutto franava e si disfaceva in quella Spagna di sogni e di antiche glorie. Ed io non ero che un’ombra nera che portava la sua disperazione su e giù per i vicoli di una pazzesca città che ingoiava i morti e subito li dimenticava perché come tutte le altre città del mondo aveva mille altre cose da fare.
Tu dimentichi che esiste la donna, finii per ripetermi, la più splendida fra le creature. Roventi pensieri sconvolsero la mia mente. Le giornate, tra una partita e l’altra, erano vuote. Fino a quando, una sera, poco prima della campana di mezzanotte, guardando la corte desolata e pensando a mio padre, a come dovesse passare tristemente la sua vita come un ergastolano nella prigione, fui costretto a sguainare la spada, sommerso da un’onda di energia che dormiva in qualche misterioso angolo, uno dei tanti che formano quel mistero più vasto che siamo noi stessi… (ma conosco troppo bene questa malattia dell’immaginazione per non sapere che le sue aggressioni non vanno contrastate)
_____________________
Rileggendo questi appunti di diario ho misurato come il tempo sembrasse ristagnare senza termine in un torbido, meccanico ingigantimento del malessere. Oggi, che i passi di mia madre risuonano circondati di vuoto nei grandi saloni silenziosi, oggi trascorro molto tempo, quasi tutto del molto che ho a disposizione, nello studio di mio padre, a leggere i libri della sua biblioteca e a riorganizzare gli scarabocchi insensati di Cide (la biblioteca che mi si adatta ora perfettamente, arida e irreale come il mio spirito). Tutta la mia vita non mi si presenta che come un perenne viaggio nell’astrazione, e neppure dopo il mio definitivo insediamento a casa mi sembra di essere approdato su quelle famose rive del reale. Il caso, dopo avermi allontanato per anni dal pensiero di questa vita, mi ha ricondotto un’ultima volta alla mia infanzia: dove non avevo più avuto voglia di tornare e quanto mi provocava un senso di fastidio pari almeno al compiacimento amaro che mi dà il non aver avuto figli, il solo sapere che il mio nome finirà con me…
________________________
Ieri mattina ho trovato casualmente, dentro un cassetto, un fascio di lettere, lettere d’amore di… lettere d’amore, e basta. Lì per lì sono stato preso dal furore, poi la coscienza ha avuto il sopravvento. Ho firmato le lettere e le ho bruciate.
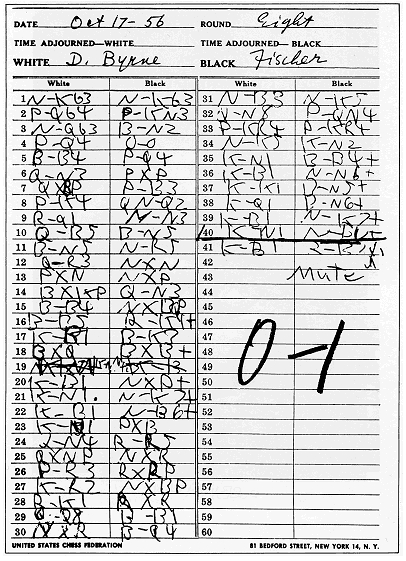
difficile respirare durante la lettura; testo bello e teso, ma senza speranze, ahimè, desolato al punto di firmare le lettere prima di bruciarle.