Altai. Tra romanzo ed epopea
[come mi viene fatto notare nel primo commento, conviene che io avvisi il lettore con un “Attenzione SPOILER”. Io, tra l’altro, non ho ancora iniziato il romanzo, ma sono certo che me lo godrò lo stesso. G.B.]
Un romanzo storico
Altai. Ovvero, il Mediterraneo alla vigilia della battaglia di Lepanto.
Per epoca ed ambientazione, l’ultimo romanzo di Wu Ming si colloca a metà strada tra il lontano “Q” (a quei tempi il collettivo di scrittura si firmava “Luther Blissett”) e il recente “Manituana”, nel tentativo evidente di rendere esplicito un senso storico della modernità, illuminandone episodi talmente significativi da costituirne la contrazione allegorica. È questo percorso, e la filosofia della storia che lo sottende che fanno dei romanzi di Wu Ming qualcosa di più che pregevoli occasioni narrative: si tratta di finzioni letterarie che rivelano in filigrana, per chi sollevi e guardi in controluce, l’intento speculativo e l’operazione colta, senza che questo impedisca al lettore medio di abbandonarsi al romanzesco in quanto tale. È comunque anche alla luce di queste ambizioni di secondo livello che ognuno di essi va collocato e giudicato, il che proverò a fare.
Ma cominciamo dal soggetto. Manuel Cardoso, di madre ebrea e padre veneziano, ha da tempo rinnegato la sua appartenenza al popolo della diaspora ed è un efficiente e stimato membro di quello che oggi si chiamerebbe “il servizio segreto” della Serenissima, impegnato a smascherare le trame dell’avversario tradizionale, l’Impero Ottomano, e in particolare di Giuseppe Nasi, un ricco banchiere ebreo favorito del sultano, i cui oscuri disegni sembrano andare oltre le mire espansionistiche della mezzaluna. Un improvviso incendio all’Arsenale, la ricerca del colpevole ideale (chi meglio di un ebreo rinnegato, che per giunta sta diventando troppo potente?) ed ecco che la condizione di Cardoso si capovolge da inquisitore ad inquisito. Manuel riesce a fuggire un attimo prima dell’arresto, ma scoprirà che a trarlo in salvo e a condurlo fino a Costantinopoli sono proprio emissari del suo acerrimo nemico e connazionale, Giuseppe Nasi il quale, una volta giunto in sua presenza, riuscirà a conquistarne la fiducia e l’entusiastica adesione al suo progetto: impadronirsi con la forza delle armate turche dell’isola di Cipro, e farne il rifugio per il popolo ebreo disperso e per tutti i transfughi e i perseguitati d’Europa. In questo si ritrova affiancato ad un anziano amico di Nasi, uomo dalle molte storie e dai molti nomi, il quale non è altri che lo scampato al disastro della rivoluzione anabattista e alla caduta della libera città di Munster, già raccontata in “Q” (ecco il collegamento tra i due romanzi). Cardoso, che ha ritrovato un’identità e un sogno, assisterà sgomento alla carneficina e alle crudeltà gratuite seguite alla presa dell’ultima roccaforte cipriota di Famagosta. A seguito della controffensiva cristiana culminata nella battaglia di Lepanto (1571), verrà catturato e condannato a morte dai veneziani prima di scoprire che Nasi ha ormai perduto il suo ascendente sul Sultano e il suo sogno proto-sionista di una patria per il popolo ebraico è miseramente infranto.
Diciamo subito che Altai è il migliore dei romanzi storici di Wu Ming. Avvincente e serrato nel ritmo narrativo, sontuoso nell’ambientazione e ferocemente carnale nell’umanità rappresentata, capace di restituire psicologie complesse che vanno ben oltre il puro e semplice “carattere” e splendidi personaggi femminili (di cui ho volutamente omesso di parlare nella sintesi) che incarnano il fulcro sapienziale della vicenda, ovvero il centro che catalizza gli eventi senza apertamente manifestarsi, quel “femminile” metafisico di cui la cultura femminista ha fatto scempio ma che il narratore di razza ritrova sulla sua strada una volta liberatosi da ipoteche ideologiche.
Del pari, l’elemento religioso vi è presente come l’anima segreta dell’agire politico e, a differenza di quanto accadeva in “Q”, la componente mistica e quella tradizionale- istituzionale del fenomeno religioso non vengono esibite come contraddittorie e incompatibili, il che faceva di quel romanzo un buon fumettone complottardo ma senza vera aderenza al dato antropologico, e quindi senza la profondità che la rappresentazione storica si merita. È vero che tutto questo veniva superato in “Manituana”, in cui la terza dimensione dello spirito dava sostanza e superava la sterile dialettica ideologica (colonialismo sì o no, globalismo sì o no, ateismo sì o no), ma qui la narrazione presentava qualche discontinuità e soprattutto l’inizio risentiva della mancanza di una focalizzazione decisiva su un protagonista, per rendere credibile la voce narrante.
Altai è un romanzo ben riuscito, dunque, ma il motivo per cui esso è un vero romanzo storico (per intenderci, qualcosa che è agli antipodi degli Aristotele o dei Dante detectives) va cercato più a fondo, e precisamente nella capacità che il romanzo storico ha di includere l’orizzonte intemporale dell’epos nella cronaca dei fatti narrati, i quali risulteranno non interamente assorbibili dal presente mobile e onnivoro del lettore, ma allusivi di ciò che nel futuro lo attende come un destino.
Epos e romanzo
La distinzione che Bachtin pone tra i generi classici (tra cui l’epica) e il romanzo, è di quelle capaci di ristrutturare interamente la visione della storia letteraria. Il romanzo non si aggiunge ai generi classici ma tende piuttosto a sostituirli inglobandoli in maniera rappresentativa o parodistica. Esso infatti porta con sé la coscienza temporale di un’umanità nuova, l’umanità storica, per la quale il riferimento all’universo compiuto e concluso dei generi “alti” è ormai impraticabile, psicologicamente inaccessibile:
“Il romanzo non è semplicemente un genere letterario tra gli altri. È l’unico genere in divenire tra generi da tempo compiuti e in parte già morti. È l’unico genere procreato e nutrito dall’epoca moderna della storia universale e perciò ad essa profondamente affine, mentre gli altri grandi generi sono stati ricevuti da essa in eredità in forma compiuta e non fanno che adattarsi – chi meglio, chi peggio – alle nuove condizioni di esistenza. In confronto ad essi il romanzo è un essere di un’altra razza. Convive male con gli altri generi. Lotta per il suo dominio nella letteratura e, dove vince, gli altri vecchi generi letterari si disgregano.” (Questa e le seguenti citazioni di Bachtin sono tratte da “Epos e romanzo”, in “Estetica e romanzo”, Einaudi editore.)
La misura più evidente di tale incompatibilità è data proprio dalla distanza siderale tra il cantore e la propria materia epica da un lato, e dalla contemporaneità del narratore ai fatti romanzati dall’altro, quand’anche i fatti fossero riferiti ad una cronologia lontanissima dalla propria: il punto decisivo non è nel contenuto del racconto ma nell’a priori da cui nasce l’esigenza di raccontare:
“L’epopea non è stata mai un poema sul presente, sul proprio tempo (diventando solo per i posteri un poema sul passato). L’epopea, come determinato genere letterario a noi noto, è stata fin dal principio poema sul passato, e l’atteggiamento dell’autore (cioè di chi pronuncia la parola epica), immanente all’epopea e costitutivo per essa, è quello di un uomo che parla di un passato per lui inaccessibile, l’atteggiamento pieno di venerazione di un postero. La parola epica per il suo stile, per il tono e il carattere del suo sistema d’immagini è infinitamente lontana dalla parola di un contemporaneo che parli a un contemporaneo, rivolgendosi a contemporanei.”
Il narratore del romanzo è la coscienza onnivora e inquieta che tutto assorbe nella plausibilità della propria esperienza e del proprio ambiente culturale e linguistico, liberamente impegnato a farne materia per la propria tensione esistenziale. Il cantore epico somiglia piuttosto a un navigante che si rapporta alla fissità della Stella Polare:
“La parola epica è parola fondata sulla tradizione. Il mondo epico del passato assoluto per sua natura è inaccessibile all’esperienza personale e non ammette un punto di vista e una valutazione personali. Non lo si può vedere, palpare, toccare, non lo si può guardare da qualsiasi punto di vista, non lo si può provare, analizzare, scomporre, penetrare. Esso è dato soltanto come tradizione, sacra e incontestabile, che comporta una valutazione universale ed esige per sé un atteggiamento rispettoso.”
Eppure, questo carattere compiuto e monumentale, che a noi moderni appare l’antitesi dello storico e coincide con il mitico, è un elemento essenziale della comprensione storica, ciò che impedisce alla storia di diventare quella sequenza inintelligibile di fatti che somiglia tanto alla brutta favola raccontata da un idiota di cui parlava Shakespeare. Se l’intemporale è inaccessibile e storicamente incredibile, è pur vero che dal riferimento ad esso gli uomini hanno tratto sogni e speranze che ne hanno orientato e tuttora ne orientano la direzione. E proprio perché la narrazione storica è oggi monopolizzata dal positivismo invertebrato degli archivisti, diciamo volentieri con Bachtin che:
“La raffigurazione veramente oggettiva del passato come passato è possibile soltanto nel romanzo. L’età contemporanea con la sua nuova esperienza resta nella forma stessa della visione, nella profondità, nell’acutezza, nella vastità e nella vivacità di questa visione, ma essa non deve afffatto penetrare nel contenuto raffigurato come forza che modernizza e deforma l’originalità del passato. Ogni grande e seria età contemporanea, infatti, ha bisogno di un sembiante autentico del passato, dell’autentica lingua estranea di un tempo estraneo”.
Attenzione: non si tratta solo di un’esigenza culturale, cioè di qualcosa che riguardi la pura e semplice rappresentazione di sé da parte dell’uomo moderno (insomma, della “sovrastruttura” in senso marxiano). Qui è in gioco la stessa possibilità dell’agire storico, la preservazione di ciò che è umano e civile: o non è abbastanza evidente che proprio l’immanentizzazione totale dell’universo nei media, l’assorbimento del passato e del futuro in un blob mostruosamente tollerante e sorridente è ciò che tutti noi avvertiamo oggi come una barbarie perfino peggiore delle antiche divisioni?
Come scriveva Ernst Junger: “Il mondo delle immagini mitiche è presente: per questo motivo misconoscerlo, bandirlo, conduce solo a un accumulo crescente e alla rottura, infine, degli argini. Questo mondo va quindi custodito all’interno della civiltà; anzi, la civiltà stessa è possibile solo là dove vi è posto per tale forma di custodia. Il mitico deve possedere il suo luogo peculiare nello spazio storico, la sua peculiare rotazione nel tempo storico”. (da: “Al muro del tempo”, Adelphi editore)
L’epopea dei vinti
Torniamo a Wu Ming e alla serie di romanzi storici di cui “Altai” è l’ultimo nato. Che cosa c’è in comune tra “Q”, “Manituana” e “Altai”? In ognuno di essi si racconta di un’utopia sconfitta: la rivolta anabattista e il tentativo di fare della città di Munster una Gerusalemme celeste, la federazione irochese dilaniata dagli interessi contrastanti delle potenze coloniali, il sogno di fare di Cipro una patria per gli ebrei della diaspora e per i perseguitati di ogni dove. In tutti e tre i casi (ma con crescente maturità storica e letteraria) la componente mistica di queste tre visioni è crudelmente smentita dal trionfo della violenza e dall’immarcescibile efficacia del potere, e in questo si assolve compiutamente la vocazione della narrazione storico-romanzesca.
Eppure i conti non tornano, il gioco non è mai a somma zero. C’è un resto ineliminabile, ed è costituito dall’intemporale e dunque epica persistenza della visione di una comunità compiuta, sempre più consapevolmente trasposta nel futuro piuttosto che relegata all’eden di un passato immemoriale e, in Altai, garantita dalla sopravvivenza di un reduce che non mancherà di avere dei “figli spirituali”, eredi di null’altro patrimonio che quello della trascendenza. Trascendenza dell’epos sul romanzo, certo, ma anche, aggiungerei, trascendenza dello spirito sullo sfacelo della carne e sulle macerie fumanti della battaglia perduta, trascendenza dell’allegoria sulla nuda brutalità dei fatti, come un enigma ancora da decifrare eppure remotamente intuito, che reclama nuova comprensione. Per questo ogni conversione in realtà è un ritorno all’origine, e a venirci incontro da ciò che appare come futuro è il passato ancora inespresso, non l’eterno ritorno dell’uguale.
La fondazione da parte dei reduci di un disastro, cioè da parte dell’eroe sconfitto il cui archetipo occidentale è Enea, fa grande la nuova polis, purchè il dolore sappia farsi sacrificio e fecondità, purchè sia memore, purchè la fondazione sia un trapianto più che la pretesa della palingenesi totale. Se il tempo non è un girare a vuoto, qualcosa della città distrutta sopravvive nella nuova, come un tempo si custodiva la lievitina per dare vitalità ad ogni impasto nuovo, o come la vite trae origine dall’unico antico ceppo. Come aveva già notato Chesterton, non è un caso se con Enea, fuggitivo da una patria distrutta, “Virgilio iniziò quel ciclo troiano che riempie tutta la storia medioevale e moderna. Ne abbiam già visto un primo accenno nel pathos di Omero intorno alla figura di Ettore. Ma Virgilio seppe, dal campo dell’arte, portare Troia nella leggenda: la leggenda della dignità quasi divina che appartiene ai vinti. È questa una delle tradizioni che prepararono il mondo alla venuta del Cristianesimo e della cavalleria cristiana. Fu questa tradizione che sostenne la civiltà nelle incessanti sconfitte delle Età oscure e delle guerre barbariche; da essa è nata la cavalleria. La quale non è che l’atteggiamento morale dell’uomo con le spalle al muro, il muro di Troia”. (da: “L’uomo eterno”, Rubettino editore).
Ho bisogno di aggiungere che di questa letteratura abbiamo bisogno, non solo più di quanto serva al diletto dell’anima il puro e semplice intrattenimento, ma anche più del raffinato solipsismo minimalista che fa dei sommovimenti intestinali dell’io narrante la misura del mondo e delle cose?
Come ho scritto tempo fa, non mi era piaciuta la macchina situazional-promozionale con cui Luther Blissett-Wu Ming hanno annunciato al mondo la loro esistenza letteraria prima ancora di dimostrarla, ma alla resa dei conti devo ammettere che in questa impresa collettiva c’è molta sostanza, e oggi come oggi seguo con interesse quello che ne deriva: il loro è tra i pochi progetti letterari che realmente reclamino il futuro, nel desolante mordi-e-fuggi che è diventata la cultura in questo povero paese di vincitori senza dignità e di reduci che non hanno mai pagato il prezzo della sconfitta.
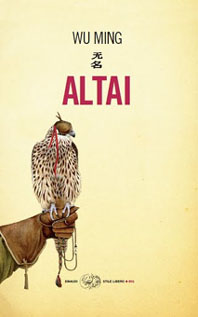
Potevate anche mettere un “Attenzione SPOILER” all’inizio del post! Binaghi racconta subito TUTTA la trama fino alla fine.
L’altro giorno mi è capitato tra le mani un romanzone che si intitola Lettere al califfo. Senza offesa, non mi sarebbe mai venuto in mente di considerarlo “letteratura”, tutt’al più fiction, ma visto che è un romanzo, adesso penso a Bachtin e gli cambio status.
Alcor, ma tu queste considerazioni le fai sempre a partire dalla copertina?
Pre-veggenza o pre-giudizio?
Le faccio avendo già letto, non questo, che non leggerò.
Ma tu hai ragione, adesso tutto è letteratura. E chiunque scriva è un autore. Non capisco perché mi ostino. Farò autoanalisi.
[…] Qui sotto ne riportiamo alcuni stralci, invitando solo chi ha terminato il romanzo a leggere la versione integrale, che contiene molte anticipazioni sulla trama e sul […]
[…] a leggere su Nazione Indiana Lascia un […]
[…] Fonte: Altai. Tra romanzo ed epopea – Nazione Indiana […]
Complimenti per l’intervento ben più che interessante, anche se mi pare che l’epica di Wu Ming si contrapponga nettamente alla visione dell’epica come “passato assoluto” in Bachtin.
Ovviamente questa contrapposizione si compie aggiornandosi, senza l’hegelismo di Lukacs, ma credendo molto nel protestismo di McLuhan. Che si lega a sua volta ad Havelock sulla questione dell’epica come enciclopedia tribale. Wu Ming sarebbero forse d’accordo nel definire la loro epica come tentativo di un’enciclopedia neotribale.
Si tratterebbe poi di discutere sulle tre note radici bachtiniane del romanzo: l’epica, la retorica e la parodia. Ma qui si apre la voragine del parodico, già affrontata dal loro saggio, e, a mio avviso, irrisolta. O forse, perché no, bisognerebbe accettare quel passato assoluto come già compromesso, raddoppiato, tra epica monologica e epica parodica, Odissea e Batracomiomachia.
saluti,
a.
“Ovviamente questa contrapposizione si compie aggiornandosi, senza l’hegelismo di Lukacs, ma credendo molto nel protestismo di McLuhan. Che si lega a sua volta ad Havelock sulla questione dell’epica come enciclopedia tribale.”
sotto-scrivo in pieno, cazzo.
Pardon, è “protesismo” il termine esatto.
Aspetto che Roberto (Bui) risponda alla mia sollecitazione! :D
«quel “femminile” metafisico di cui la cultura femminista ha fatto scempio ma che il narratore di razza ritrova sulla sua strada una volta liberatosi da ipoteche ideologiche»
rileggendo stento a credere ai miei occhi! mi chiedo se nell’immaginario di certi uomini rimanga latente il desiderio di eliminare tutta la “razza” femminile relegandola a una sfera rigorosamente e per definizione “oltre” (e fuori da) ogni realtà.
bah!
@ tina:
ne stiamo parlando qui, vieni a dare un’occhiata se ti va:
http://www.wumingfoundation.com/italiano/Altai/?p=193
Nastasi, mi sa che hai qualche problema con la metafisica. L’aggettivo non significa irreale o fuori dal reale ma talmente reale da essere onnipresente, purchè si guardino le cose in profondità e non solo in superficie.
Mi piace Binaghi perchè é il contraltare coraggioso di tante idee, ad esempio di quelle dei Wu Ming.
Trovai Q sul tavolo di un redattore di Amsterdam. Uno dei piú bei romanzi mai letti.
@wu ming 1
grazie mille: ho letto con molto piacere