Femmes sans frontières

La frontiera delle donne 1.
di
Camilla Panhard
traduzione di Francesca Spinelli
Tapachula (Chiapas)
Due ragazze fissano in silenzio la mappa stradale del Messico : “Tapachula-Houston 2.900 chilometri”, dice la legenda. Sono entrambe minute, il cartello con la mappa le sovrasta. Come se, attraversando il fiume Suchiate, che separa il Guatemala dal Messico, fossero rimpiccolite. Una delle due è leggermente china in avanti. L’altra mi risponde di sì quando le chiedo se sono state aggredite. Appena un’ora fa. Avevano svoltato subito prima di El Silencio, una piccola frazione, per aggirare il primo posto di frontiera. È stata la loro prima aggressione. A ogni svolta, le aspetteranno banditi armati di machete, kalashnikov o pistole scalcinate.
Le due giovani si preparano ad aggirare la prossima garitta, che si trova nel quartiere di Viva México a Tapachula, capoluogo meridionale dello stato messicano del Chiapas. Un ragazzo in bicicletta si ferma per indicargli la strada, ma ci ripensa subito e gli consiglia di rinunciare.
“Te l’avevo detto”, sospira una delle due.
“Dai, andiamo”, incalza l’altra.
“Siete coraggiose”, mi limito a osservare.
“No, io no! Io no!”, riprende la più piccola, portandosi la mano alla bocca.
“Ha perso la verginità su queste strade. Non c’è bisogno di andare lontano per farsi stuprare”, spiega la compagna di viaggio, mentre l’altra arrossisce.
Si chiama Griselda e ha aspettato di compiere diciott’anni per lasciare l’Honduras. È partita da sola. Subito dopo aver varcato la frontiera del Messico, l’ha violentata un tipo che si era presentato come trafficante di persone. Per un pelo non è finita in uno dei bordelli di frontiera. Poi il suo cammino ha incrociato quello di Yohanna. Originaria di Città del Guatemala, 27 anni, la più anziana ha una forza d’animo straordinaria.
Da qualche anno i banditi invece delle aggressioni a mano armata preferiscono il sequestro, che è più redditizio. E hanno moltiplicato i profitti grazie alle migranti. Prima le costringono a fare dei film porno. Poi a prostituirsi. A quel punto chiedono ai familiari una somma per spedirle negli Stati Uniti. Arrivate a destinazione, sono consegnate a un bordello: finiscono per pagare loro stesse il riscatto per la liberazione.
Approfittando di un momento in cui la sua compagna si è allontanata, Yohanna sussurra: “Bisogna aiutarla, è molto povera. Sai da dove viene? Da una capanna fatta di foglie di palma. Non aveva un letto, non aveva mai visto un ventilatore”.
“Svegliati, mamita…”
Alcuni preti cattolici hanno aperto dei rifugi per aiutare i migranti dandogli una zuppa e un letto. Qui s’incrociano l’informatico di Tegucigalpa, l’adolescente di San Salvador e il pescatore della costa caraibica, spinti a partire dai debiti, dalla violenza e dalla fame. Rischiando la pelle, laici e religiosi si battono perché le mafie e le autorità non mettano le mani su questi posti, simili a bandiere bianche su un campo di battaglia. Perché quella in corso è una guerra.
Nei dormitori dei rifugi nessuno dorme.
Alleanze si stringono e si sciolgono in vista della prossima battaglia. In base al regolamento non si può restare più di tre notti: trovare un altro letto con gli aguzzini alla porta crea una tensione devastante.
Prima di svenire, Kristin ha urlato. Ha appena saputo che non le saranno versati i soldi che aspettava per raggiungere gli Stati Uniti. Tra qualche ora i suoi compagni di viaggio partiranno senza di lei. Si troverà sola, abbandonata nell’“imbuto della morte”, come i migranti hanno ribattezzato questa zona. “Dài, mamita, svegliati!”. La donna più grande prende in mano la situazione. Ha lasciato in Guatemala le sue gemelle, che hanno la stessa età di Kristin, 19 anni. “Svegliati, mamita”, le dice, dandole degli schiaffetti sulle guance mentre un’altra avvicina un ventilatore. Al segnale di partenza il piccolo gruppo, rimasto unito fino a qui, si disperderà. Chiedo perché non torna a casa, finché non trova nuovi appoggi. “È scappata, è stata minacciata di morte. Non credo che possa”, bisbiglia una ragazza. Quale violenza l’ha cacciata dal suo paese? Quella della sua famiglia o quella delle maras, le gang che terrorizzano l’America Centrale? Kristin avrebbe potuto chiedere asilo politico?
In questa situazione, dove nessun medico accorrerà in suo aiuto, le domande sono fuori luogo. “Sto cercando di contattare l’unico dottore disposto a lavorare con noi, ma non risponde”, spiega il ragazzo di guardia stasera. “Quelli dell’immigrazione non ne possono più!”, esclama M. Mack, un altro volontario del rifugio, di origine cinese. “Non ne possono più”, ripete, alludendo alle donne, che secondo lui usano il loro corpo come passaporto. Gli ricordo le aggressioni, gli stupri, la tratta. “E allora che restino a casa loro. Non si muore di fame in America. Hai visto quei rami carichi di manghi?”.
I manghi mi ricordano Yolanda, la prima migrante che ho incontrato su queste strade. Una donna di cinquant’anni, stuprata e poi gettata per strada da una macchina a mezzanotte. Dopo essersi asciugata gli occhi, aveva voluto portare avanti il suo racconto, oltre l’orrore: “Subito dopo ho incontrato un uomo. Era in macchina e si è offerto di accompagnarmi dove volevo. Si è perfino scusato di non potermi invitare a cena. ‘Non posso fermarmi, sono un rappresentante di commercio’, mi ha detto, e poi mi ha offerto due manghi”.
Il mango, per me, è il frutto più sensuale che ci sia. Immagino Yolanda che lo assapora, ritrovando il gusto della vita o, almeno, le forze necessarie per rimettersi in strada. Da sola.
Le donne migranti sono le viaggiatrici più coraggiose.
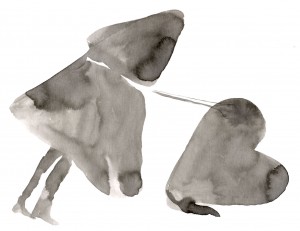
Arriaga (Chiapas)
Ha percorso quasi 270 chilometri a piedi dalla frontiera tra Guatemala e Messico per raggiungere Arriaga, un borgo della costa del Pacifico. Parliamo sedendo sul bordo di un materasso, nel dormitorio femminile del rifugio Hogar de la misericordia, a Playa Fina. Con il suo aspetto androgino e i lunghi capelli legati da un fermaglio di plastica gialla, potrebbe essere un parrucchiere o un massaggiatore. È molto popolare tra le viaggiatrici: si aspettano che con il suo tocco magico trasformi questa cella di cemento in un salone di bellezza. “Mi fai un massaggio?”, chiede una ragazza. La nostra conversazione sarà più volte interrotta da questa domanda assurda. È l’unico che accetta di raccontarmi il suo passaggio a La Arrocera, un paesino vicino a un posto di frontiera, una delle tappe più pericolose di questa traversata del Messico. Per evitare il blocco, i migranti devono allungare la strada di una ventina di chilometri. Sulle scorciatoie le aggressioni sono frequenti. I banditi hanno costruito delle postazioni tra l’erba o sugli alberi, e da lì aspettano le loro prede. Descrive i mille altri paesini attraversati, simili a questo: “Case piccole, tutte con le porte sbarrate. L’unica aperta è quella di un alimentari dove vendono solo patatine e Coca-Cola”. Voleva solo camminare. Dopo una settimana di corsa folle, le gambe andavano avanti da sole, come isteriche. Era impossibile fermarle. Si era seduto un momento su una panchina. Aveva passato giorni interi nella giungla, sussultando al minimo fruscio. Quella volta, però, non ha sentito i cinque tizi – capelli lunghi, armi d’assalto, scarponi e uniformi militari – che l’hanno assalito. “Come in un film”, dice. “Un solo sguardo e ti spacco la testa”, l’ha minacciato uno degli aggressori. Lui ha abbassato gli occhi. Ha visto i resti umani per terra, una donna legata a un albero. Gli hanno ispezionato i testicoli e l’ano per trovare i soldi. Uno dei tizi ha immerso i suoi pantaloni nel fango, poi gli ha fatto cenno di rivestirsi. Lo stesso, con le unghie nere, gli ha dato sghignazzando un biglietto da cinque pesos: “Per il trasporto”. Mentre racconta, il massaggiatore imita spesso quella risata. “Avevo mille pesos, sono passato. La ragazza no. Bisogna essere pazzi per fare quella strada senza soldi. Mi aveva detto: ‘Sono nelle mani di Dio’. È rimasta con noi finché ha potuto. Le avevo dato da mangiare, anche da bere. Alcune vanno a letto con chiunque solo per questo, un sorso d’acqua, una tortilla. Che tristezza, eh? Pure lei, però. Nelle mani di Dio… Che c’aveva in testa?”. “E voi?”, dice a due ragazze stese su un letto a castello. “Non mi direte che con voi sono stati galanti”. Ha un tono antipatico, le ragazze chinano lo sguardo. Con un gesto affettato si toglie il fermaglio di plastica e si scioglie i capelli, neri, folti, che gli arrivano fino al sedere. Poi annuncia che se ne andrà, questo posto non gli piace.
Gli chiedo di restare per parlarmi della sua vita nel Salvador, dov’era fioraio e si occupava di cinque bambini: la sorella piccola e quattro maschietti che gli erano stati affidati. “Gli affari andavano benissimo. Ricevevo ordini perfino dal Guatemala, attraversavo la frontiera pieno di pacchetti di banconote. Non ho mai avuto problemi di soldi, neanche ora. Sono partito per raggiungere mia madre negli Stati Uniti. È malata e devo sostituirla al lavoro. Mi paga lei il viaggio. Ovunque vada, c’è un versamento che mi aspetta. Devo solo trovare uno sportello Western Union”. Quando si alza, lo afferro per la spalla: “Non dire a nessuno che hai dei soldi. I muri hanno le orecchie, diventeresti un bersaglio per i sequestratori”. La spalla s’irrigidisce, mi sorprende scoprire che può essere espressiva quanto una mano. “Stai tranquilla. Mi protegge una maras”, risponde. Il suo tono mi sembra minaccioso. Ho appena fatto un errore: sparare consigli alla cieca. Già due volte mi è capitato di mettere in guardia qualcuno contro i trafficanti di esseri umani, senza rendermi conto che stavo parlando con uno di loro.
Per sopravvivere sulle rotte della migrazione bisogna agire come spie. Nei rifugi i telefoni sono sotto controllo e i migranti parlano in codice. La mia strategia: non rispettare mai i miei appuntamenti. Arrivo sempre a un’ora o in un giorno diversi da quelli annunciati.
Una notte qualcuno ha bussato alla mia porta, supplicandomi di aprire e chiamandomi per nome. Per difendermi ho acceso la televisione e ho alzato il volume. I canali messicani vanno matti per i film d’azione: urla, sparatorie, esplosioni… Alla fine anche un altro cliente dell’albergo ha battuto sul muro, e tutto quel chiasso ha allontanato il pericolo. Il giorno dopo la receptionist mi dice che da quando mi chiama il taxi si presenta sempre il numero 85. Che fare? Borsa in spalla, corro a prendere un autobus alla stazione. È una vecchia carretta, di quelle che sfrecciano con le porte spalancate. Mi siedo proprio dietro il conducente e noto, davanti all’autobus, un uomo sulla trentina con un dente d’oro piantato in mezzo al suo ampio sorriso: si presenta come il taxi numero 85. “Che faccio, signorina? Parto?”, mi chiede il conducente. Annuisco, sollevata. In questo autobus di terza categoria, se hai un po’ di soldi e un passaporto ben piazzato nella classifica delle potenze mondiali, gli uomini sono ancora galanti.
Ma non dimentico che la sera prima ero venuta in questa stessa stazione per accompagnare due viaggiatrici coraggiose. Mi avevano chiesto di comprare due biglietti a nome mio: se gli impiegati avessero notato il loro accento centroamericano, avrebbero raddoppiato il prezzo e avrebbero segnato i loro biglietti in modo che anche il conducente potesse estorcergli del denaro.
Ixtepec, Oaxaca
Ha appena viaggiato per dodici ore filate sul tetto di un vagone. Arriva da Arriaga, città di partenza del treno merci. Dopo una sosta in questo rifugio, salterà su un altro convoglio che la porterà nello stato di Veracruz. E così, di treno in treno, di rifugio in rifugio, forse raggiungerà l’ultima frontiera. Le ferrovie che aiutarono la diffusione della rivoluzione messicana sono state privatizzate negli anni novanta. Da allora non circolano più treni passeggeri. Restano solo i treni merci e una vasta rete ferroviaria che copre tutto il paese, compresi i 3.200 chilometri di frontiera con gli Stati Uniti. Per ironia della storia, il treno è di nuovo leggendario grazie ai migranti, che l’hanno trasformato nel protagonista della loro epopea dandogli nomi diversi a seconda dello stato che attraversano. “La bestia” quando passa nella giungla del Chiapas, “il verme d’acciaio” quando penetra la vegetazione dello stato di Veracruz, “il cavallo di ferro” quando corre nei deserti del nord. La ragazza divora una zuppa di broccoli sotto i raggi del sole di fine pomeriggio. “Non è che avresti dei pantaloni?”, chiede prima di alzarsi, strizzata in un paio di jeans di velluto rosa. Deve averli presi tra gli abiti raccolti per beneficenza. “Mi chiamo Sonia e ho sonno”, dice, cercando un posto all’ombra dove accasciarsi. “Da quant’è che non dormi?”. “Settimane”, risponde, prima di stendersi sulla pancia e addormentarsi. Appena arrivano al rifugio, il primo riflesso delle viaggiatrici coraggiose è quello di esplorare il mucchio dei vestiti usati. Spesso restano solo top, i pantaloni sono rari e le scarpe poco adatte. Ricordo la disperazione di una donna che il giorno dopo si sarebbe dovuta arrampicare su un treno e trovava solo ballerine. “Chi dorme meglio vince la guerra”, dicono i migranti. Appollaiati per notti intere sui tetti dei vagoni, hanno perso tutti almeno un compagno, caduto per un colpo di sonno. Basta rilassarsi un po’ e rischiano di finire sotto le ruote del treno. Alcuni muoiono stritolati, altri perdono una gamba o un piede. L’unico muro costruito in questo terreno è dipinto di rosa. È il primo pezzo della futura cappella. Sotto il crocifisso dorme un ragazzo molto giovane, con le braccia incrociate sul viso, come per proteggersi. “Solo, andava solo e nessuno sapeva della sua esistenza / Solo, andava solo e non conosceva più le ore / Solo la notte e il giorno, l’incubo e la follia”. Mi torna in mente la voce dolce e cadenzata di Leyla. Una ragazza che aveva scritto una poesia in memoria di uno di quei morti anonimi, di cui aveva visto il cadavere gettato lungo la ferrovia. “Almeno tra noi, dobbiamo vederci”, aveva aggiunto.
Osservo Sonia, seduta in disparte. È il rito della partenza: infilare calzini e scarpe da ginnastica. Mi concentro sulla sua espressione fissa e sui gesti meccanici.
“E devo rimettere questi calzini sporchi.
Non ne posso più dei calzini sporchi”, dice, quasi sussurrando. Non si ascolta più, forse non si appartiene neanche più. Alla sua destra, un uomo sbircia la scena, con lo sguardo acceso. “Che fate?”, chiede con una falsa giovialità che dà i brividi. Fisso la sedia e le sue gambe sporche di terra, la struttura metallica e le macchie di ruggine. Registro ogni particolare come se qualcuno dovesse chiedermi di identificarla. Sonia ha il corpo coperto di fango come le vittime estratte dalle macerie. Dalla tasca tiro fuori una crema lenitiva. Se la spalma sulle braccia. “Guarda la mia pelle, è bruciata ma sotto c’è quella nuova”, dice. Poi, con una smorfia infantile, mi chiede: “Il peggio è passato, vero?”. Sono colpita, le è bastata un po’ di crema per riprendersi. Un attimo dopo la scorgo in lontananza, mentre si allontana dallo spiazzo appiccicata al tipo. Camminano goffamente, come se avessero i piedi legati. L’uomo la minaccia forse con un’arma infilata in tasca? Vuole venderla o usare il suo corpo? Quante volte dovrà cambiare pelle Sonia prima di ritrovare la libertà?
Veracruz
Seguendo la ferrovia dalla costa del Pacifico fino al golfo del Messico, arrivo al villaggio di La Patrona, dove un gruppo di attivisti ogni giorno dà da mangiare e da bere ai passeggeri del treno. “Una tempesta ha bloccato il convoglio, mi accompagni? È qui vicino”, mi dice Norma, la capofila. Nel bagagliaio del suo 4×4 sono già sistemati diversi cestini da picnic e dei lonches, piccoli sacchetti con tacos e guacamole. Avanziamo a sbalzi sulla strada piena di buche e dossi. Alla fine scorgo il convoglio e contemplo ogni vagone come se fosse un pezzo da museo. È la prima volta che vedo il treno fermo.
Parcheggiamo davanti a una schiera di casette con le sbarre alle finestre, da cui non filtra nessuna luce. Non è tardissimo, forse le dieci e mezza di sera. Gli abitanti hanno paura di uscire, ma anche in casa non si sentono al sicuro. “Che vigliacchi! Non potrebbero darci una mano?”, s’indigna Norma. Nelle sue prediche, il prete del villaggio condanna Norma, “il diavolo con le lentiggini”. Le vicine hanno rinunciato ad aiutarla. Gli uomini si oppongono con forza a qualunque iniziativa delle donne fuori dalle mura domestiche. “Come fanno ad arrampicarsi lassù? Così in alto, come se il pericolo fosse gravissimo e potesse raggiungerle”, si stupisce Cristóbal, un ragazzino di dodici anni. Ogni giorno è lui che fa una telefonata a Norma per avvertirla dell’arrivo del treno. “Ho visto una scala buttata dietro gli alberi di guaiava”, urla prima di andare a prenderla. Appena scese dal treno, le quattro viaggiatrici coraggiose si appoggiano al 4×4 per bere del caffè. Portano tutte un berretto. Il paesaggio è tropicale e loro sembrano ridicole, ma chi passa dodici ore su un tetto di lamiera, sotto scrosci di pioggia, non pensa certo alle palme. Gli occhi come soli notturni, rischiarano le lentiggini sui loro volti. Una visione improvvisa di grande intimità. Tirando fuori un pacco dalla macchina, Norma annuncia: “Ho dei vestiti di ricambio, date un’occhiata!”. Interrompono la pausa caffè. Gli strati di abiti le proteggono senza dubbio dal freddo, ma anche dallo sguardo dei banditi. Tutte hanno il seno fasciato. Una di loro, incinta, s’infila un paio di pantaloni ma non riesce a chiudere il bottone. Ripenso spesso a questa scena, l’ultima volta che hanno provato dei vestiti da donne libere. Alla tappa successiva le hanno sequestrate. L’ho saputo in seguito da uno dei loro compagni di viaggio, che ho incrociato per caso in un rifugio più a nord. Il sequestro è avvenuto alla Lechería, la latteria. Questo nodo ferroviario alla periferia di Città del Messico è un posto chiave della tratta delle donne. Ai lati dei binari vengono a rifornirsi i bordelli di una capitale che ha più di venti milioni di abitanti. Le quattro ragazze sono condannate alla morte lenta della prostituzione. “Finché non impazziranno o moriranno di aids”, dicono i magnaccia che, appena vedono una donna, calcolano subito per quanti anni la potranno sfruttare.
Nella stazione della Lechería, un’impiegata il cui ufficio dà sui binari conferma la scena: “Ho visto delle ragazze in mutande caricate su alcune macchine della polizia. Le sembra normale?”.
San Luis Potosí
Questa volta il mio autobus è comodo. Senza il timore di incontrare i funzionari dell’immigrazione, sono ipnotizzata dal deserto dove danzano le yucche, e intanto ripeto il nome di una città, che sembra una formula magica: Matehuala.
Taccuino in mano, una ragazza che indossa una maglietta mimetica m’interroga: “Quanti posti di blocco dell’immigrazione?
A quanti chilometri da qui?”. Ritorno alla realtà. San Luis Potosí è uno degli stati più violenti per i migranti. Entrando nella capitale, con le sue facciate pittoresche e la serie di piazze coloniali dove sfilano giovani donne in abiti di crinolina, stento a credere che questa graziosa città possa essere più pericolosa di un villaggio barricato di frontiera. Anche perché il rifugio non è relegato, come tutti gli altri, ai margini del centro abitato. Per raggiungerlo basta seguire un viale alberato e prendere la stradina alle spalle del santuario dedicato alla Vergine di Guadalupe. Davanti alla pesante tenda di plastica che segna l’ingresso del dormitorio femminile comincio a sentire dei brividi. Mi sembra di entrare in una cella frigorifera. Poi, di colpo, uno sguardo febbrile trasforma la mia visione in uno scatto in bianco e nero. Vedo le donne della grande depressione fotografate da Dorothea Lange. Mi tempestano di domande, sui blocchi dell’immigrazione e sugli Zetas, l’altra mafia che controlla il traffico dei migranti. Un ragazzo scosta la tenda e si affaccia.
Non fa in tempo ad aprire la bocca che una donna lo interrompe con durezza: “Non mi parlare, non provare neanche a guardarmi, perché non ho nessuna intenzione di finire per strada”. La ragazza con la maglietta mimetica mi spiega: “Ieri, a due passi dal rifugio, due amiche sono state sequestrate e altre due arrestate. La direttrice le aveva appena messe alla porta perché avevano parlato con un uomo”. “Siamo finite in una trappola. La madre superiora ci sbatte fuori con qualunque pretesto, ma secondo me vuole consegnarci ai poliziotti, forse anche agli Zetas”, esclama una donna che indossa una salopette da pagliaccio. Poi, all’improvviso, cambia tono e mi fa una domanda assurda: “Tu li sai cucinare gli uccellini alla brace?”.
Kamikaze della povertà
Il pericolo si nasconde dietro la porta. Madre Carmen, la direttrice del centro, una religiosa, è praticamente una tenutaria. Sembra uscita da un incubo: camicia di seta viola e croce smisurata al collo. “Allora, sei pronta, principessa?”, chiede a una ragazza. “Sì, sì, arrivo”, risponde lei con voce tremante. Ha i capelli legati, tinti con l’henné, e due orecchini d’argento a forma di mezzaluna, indossa un paio di jeans e un golf fucsia. Fucsia! Provate a immaginare la faccia del poliziotto di frontiera che si trova davanti una salopette da pagliaccio o un golf rosa shocking. Il ballo in maschera dei “kamikaze della povertà”. Quelle arrivate fin qui sono già delle eroine, delle pioniere. Organizzano e finanziano il loro viaggio così abilmente che, a volte, lo trasformano in un mestiere e diventano a loro volta trafficanti. Mi è capitato di incontrare delle trafficanti mimetizzate in un gruppo. Si riconoscono facilmente perché spesso indossano abiti sportivi griffati e sono “meno rovinate”, come dicono le altre donne, che giorno dopo giorno lottano con i loro corpi sofferenti: scottature, diarrea, congiuntivite, vesciche.
Ne noto una nel dormitorio, indossa i pantaloni di una tuta di velluto color talpa perfettamente aderenti al suo corpo sinuoso. Avrà vent’anni: “Mi è capitato di accompagnare una ragazza che faceva eccitare tutti gli uomini del treno. Alla fine l’ho dovuta mollare. Hai presente cosa vuol dire andare in giro per l’Honduras con una ragazzina così al seguito? Ti prendono subito per una puttana”, dice, rivolgendosi alla tipa con il golf fucsia. “Ma insomma, ma mi vedi? Sono solo una vecchia che è partita per permettere ai suoi cinque figli di studiare”, risponde la donna, che non ha ancora trent’anni. “Viaggio sola, sono partita sola”. Sembra non credere a quello che le succede, come se fosse stata convinta che il suo coraggio di partire l’avrebbe protetta dai problemi. Ora che si è rifugiata in questo gruppo la paura, invece di svanire, si scatena. La donna con il golf fucsia, paralizzata all’idea di lasciare da sola il posto, farebbe di tutto pur di essere accompagnata. “Fidati di me”, dice supplicando alla trafficante che, per chissà quale motivo, non vuole prenderla nel suo gruppo. Non è il primo rifiuto che riceve. Da quando ha lasciato il suo paese, soffre per il fatto di non sentirsi più guardata. Questo spiega lo strano trucco sulle palpebre: un ombretto blu luna, un po’ troppo carico. Come per dire: “Ce la posso fare, ce la voglio fare”. Poi, di colpo, crolla ed esclama: “I miei figli, li ho lasciati soli. La più grande ha sedici anni. Non so se hanno da mangiare adesso”.
La tenutaria torna. Ha il viso gonio, ho l’impressione che abbia bevuto. La donna con il golf fucsia si pulisce i segni di mascara sotto gli occhi e la segue. Va a fare la baby-sitter.
I rifugi per migranti non servono quasi mai a riposarsi: durante il soggiorno, che a seconda del regolamento va dalle ventiquattr’ore ai tre giorni, bisogna trovare i soldi per continuare. Così vengono proposti – o a volte imposti – dei lavoretti. Dopo questa partenza sul gruppo cala il silenzio. Ascoltiamo i suoni confusi della strada, poi ci fa sobbalzare il grido di un venditore ambulante: “Gas! Gas!”. Ed è come se scatenasse l’urgenza di raccontare. “Chiamavo gli amici, erano lì vicino, eppure nessuno di loro…”, ricorda tra i singhiozzi una bella ragazza con i capelli castani e gli occhi a mandorla, che avrà sì e no vent’anni. Due poliziotti l’hanno stuprata in un vagone, dove si era appena rifugiata sfuggendo per un soffio agli Zetas, che volevano venderla a un bordello. “Abbiamo scavalcato del filo spinato, ci inseguivano armati, con dei cani, una donna è caduta e ci ha supplicati di continuare senza di lei e poi, e poi, e poi…”.
I racconti delle violenze si accumulano a tal punto che cominciano a stonare, come un brutto film d’azione. Non potendo tapparci
le orecchie, incrociamo le braccia. Quasi in preda alla rabbia, penso: “È troppo, troppo, troppo”. La giovane con gli occhi a mandorla aveva esordito con voce serena: “Grazie a Dio non mi è successo nulla…”. Questa frase torna spesso sulla bocca di tutte, come per esorcizzare gli stupri che rischiano in ogni momento. La donna con il golf fucsia rispunta annunciando che suo fratello le ha appena mandato dei soldi e che non farà la baby-sitter. Nel suo cuore stanco si riaccende l’energia per lottare: “Troverò il coraggio”, dice. “Ce ne andremo tutte insieme”, aggiunge la ragazza con la maglietta mimetica. Mi metto di guardia in strada. Sulla facciata del rifugio un gruppo di giovani migranti dipinge una Vergine di Guadalupe con i colori della bandiera messicana. Alcune alunne in kilt passano mordicchiando stecchini di lecca-lecca. È ora di pranzo, il momento per scappare mescolandosi alla folla di studenti, ora o mai più. Ormai, solo le uniformi scolastiche possono proteggerle. Due a due, camminano lentamente, come se la paura gli rendesse i piedi di piombo. Sui gradini del santuario di Guadalupe si separano. La maggior parte decide di camminare fino alla ferrovia per aspettare il prossimo treno. La donna con il golf fucsia dice a un tassista:
“Al Media Luna”. La sera prima era scappata da quel motel dopo che il gestore le aveva mormorato, issandola: “Se non ha i soldi per pagare, possiamo trovare una soluzione”. Ha pesato la frase sulla bilancia del rischio. E alla fine ha preferito il gestore depravato alla tenutaria. Il tassista le lancia un brutto sguardo. Troppo tardi. Si è infilata nella macchina con altre due ragazze. In mezzo all’incrocio il tassista fa inversione e mette la freccia: ci sono e non ci sono, ci sono e non ci sono, una frazione di secondo ancora e via. Me ne sto impalata sul viale. Mi siedo su una panchina, vicino a un impiegato con la sua insalata. E mi torna in mente il titolo di un articolo che riferiva la denuncia di una giovane migrante: “Ci maltrattano, ci picchiano come le foche in Canada”. Mi era sembrata un’immagine poco felice, quasi comica, ma ora sento il peso di ogni parola e capisco. Viaggiatrici in via di estinzione, ecco cosa sono.
Frontiera nord
Siamo a un centinaio di chilometri dalla frontiera, alle porte del deserto. La potenza della luce cancella le occhiaie come un raggio laser, torna la speranza e per ingannare il tempo le tragedie vissute in viaggio vengono raccontate come aneddoti. Yoli, la capogruppo delle viaggiatrici coraggiose, non si vergogna di descrivere i suoi incontri ravvicinati con la polizia di frontiera. Le altre preferiscono tacere. Spesso l’arresto alla frontiera è vissuto come una bocciatura. Non a caso esiste un corso per imparare ad attraversarla. Si svolge tutte le sere nel cortile di questa scuola primaria riconvertita in rifugio. Il contenuto potrebbe sembrare assurdo, ma per chi partecipa lo è meno che stare seduti in classe a cantare l’inno nazionale. In Honduras o nel Salvador i tipi dall’aria losca fermi all’uscita delle scuole non sono spacciatori ma broker, agenti che promettono viaggi a credito per gli Stati Uniti. “L’età media dei migranti è diminuita di dieci anni. Prima erano sulla trentina, ora sono ragazzi e ragazze di meno di vent’anni”, conferma un’attivista. Basta dare un’occhiata per convincersi: sembrano studenti di una classe di liceo. Solo che il loro esame finale non è la maturità, ma la traversata del Río Bravo su una boa improvvisata. “Fate una colletta per comprare una camera d’aria e una pompa per bici da un ferramenta. Domande?”, chiede il professore, che si è beccato il soprannome di Chuck Norris.
“Vietati i vestiti dai colori accesi… Quel giallo può andare…”, risponde a uno studente che gli ha indicato la sua maglietta con aria interrogativa. “Allora, come sapete i gringos hanno piazzato delle telecamere a raggi infrarossi in grado di captare il calore di un corpo umano a più di un chilometro di distanza. Non accendete sigarette. Hanno installato anche dei sensori di movimento, quindi camminate con passo leggero. Inutile ricordarvi che non dovete cantare né fischiare, anche se non sentite nessuna presenza nei paraggi”. “Mi accompagni in bagno?”. Cristal ha l’aria indolente di chi salta le lezioni. “Non trovi che sembro incinta?”. Mi torna in mente il suo fidanzato, un bel ragazzo con gli occhi castani e un gran sorriso. “Sembri innamorata”, rispondo. Scoppia a ridere, felice, poi mi ferma di colpo e mi confida con aria seria: “Ieri sera ho vomitato”. “Sei sicura che non sia qualcos’altro? Lo stress, per esempio? Hai sentito cos’ha detto il professore, anche con l’aiuto di un trafficante a tutti toccheranno cinque notti di marcia nel deserto”.
“Non saprei…”, risponde lei, evasiva. Penso ai suoi genitori, che da qualche parte in Honduras o in Texas, aspettano angosciati.
Per gli adolescenti dell’America Centrale, ritrovarsi con le spalle al muro non è un rischio solo metaforico.
Gandhi ha scritto: “La povertà è la peggiore forma di violenza”. La frase s’incarna in tutta la sua verità quando una ragazza alza un moncherino per intervenire durante la lezione: “Volevo dire che anche chi non ha una gamba o un braccio vale comunque qualcosa”. La sera prima mi ero ritrovata accanto a lei quando bisognava pulire i fagioli per la cena. Si era chinata in avanti per svolgere il lavoro e io, confusa, non osavo attaccare discorso. Yoli mi aveva raccontato l’episodio della sua amputazione: “Stava due vagoni davanti al mio. La conoscevo già, anche lei è dell’Honduras. Si chiama Sonia e non aveva soldi da dare ai banditi. Allora hanno cercato di stuprarla e lei ha resistito. ‘Ma sei una selvaggia!’, le hanno detto, prima di buttarla dal treno. Subito dopo, mentre scappavo, ho visto le sue braccia lungo i binari”. Le retate delle squadre dell’immigrazione seguono un copione preciso: spesso avvengono in piena notte, quando il treno attraversa le zone dove ci sono precipizi o paludi. “I poliziotti le hanno offerto dei dollari
a patto che se ne tornasse a casa senza fiatare, ma lei ha rifiutato, dicendo che sarebbe arrivata negli Stati Uniti, costi quel che costi”.
Anche se Chuck Norris insegna ogni sera da tre anni, la determinazione dei suoi studenti continua a sorprenderlo. “Durante la prima lezione ho fatto una gaffe. Erano circa centosessanta e gli ho detto: ‘Sappiate che non passerete tutti’. Silenzio. Poi un tizio si è alzato e ha risposto con fermezza: “Invece sì, passeremo’. Un’altra volta mi sono dovuto inginocchiare per dissuadere una donna di più di sessant’anni che viaggiava alla ricerca del figlio. Non mi ha dato retta e si è lanciata nel deserto”.
All’improvviso, come se una sfilza di volti gli stesse tornando in mente, si chiede, distratto: “Quel ragazzino con i capelli bruni e ricci… Una sera avevo cenato con lui. Nessuna notizia… Sono passate tre settimane… Aveva promesso di chiamarmi”. Mi ricordo di un giovane informatico honduregno. Si chiamava Ángel. L’ho incrociato alla stazione degli autobus e mi ha detto che avrebbe attraversato il deserto da solo. “È una buona strategia andare da soli”, commenta il professore, che spesso parte in ricognizione dall’altra parte. Abitando alla frontiera, Chuck ha il permesso di circolare liberamente. Con il suo fisico da uomo d’azione si è conquistato la simpatia delle guardie di frontiera, che non solo gli offrono da bere ma gli rivelano le loro strategie per dare la caccia ai migranti.
E lui riferisce tutto a lezione. “Non voglio che viaggino alla cieca”, spiega Chuck, un uomo che, per scacciare la tristezza, cerca di dare un senso all’assurdo: “Non capisci quanto siamo privilegiati. Hai letto Il Messico insorge di John Reed? Leggilo. Abbiamo la storia davanti ai nostri occhi”. Osservo un gruppo di honduregni, guatemaltechi e salvadoregni, giovani nati dopo i disastri delle guerre civili degli anni ottanta. Sono seduti intorno a Yoli, che racconta quanto fosse facile attraversare la frontiera prima dell’11 settembre: “Bastava che un coyote, un trafficante, ti facesse vestire da maratoneta e potevi entrare sgambettando dalla porta principale”.
Un pugno di sassi
In questa città di frontiera dove il coprifuoco scatta spontaneamente alle quattro di pomeriggio, gli Zetas fanno reclutamento attraverso i piccoli annunci. “Ex soldato o militare in servizio, se sei stufo della tua paga da fame e di mangiare zuppe istantanee, unisciti a noi”. Sulla piazza principale, i trafficanti vendono all’ingrosso i migranti alla mafia: “È un mercato di schiavi”, mi aveva avvertito un attivista, sconsigliandomi di uscire dal rifugio. Da dietro le finestre protette da reti metalliche, assisto all’arrivo di una miracolata: una ragazzina dall’aria spensierata, in jeans e polo, con un rossetto rosa chiaro che le sta malissimo. Dove l’ha trovato? Da dove viene? “Dalla valle di San Lorenzo”, risponde, come se fosse dietro l’angolo. “Dove, esattamente?”. “A sud, verso Choluteca”.
Ha quindici anni, si chiama Suyapa e viene dall’Honduras, a più di tremila chilometri da qui.
Non contenta di aver attraversato da sola il Guatemala e il Messico, questa notte proverà a varcare la sua terza frontiera. “Allora, volete sentire la mia avventura?”, chiede, elettrizzata. Con il suo metro e cinquanta e gli occhi sfavillanti, l’estrema magrezza e la voce da Edith Piaf, mi fa pensare a un’eroina dei cartoni animati. Ed ecco che trasforma la sua ennesima disavventura con i trafficanti in un racconto a tinte forti: “Ho capito che era un sequestro, ma volevano farmi credere che era tutto ok. Allora hanno chiamato il padre di mio figlio negli Stati Uniti. È lui che aveva pagato il viaggio. ‘Suyapa, maledizione, fai quello che ti dicono!’. Ha provato a convincermi, ma niente da fare: avevo già deciso. Non mi fidavo più, da subito, da quando ci avevano caricati su un furgoncino bianco e sbam, sbam, avevano chiuso gli sportelli. Dentro piangevano tutti. C’era un tizio con un brufolo tra le pieghe della fronte, un brufolo quasi bianco. Non migliorava certo il suo brutto muso. Poi siamo arrivati in una casa senza mobili ma piena di gente, anche donne incinte, bambini, giovani, vecchi. Tutta l’America Centrale aveva pagato per il sogno americano, e io non riuscivo a trovare un buco dove dormire.

Allora ho pensato: ‘Io me ne vado, scappo, pazienza per la valigia, voglio salvarmi la pelle’. L’amica che stava con me non voleva seguirmi, frignava: ‘Ma i miei genitori hanno già pagato il viaggio, e se poi succede questo e quest’altro…’. Allora le ho detto: ‘Senti, Kellin, i tuoi genitori sono a migliaia di chilometri da qui, non possono fare nulla per te’. È rimasta lì. Io ho scalato un muro. E sentivo uno dei ragazzi che ci sorvegliava lamentarsi: ‘Ehi, torna, sennò mi menano’. Provando a saltare su un treno in corsa mi si è incastrato un piede e ho strappato la camicia. Stavo per mollare la scaletta quando tre guatemaltechi mi hanno sollevata fino al tetto del loro vagone. E io che pensavo che erano cattivi, i guatemaltechi, invece sono proprio simpatici”, conclude allontanandosi. I suoi zoccoli, scovati chissà dove, risuonano allegramente, tac toc, tac toc, come se Suyapa fosse a casa.
Nel dormitorio femminile, l’attrazione principale è la finestra con le sbarre. “Indietro, tirati indietro. China la testa, ecco, ci siamo quasi”. Quel che cercano di vedere non è l’angolo di cielo azzurro dei carcerati, ma alcuni alberi texani di un verde insolente, proprio davanti al rifugio. “È quello? È quello il río Bravo?”. “Ti assicuro che in mezzo è pericoloso, è pieno di buche e di mulinelli”, spiega una ragazza grassottella di nome Blanca. L’avrei scelta come compagna di viaggio per il suo senso della strategia. Aggiunge: “Quando attraversi di notte, gli elicotteri volano così basso che l’acqua risale…”. “A volte i trafficanti gli lanciano delle pietre, agli elicotteri”, conclude un’altra. Queste donne hanno già affrontato il loro battesimo di fuoco. Suyapa no. Si è unita a un gruppo che va in ricognizione sulle sponde del fiume. Sono cinque, scortati da un prete in abiti civili, un ragazzone sulla trentina, in jeans e maglietta, che al posto della croce porta una collana brasiliana. Li fa sedere sulla riva per insegnargli a inspirare ed espirare.
La vista di una maglietta con la scritta alive in lettere bianche s’intreccia al ricordo di un’email che ho ricevuto la sera prima. Sotto l’immagine di un Cristo, una frase lampeggiava come un numero verde: “Se ti mettono una pistola alla tempia, a chi chiederai aiuto?”.
Un trafficante si aggira intorno a Suyapa, che lo ignora. La minaccia: “Vuoi attraversare da sola? Almeno per te non serviranno molte pietre nello stomaco, basterà un pugno di sassi”. Mi tornano in mente le parole di un migrante:“Se c’è troppa corrente muori, oppure le pietre ti sotterrano”.
A cena, Blanca butta nel piatto di ognuno un formaggino. Le chiedo delle pietre nello stomaco. Conferma: “E così, cuciono delle pietre nello stomaco dei cadaveri per farli affondare”. “Ma chi? Chi le cuce?”. “Nel Salvador, durante la guerra…”, attacca un tizio alto e biondo, ma ci ripensa subito. Ora che mancano poche ore alla traversata, preferisce scherzare: “A proposito, a che ci serve il passaporto? Non lo vuole nessuno. Ah, già, nel nostro paese”. E tutti ridono di gusto.
Dormitorio per adolescenti
“Tutte queste sofferenze per farsi acchiappare ora… Se mi prendono, io scoppio a piangere”, annuncia senza tanti giri di parole una ragazza incinta di pochi mesi. “Lascia stare le lacrime. Se ti prendono, cacci fuori i dollari, e in fretta. Paghi il primo agente, ma prima che arrivino gli altri, sennò… Le guardie di frontiera sono molto più care di quelli dell’immigrazione”, interviene Blanca in tono disinvolto, come se stesse parlando di marche di vestiti. Mentre le viaggiatrici coraggiose si preparano per la partenza, mi spediscono a comprare alcune cose dal droghiere lì accanto. I ragazzi che fanno la guardia girano la chiave nella serratura, senza una parola. Attraverso la strada deserta come se fosse il mio río Bravo. Il droghiere sta dietro una rete metallica, a cui sono attaccate delle bustine di polvere viola che i messicani chiamano sal de uvas: serve per reidratarsi la bocca durante la traversata del deserto.
Forse si aspetta che gli chieda delle taniche d’acqua da sette litri e delle scatolette di sardine. E invece no, mi hanno detto di prendere dell’olio per neonati, un solvente per lo smalto e una crema idratante. Quando torno in quella stanza incasinata, invasa da prodotti di bellezza aperti, vestiti sparsi, pezzi di specchio con gli adesivi dei Mini Pony, mi sembra di stare in un dormitorio di adolescenti. Con un’unica differenza: sul muro verde pallido, invece di “Gustavo, ti amo”, c’è scritto “Dio”. Suyapa si sforza di non piangere. “Sono nervosa”, confessa. Ha aperto il flacone di olio e un odore di sederino pulito si diffonde nella stanza. Se ne versa un po’ sui capelli. Un ragazzo prende il barattolo di crema Nivea e se la spalma sulle braccia. “Ehi, vacci piano!”, gridano le ragazze. Blanca si toglie ogni traccia di smalto. Partirà con le unghie al naturale. Come se fosse il suo primo giorno.
- uscito su XXI, Francia e ripreso da Internazionale 30 luglio 2010🡅

i flussi migratori continueranno, nonostante i muri e la cecità dei paesi ricchi che come gli struzzi continuano ostinatamente a rifiutarsi di capire un fenomeno di portata storica, a guidarlo, governarlo e a sfruttarne le enormi potenzialità;
la stupidissima cecità dei paesi occidentali che pretende di rimuovere il problema attraverso leggi repressive e identitarie
la pericolosissima cecità delle destre occidentali che alimentano la paura dello straniero, per tranne profitto politico, in una spirale perveresa e regressiva;
l’irrazionale cecità di noi uomini bianchi del primo mondo non fermerà i flussi migratori ma li renderà sempre piu’ esplosivi e ingovernabili, o meglio governati dal crimine (un po’ come succede con la droga).
Eppure basterebbe vivere una ettimana in africa o in centroamerica per capire che pretendere di fermare i flussi migratori è come pretendere di fermare il consumo della droga, o la circolazione die capitali.
Tapachula è un inferno (anche climatico), uno dei tanti inferni nella via crucis della migrazione. Il migrante fugge dalla fame, lo si sa, ma fugge anche dalle proprie radici. E questa è una scelta che non fanno tutti.
L’idea di “radice” identità culturale” “nazione” “patria” è legata al
modello dello stato territoriale moderno centralizzato, dello stato così come oggi noi lo conosciamo:appunto fondato sulla paralisi ideale dei sudditi, sulla supposta staticità, cioè immobilità, dei suoi abitanti. Di qui l’estrema difficoltà che ogn istato incontra ai giorn inostri nel mettere a punto politiche minimamente decenti nei confronti dei flussi migratori, composti da soggetti che per natura contraddicono il fondamentale comandamento dell’immobilità. E questo perchè l’assunzione del modello prospettico-spaziale e dei suoi presupposti……ha prodotto un pensiero di cui soltanto adesso accenniamo ad uscire…………….
franco farinelli – geometrie del potere lettera internazionale nr 4
farinelli aggiunge anche che
l’insegnamento degl istudiosi……si condensa nella messa in discussione delle strategie che designano i non occidentali come “nativi”. Tale definizione viene …respinta dall’antropologia moderna che considera il soggetto non più espressione di un campo delimitato. ma piuttosto di una serie di localizzazioni mutevoli, non più il prodotto di una situazione statica ma di un processo dinamico:attore, insomma non più interno a un ambito circoscritto da frontiere, ma a una zona di contatto più o meno estesa, composta da relazioni, interazioni e comportamenti temporanei e interconnessi, di solito fondati su rapporti di potere radicalmente asimmetrici, cioè disuguali, e su limiti fluifi e mobili.
Cosi’ e’ stato fino alla anscita dell stato moderno. Noi non siamo alberi, immobili, pietrificati, (altro articolo interessante di george santayana.
io credo che noi dobbiamo riflettere sul progressivo sbricciolamento delle categorie che hanno fondato fin ora la nostra visione del mondo e che secondo farinelli
rende impossibile ogni originario rapporto con la realta, ridotta al sempre men ovisibile diafreamma interposto tra la mappa che è nella nostra mente e quella che corrisponde all’insieme a cio’ che ci circonda
se queste premesse sono “valide” allora la letteratura ha e deve svolgere un grande ruolo nella frantumazione di quel diaframma che ci impedisce di vedere e di sentire come diceva francesco forlani nell’articolo qui sotto di qualche giorn ofa
se que
Primo ringrazio per la qualità del post. I designi con la fragilità lottano contro la violenza e i racconti in zona di guerra. He ragazze della frontiera hanno il cuore mangiato. Il corpo dilaniato dallo stupro, dalla prostituzione, dalla paura, dal sonno morto, dal occhio sempre in alerta, dal treno addentato, macellato. In questa zona, il viaggio non arriva mai.
Sono corpi sequestrati, assaliti in un’identità frammentata. Qui la pietà è morte, qui il fiore è strappato, qui il cielo ha il colore della fama, qui l’amore non c’è.
Le ragazze di guerra. I racconti vengono a galla in zona di guerra.
dall’ochio
Tutte chine o sghembe, ma mai mai spezzate, finché sono in vita..un abbraccio a Camilla e Raffaella, V.
beh volevo inserire un video di amnesty international
che si puo vedere qui
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/widespread-abuse-migrants-mexico-human-rights-crisis-2010-04-27
puo’anche essere scaricato il rapporto aprile 2010
Widespread abuse of migrants in Mexico is ‘human rights crisis’
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf
in francese
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/e78b5ce3-7933-4f8e-b424-7132e1f8ffe2/amr410142010fra.pdf
in spagnolo
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/1345cec1-2d36-4da6-b9c0-e607e408b203/amr410142010es.pdf
….Secondo la Commissione nazionale dei diritti umani, in soli sei mesi del 2009 quasi 10.000 persone sono state rapite e metà di loro ha denunciato il coinvolgimento di pubblici ufficiali. Si calcola, inoltre, che sei donne e ragazze migranti su 10 abbiano subito violenza sessuale. Questo potrebbe spiegare la richiesta di alcuni trafficanti di somministrare un contraccettivo con iniezione prima del viaggio, per evitare gravidanze a seguito di uno stupro.
le vene aperte dell’america centrale
http://rassegnastampabolano.blogspot.com/2010/09/graziella-pulci-su-migrazioni.html
la frontiera del messico e le migrazioni clandestine…
…