Giardini di loto
di Luca Alvino
La complessità dei nostri pensieri è fortemente influenzata dalla lingua nella quale pensiamo ed ela-boriamo i dati della nostra esperienza. Non sto dicendo nulla di nuovo, ma probabilmente non ci ri-flettiamo abbastanza. A determinare la complessità del pensiero sono da un lato le risorse della lin-gua specifica – la sua ricchezza lessicale, le possibilità morfologiche, le volute sintattiche, la tradi-zione letteraria – e dall’altro le conoscenze individuali che della lingua si hanno. Quanto maggiori sono le possibilità della lingua – le sue capacità di astrazione, di precisione semantica, di individua-zione delle sfumature – tanto maggiore è la complessità di pensiero che essa consente. Ed è proprio la complessità del pensiero a determinare la complessità della realtà, che di per sé non è né semplice né complicata. Essa si limita a sussistere, non si ripensa, non è consapevole di sé. È l’uomo che, nel suo innato desiderio di interpretarla, ne determina i viluppi o le pervietà. Da un punto di vista emi-nentemente gnoseologico, la complessità non è una qualità del reale, quanto del pensiero e della lingua nella quale esso viene concepito ed espresso.
Ne è certamente consapevole Andrea Melone, la cui peculiarità scrittoria maggiormente evidente consiste proprio nel linguaggio, e principalmente nel lessico. Quello che colpisce il lettore fin dalla prima pagina del suo romanzo Giardini di loto (Gaffi, 2010) è un’appassionata ricerca linguistica, e dunque una precisa intenzione di decifrazione puntuale e attenta della realtà. Melone rifugge tena-cemente il termine generico: animato da un’ammirevole acribia semantica, va sempre alla ricerca del vocabolo esatto, adeguato all’espressione di un significato il più preciso possibile. Nel riportare il discorso diretto, al termine «disse» – che esprime il semplice concetto di pronunciare parole – ne predilige altri che evidenzino l’intenzione di colui che dice: come «asseverò», a rimarcare un’enfasi affermativa; oppure «opinò», per esprimere un intento dubitativo.
Laureato in filologia classica e insegnante di latino e greco in un liceo, Melone attinge doviziosamente al proprio repertorio culturale, proponendo formule omeriche, citazioni dai tragici, rimandi alla lirica arcaica; o creando neologismi su prestiti latini (come «scortillo», sulla base del catulliano «scortillum», sgualdrinella). Ripropone parole italiane in un’accezione che riconduce piuttosto al loro etimo che non all’uso contemporaneo: come il termine «eminenza», utilizzato nel suo significato di superiorità, elevatezza (dal lat. e-mineo, sovrasto, sporgo in alto). Altrove, al termine usuale, logorato dall’impiego quotidiano, preferisce il termine desueto, letterario, in netta contrapposizione con la tendenza odierna a un minimalismo anche lessicale, che predilige nella narrativa piuttosto le forme colloquiali che non quelle più legate alla letterarietà. Anche la sintassi risente di una ricerca volta allo straniamento; non tanto nelle relazioni tra le diverse proposizioni all’interno del periodo, ove prevale una paratassi di più regolare strutturazione; quanto nell’ambito della singola proposizione, nella quale l’ordine delle parole spesso non coincide con quello dettato dalla logica interna alla lingua italiana (dalla sua tradizione e uso quotidiano), ma segue criteri più vicini alla poesia, o forse alle lingue classiche, in cui il significato viene garantito più dalla nitidezza semantica dei ter-mini utilizzati che non dalla sequenza dei predicati e dei complementi.
La trama del libro si articola in due parti non rigidamente connesse tra loro da un punto di vista nar-rativo. Nella prima parte si raccontano le vicende della famiglia Lorenzini, composta da individui drammaticamente soli, che sperimentano una serissima difficoltà di comunicazione: Alfonso, un appassionato melomane che ha fatto dell’arte e della bellezza una gabbia che gli impedisce di com-prendere i bisogni esistenziali della propria famiglia; sua moglie Liliana, delusa dal proprio matrimonio e desiderosa di spendere le opportunità che la vita ancora le riserva, con i suoi ultimi scampoli di bellezza; i loro figli, disorientati dal dissestato contesto familiare, continuamente in bilico tra una più strutturata condiscendenza naturale verso gli affetti e una spontanea, licenziosa cedevolezza a un seducente languore istintuale. Liliana confessa a suo marito (mentendo) di avere un amante, e incarica Raffaele Mensi, un investigatore privato, di cercarlo, non avendo più sue notizie da alcuni mesi. Con tale rivelazione inventata Liliana certifica una situazione di stallo esistenziale dalla quale tenta di affrancarsi nell’unico modo che ritiene possibile: imbrigliandosi in maniera ancor più costretta nel groviglio inestricabile delle strutture antropologiche in cui si ritrova tragicamente avviluppata.
Nella seconda parte del romanzo, partendo dai pochi indizi completamente inventati dalla donna, Raffaele Mensi inizia un’estenuante ricerca, che da insensata indagine poliziesca si trasforma ben presto in quest esistenziale. L’investigazione lo conduce dalla Toscana a Vienna, da Salisburgo a Budapest, da Berlino a Copenaghen, da Oslo fino a Helgebosta (uno sperduto fiordo finlandese), in un percorso nel quale la materia perde a poco a poco la propria consistenza e assume progressiva-mente la simbolica impalpabilità di una lenta destrutturazione culturale. Raffaele entra in contatto con un gruppo di ragazzi norvegesi, che lo conducono in una peregrinazione senza meta apparente. Lo ricevono nel proprio gruppo con una fredda e civile accoglienza sempre pronta a tramutarsi in sconcertante ostilità. La solitudine dei membri della famiglia Lorenzini – che il lettore aveva già avuto modo di conoscere – si ritrova amplificata nei rapporti che intercorrono tra i numerosi personaggi nordici della seconda parte del romanzo. Non si comprende in cosa consista il collante che li amalgama tra di loro: i loro dialoghi sono in realtà monologhi; nessuno riesce a entrare in un rap-porto reale con l’altro; la stessa sessualità sembra più uno strumento di divisione che di unione.
Anche il linguaggio in questa seconda parte appare più lineare, meno costruito, sia da un punto di vista lessicale che sintattico. L’iniziale complessità linguistica corrispondeva a una maggiore com-plessità sociale e culturale. Laddove nella prima parte i legami sociali pertengono in massima parte a strutture familiari stratificate, intricate, limacciose, nella seconda parte le dinamiche di formazione e separazione dei gruppi seguono traiettorie più fluide e meno definibili secondo paradigmi e rife-rimenti noti. Anche la concezione della musica (l’altra grande passione di Melone, insieme alla letteratura), che nella prima parte era sommamente aristocratica, alla ricerca dell’«interprete che nasce ogni tre generazioni», si rivela nella seconda parte più aperta a influenze popolari.
L’itinerario verso il Nord si configura come un ideale percorso di purificazione in cui la realtà esterna perde progressivamente colore e calore, fino a consistere in un algido, candido, cupio dissolvi, una fuga simbolica insieme fisica e metafisica, un cammino di liberazione dalle sovrastrutture ideologiche dell’esistenza. Raffaele cade in questo equivoco, credendo che la perdita di vitalità da parte dell’ambiente e dei personaggi sia dovuto a una semplificazione del mondo, la quale, partendo dall’espressione linguistica, investe progressivamente i referenti; e si illude così di poter beneficiare di una sorta di indulgenza plenaria dell’angoscia esistenziale: «avrò problemi inesplicabili in una lingua che non li contempla», fantastica Raffaele, immaginando una vita futura in Scandinavia irrorata dal balsamo della semplicità; una vita nella quale i suoi complessi problemi sembrano destinati ad annegare nelle gelide acque dell’inespressione.
Seguendo il proprio istinto, l’uomo viene condotto «in un luogo remoto, sconnesso dalla travatura del mondo», che assomiglia in maniera sorprendente a una sponda d’Acheronte, cui non è possibile accedere se non traghettati da un Caronte in forma femminina. Senza anticipare il finale sorprendente della storia, si può tuttavia rivelare una sua intenzionale inesplicabilità, che ne aumenta il potenziale di suggestione. Ma al lettore non è necessaria una coerenza onnisciente. L’ossessiva ricerca delle motivazioni è una stravaganza della modernità. In quanto archetipi, gli antichi temi della letteratura drammatica – quelli che informano anche le strutture profonde di Giardini di loto – non avevano bisogno di essere interpretati: incesto, tradimento, ingiustizia, crudeltà, vendetta, gelosia, rivalità, desiderio, perdita, disonore e lutto.
Incarnazione albina di straniati angeli della morte, i personaggi nordici di questo romanzo incarnano una superiore, coscienziosa necessità. Ma è una necessità che non si misura in una incomprensibile teleologia, quanto nei solchi lessicali di una appassionata tradizione linguistica, nelle volute elevate di una sintassi magniloquente, nel sentiero esistenziale che lega il segno linguistico alla realtà, distillata in esperienza tramite gli imprescindibili snodi del pensiero.
A. Melone, Giardini di Loto, Gaffi (2011), pp. 283, 14,80 eu.
[il dipinto in apice è di Leonora Carrington]

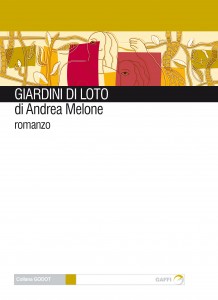
Una magnifica recensione. Un titolo aperto; i giardini del loto. Il loto à il fiore dell’oblio. Una lingua è giardino di esplorazione dell’infanzia. Li crescono piante, alberi di terra natale. E forse il linguaggio dell’infanzia
possiede l’adeguamento tra mondo visto e canto della parola. Prima trasmessa dalla madre. Poco a poco si costruisce il lessico personale, il lessico che affiora nella vita adulta.
Lo scrittore lo sa, il lessico intimo è un fantasma, si mostra con ostinazione. Il lessico intimo diventa un piccolo mondo familare, rassicurante.
Invece in questo libro presentato da Luca Alvino, la lingua è ricerca precisa, allontanata da tutta parola imprecisa come lo è un ricordo d’infanzia.
La precisione della lingua è il lavoro di uno scrittore, mentre la lingua semplice è traduzione nostalgica del giardino antico: si scopre piccolo e non immenso, come si sognava.
Per creare un ponte con il post di Francesco Forlani, se puo dire che scrivere in lingua straniera con il lessico della lingua natale è un’ avventura straordinaria, perché li, dietro il cancello è celato un desiderio di ritrovare la sua lingua dietro un’altra, di attraversare il giardino con lingua fatta di fiori venuti da climato straniero, freddo, nebbioso, o luminoso.
Siamo sulla soglia di nuova migrazione di lingue nella letteratura, è il segno che la letteratura è viva, cammina ( un ponto con primo amore).
Scrivere in lingua straniera come lo fanno le due scrittrice presentate da Francesco Forlani è una meraviglia ma anche la marca di un dolore.
Perché chi parla benissimo una lingua straniera, senza il solito corpo d’amore della ligna natale, viaggia con un nuovo bagaglio.
Nella mia esperienza che non è quella di una scrittrice, capisco come la mia propia lingua mi segue fino nella lingua straniera.
Ringrazio tutti gli indiani chi hanno pensato a quelli che non hanno potuto fare il viaggio a Milano: era una bella sorpresa trovare post nonostante la festa.