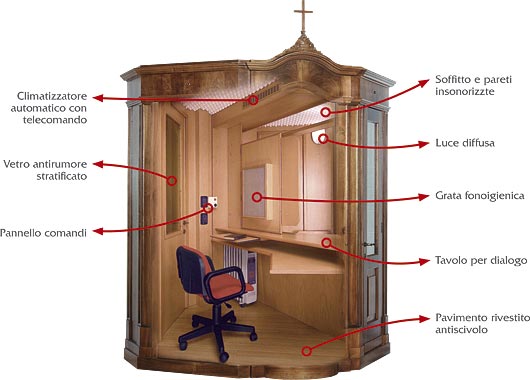Reader’s Digest: Maria Luisa Putti
La confessione
di
Maria Luisa Putti
Arrivare a Bellagio in gennaio non è una gran fortuna. Passate le feste di Natale non ci si vede più un’anima e fa veramente un freddo boia.
I negozi sono chiusi; le saracinesche abbassate e mucchi di posta infilati a forza nelle cassette. Un paio di caffè illuminano i porticati di aria calda e di pochi rumori. I lampioni con le luci gialle, le insegne dipinte a mano e coltellate di vento all’incrocio di ogni salita rendono questo paese un presepe immobile.
Sono sempre le stesse persone, sempre la stessa gente, i bellagini. Vivono d’estate; tra Sant’Ambroeus e la Befana riaprono per le feste. Ma subito dopo si adagiano nel loro letargo pigro. Dietro le finestre delle case, il muoversi operoso delle chiacchiere, che creano, distruggono, inventano, così, per ammazzare il tempo e questo freddo boia.
Oltre ai caffè, d’inverno a Bellagio rimane aperta la salumeria, la farmacia, il panificio, il giornalaio e, ovviamente, la chiesa.
Il vecchio parroco è morto da tre settimane, giusto in tempo per la messa di Capodanno. Litigava con quelli del coro: «Ma che roba è questa qua?», gridava don Luigi dalla sacrestia. Non gli piacevano i canti moderni da chiesa, con quella chitarra strappata e le «canzonette», come le chiamava lui. Si arrabbiava e diventava tutto rosso, come una bolla che sta per scoppiare. Era uno all’antica. Un montanaro che sapeva il latino e amava la musica. Gli piaceva il suono dell’organo, il gregoriano, «il canto che avvicina a Dio», diceva, quello buono. Ma l’organista si era ammalato, e Antonio, il ragazzo che lo aiutava con il coro, se n’era andato con la moglie in città, a lavorare nell’azienda del suocero. Era pianista, Antonio. Ma non faceva mica i soldi insegnando musica nei paesini. E poi, d’inverno, con questo freddo boia, oggi un bambino ha l’influenza, domani c’è neve e non c’è verso di arrivare a far lezione, e poi devono preparare i compiti in classe per la scuola e non hanno il tempo di mettersi al piano. Insomma: nulla di sicuro. Meglio lasciar perdere.
È bella la chiesa qui. E andare in chiesa è meglio che star sempre in casa. Una ragione per mettersi un vestito, una scusa per andare a spettegolare, per osservare e criticare, un luogo dove trovare qualcosa da raccontare e far passare di bocca in bocca fino a che, quel «qualcosa», diventerà un’altra cosa, condita di dettagli piccanti, di particolari buoni a renderla più credibile, ma, alla fine, molto diversa dalla realtà.
Che la signorina Costanza non venisse mai in chiesa si erano affrettate a riferirmelo il primo giorno: «È una strana persona, padre, sa? Non viene mai in chiesa. Però manda le offerte».
«Non la si vede in giro nemmeno d’estate»
«Non ha parenti, non ha nessuno…»
«Si affaccia al balcone, innaffia le piante, prende un po’ d’aria così…»
«Mi hanno detto che insegni ai bambini, il pomeriggio. Non si fa mica pagare…»
«Era un’insegnante, credo. Non è di queste parti…»
Le voci delle beghine si confondevano, una sull’altra. Ognuna a voler dimostrare di saperne di più.
Non mi restava che andare a trovarla, questa signorina Costanza. Non so se, come parroco, ne avessi veramente il dovere, ma di sicuro mi sembrava la cosa più divertente da fare in un paesino di mille anime, a gennaio, con questo freddo boia.
Suono al portone. Mi aspetto di trovarmi di fronte una di quelle mezze matte che vivono con i gatti, che parlano da sole, e che in fondo non hanno mai vissuto. Mi aspetto di vedere una vecchia trascurata, sciatta, una povera anima da ricondurre all’ovile del Signore. Suono ancora. Una voce limpida mi risponde, chiara, giovane, calda: «Sì? Chi è?». Immagino sia qualcuno che è venuto a farle visita: «Sono don Flavio, il parroco. Cerco la signorina Costanza». Il portone si apre, una porticina in legno massiccio. L’androne è buio, anche ora che sono le dieci del mattino; le scale ripide e polverose. In cima alla rampa si dischiude una porta: vedo una lama di luce proiettarsi sul muro. Dalla fessura di quella porta aperta, un calore dolce di casa mi viene incontro: odore di zucchero a velo, odore di Carnevale. I ricordi della mia infanzia si affacciano uno ad uno, ad ogni gradino che salgo, ad ogni passo, ad ogni respiro, che profuma di cannella, di biscotti appena sfornati. E i ricordi si affacciano ora alla ringhiera di ferro battuto che costeggia la rampa, nella sagoma imponente di una donna. La vedo controluce, ora che la porta è spalancata alle sue spalle e di fronte ai miei occhi: una poltrona foderata di verde e un lume su un tavolino déco è tutto ciò che riesco a cogliere. E quella sagoma ferma che mi scruta nella penombra, i capelli raccolti, il corpo formoso. Arrivo in cima: «Si accomodi, padre». La stessa voce che avevo udito al citofono, la stessa voce bella che nulla aveva di vecchio mi invita ad entrare. Ancora non riesco a vedere il viso di questa donna: perché mi offre le spalle per farmi strada nell’ingresso della casa. Si volta, ora, per chiudere la porta; mi guarda negli occhi e mi sorride: «Lei è il nuovo parroco, allora…».
«Sono arrivato da pochi giorni. Mi hanno portato la sua offerta domenica scorsa e sono venuto a ringraziarla.»
Non è vero; non sono venuto per ringraziarla. Sono qui perché ero curioso, terribilmente e morbosamente curioso di vedere lei, la signorina Costanza, che immaginavo così diversa.
I capelli biondi raccolti in uno chignon elegante, gli occhi azzurri, grandi, truccati come si usava negli anni Sessanta, con l’ombretto celeste e le ciglia allungate di nero, e il corallo lucido del rossetto. Indossava una gonna grigia, la signorina Costanza, e sopra un twin set giallo chiaro con un filo di perle. Il profumo è lo stesso che portava mia madre, Arpège, sì, mi sembra Arpège. Ed è tutto questo insieme di odori, di colori, di parole scelte come si faceva una volta, di toni di voce pacati, di gentilezze ormai passate, a darmi la sensazione, tanto istintiva quanto irrazionale, di ritrovarmi dentro la mia infanzia, di fronte alla mia maestra.
Mi offre un caffè. Apre una scatola di cioccolatini e la poggia sul tavolo tondo del soggiorno, dove siamo seduti a chiacchierare: «Non ho un vero salotto in questa casa, padre. Mi perdoni se la ricevo così». Nessun altro, in questo Duemila senza forma e senza sostanza, avrebbe mai pronunciato una frase del genere. Ma la signorina Costanza sembra uscita da un quadro antico, in una casa pensata all’antica, vestita com’era di moda quand’era ragazza lei, e il fascino delle donne era pieno di mistero, e lentamente si lasciava scoprire.
«Non ha voglia di confessarsi?»
«Di confessarmi? È venuto a casa mia per redimermi?». La signorina scoppia in una risata piena, non sguaiata, ma libera.
«Non so, se vuole, io potrei confessarla.»
«È passato mezzogiorno, padre», prosegue sorridendo con tenerezza «sarebbe il caso che lei tornasse ai suoi uffici. E poi, io non mi confesso da quarant’anni, per cui, se proprio vuole, dovrebbe restare a casa mia una settimana… Perché per confessarsi dopo quarant’anni almeno una settimana ci vuole».
Capisco che è una battuta, ma la prendo sul serio: «Va bene: resterò qui da lei per una settimana». Mi fissa negli occhi, mi sfida: «Allora cominci col venire in cucina con me: dobbiamo preparare il pranzo».
Il tavolo di marmo della cucina con la verdura da lavare; il frigorifero pieno di roba; la cassetta del vino, l’acqua minerale e i dolci di Carnevale in un piatto con il bordo dorato. Apparecchio la tavola; la signorina Costanza comincia il suo racconto. Non è solo una confessione, ma una narrazione che confonde il giorno con la notte, il pranzo con la cena.
È una settimana che non dico messa; tutto contravviene al protocollo, alle regole, e forse persino alla decenza. Non vorrei andarmene mai più. Me ne starei per sempre qui, in questa casa con il parquet, con le stufe di ghisa, con i mobili antichi, con l’odore del bucato e il profumo di Arpège. Con lei, che mi parla senza segreti, che sorride con ironia, che si commuove, che ricorda, che si arrabbia, e che cucina da Dio: lo sformato di spinaci, il pasticcio di lasagne, le cotolette, l’arrosto, il polpettone, le patate al forno, la pizza di ricotta, i panzerotti, fave e cicorie, i tortellini, la pasta all’uovo, il bollito, la polenta con gli osei scampai, risi e bisi.
Fuori dal portone il freddo mi sorprende, impreparato. È quasi notte, ed io mi volto a guardare le finestre di quella casa, le luci accese, la sagoma della signorina Costanza in controluce, che scioglie i suoi capelli come non avevo mai visto nei giorni della confessione.
Continuo a camminare, ripensando, ricordando, rivivendo.
Incontro un paio di beghine. Di sicuro si aggirano da queste parti perché muoiono dalla curiosità di sapere. Mi fermano, smaniose di chiedere: «Non posso dire nulla: è una confessione».