Esiste una scrittura maschile?
Quando, mesi fa, ho accolto l’invito a partecipare a questo seminario, certo non immaginavo di aderire a una pericolosa lobby eretica attaccata nelle scorse settimane anche da Papa Francesco e dalle Sentinelle. Se avessi saputo, avrei accettato con maggior entusiasmo romanzesco e, soprattutto, avrei smesso di fare tutto il resto per studiare e riflettere più che potevo, anziché trovarmi, e me ne scuso con chi ascolta, a presentare considerazioni che lavorano in me da lungo tempo, ma che formano un insieme ancora provvisorio di note sulla scrittura “maschile”.
Che, con buona pace degli illustri signori di cui sopra, esiste: come esiste il genere, che non è una circostanza casuale, un’ideologia alla moda; ma, tanto per cominciare, è una situazione e un progetto di sé che – come scrive anche Giulio Mozzi nel suo blog – non consiste banalmente nell’indossare capi diversi di biancheria intima, ma produce autodefinizioni e posizionamenti differenti – in termini di linguaggio, di bisogni emotivi, di consapevolezza, eccetera).
Le mie considerazioni di oggi, però, riguarderanno soprattutto la semantica e l’uso del genere in quanto dispositivo sociale – dunque anche letterario – di assimilazione, definizione e negoziazione del rapporto tra i sessi. Discuteremo dunque del genere come «performance» (secondo gli studi di Judith Butler), vale a dire come atto che in primo luogo trae autorità dal contesto in cui si situa; e, in secondo luogo, come atto che fa accadere una realtà, mette in scena il mondo e l’io nel mondo, attraverso i nomi e le parole con cui chiama ed etichetta la realtà stessa. Per intendersi meglio su questo concetto del genere come apprendistato all’invenzione e alla sistemazione dei propri desideri, può aiutarci un passaggio di un racconto di Alice Munro:
[…] Al tempo dovevo aiutare mio padre ogni tanto, perché mio fratello era ancora troppo piccolo. Prendevo l’acqua alla pompa e facevo il mio giro lungo le file dei recinti a pulire e riempire le ciotole di metallo degli animali. Mi piaceva. La responsabilità dell’incarico e la frequente solitudine in cui si svolgeva erano il massimo per me. Più tardi, quando dovetti restare in casa per dare una mano a mia madre diventai scontrosa e aggressiva. «Rispondevo», così si diceva. Il mio atteggiamento la feriva, diceva lei, e prima o poi andava a raccontare tutto a mio padre che lavorava nel fienile. A quel punto a lui toccava interrompere quel che stava facendo per venire a picchiarmi con la cinghia (un castigo abbastanza comune a quei tempi). Dopo le botte, me ne stavo a piangere a letto, organizzando la fuga da casa. Ma anche quella fase passò, e diventai un’adolescente mansueta, allegra, perfino, nota per il modo divertente in cui raccontavo cose sentite in giro per strada o incidenti di scuola.[1]
Dentro questo quadro di riferimento da cui, per ragioni di tempo e per necessità di sintesi, guarderemo alle espressioni di genere concentrandoci sui modelli egemonici, lasciando da parte, di conseguenza, le varietà d’identità maschili che smentiscono le pretese assolutizzanti degli studi di Mosse (L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile nell’epoca moderna, 1996.[2]); dentro questo campo di rapporti per cui, ragionando in termini di senso comune, la scrittura di genere, gli studi di genere, sono espressioni per lo più intese come sinonimi di scrittura/studi delle donne, è dunque possibile parlare di uno specifico letterario maschile?
Esiste, insomma, una scrittura “maschile”?
Volendo rispondere immediatamente e con un unico termine: NO. No perché è sbagliata la domanda: è falso quel suo appellarsi all’orizzonte della specificità (e della differenza) come eventuale tratto dell’identità maschile. Il concetto di “maschile/macho” – l’espressione non è mia[3] – così come si presenta e si autorappresenta, non è mai un particolare, ma un universale; non occupa mai un delimitato spazio: “è” lo spazio; è sostanza, non accidente.
Questo sbilanciamento di pesi forse potrà sembrare esagerato; può darsi che lo sia e che, di conseguenza, valga la pena di fare qualche riscontro. Certo: per verificare gli ordini di grandezze e le relative gerarchie possiamo rivolgerci agli assetti del mondo definiti dal linguaggio, fermando la nostra attenzione, per esempio, sul fatto che non esista un equivalente al maschile dell’espressione “misogino”, perché il suo opposto, evidentemente, non è “misantropo”, che esprime – e ammette – invece un sentimento di odio verso la specie tutta, non verso il genere: verso l’intero, non verso il particolare.
Ma intanto che scorriamo le circostanze materiali e simboliche prospettate dalle declinazioni di genere del linguaggio, possiamo continuare a riflettere su quel secco “NO” con cui ho per il momento replicato alla domanda intorno all’esistenza di una scrittura maschile. Possiamo infatti verificare quel “no” applicando un procedimento molto banale che si potrebbe al limite chiamare come “il collaudo del viceversa”. Il test funziona quando il rapporto tra due elementi presupposti come ugualmente rilevanti è definito da una relazione di reciprocità e intercambiabilità, cioè se, ribaltando i termini, il risultato e l’effetto della percezione non cambiano, ossia rimaniamo all’interno del medesimo codice. Se invece, ribaltando la situazione, si produce un senso di stranezza, cioè di uscita dalla coerenza e dalla serietà del codice, evidentemente sono all’opera due registri, due schemi, due ordini di importanza diversi.
Procediamo allora con un esempio. Agli inizi di aprile, passando da una delle librerie più importanti d’Italia, cioè la sede Feltrinelli di Largo Argentina, a Roma, ho notato che, accanto all’ingresso principale, si trovava una curiosa ma eloquente installazione: formata da un blocco di scaffali sui quali erano allineate le opere delle scrittrici italiane più famose del momento (Santacroce, Avallone, Ballestra, Mazzantini, Mazzucco, Ravera eccetera), e sovrastato da un cartello che nominava questo raggruppamento attraverso il titolo “Amiche geniali”, ispirato, evidentemente, alla tetralogia di Ferrante. Ho fatto una foto:

Proviamo a collaudare la valenza di genere di questa sistemazione attraverso il test del viceversa, cioè proviamo a immaginare la stessa situazione al contrario: prendo il titolo d’autore più importante in questo momento, il bel romanzo di Nicola Lagioia che si contenderà lo Strega con Elena Ferrante, e vi chiedo di immaginare un analogo scaffale intitolato “I feroci”. Ci fa un effetto strano, no? Qualcuno ride; qualcun altro non capisce: ammettiamolo, il ribaltamento è impossibile, “seriamente parlando”, e proprio l’impossibilità di capovolgere la situazione senza evitare l’impressione del carnevalesco dimostra quanto si osservava sopra sui modi diversi in cui “femminile” e “maschile” possono funzionare rispettivamente come espressione di ciò che è particolare o universale.
Non è serio – e per fortuna siamo tutti d’accordo – uno scaffale su I feroci; è serio, cioè rilevante, cioè credibile, lo scaffale delle Amiche geniali. Tra l’altro, il sussulto mentale per l’effetto di paradosso del ribaltamento ci fa mettere a fuoco una prospettiva testuale che varrebbe la pena di discutere di più non solo in termini culturali, o politici, ma in termini di retorica letteraria: mi sto riferendo al concetto di “rilevanza” (narrativa, poetica, ma come vedremo in questa sede mi limiterò per lo più all’ambito della prosa). Anche la categoria di Auerbach di realismo, per esempio, potrebbe essere riutilizzata sulla prassi delle proporzioni testuali per scomporre il concetto di serietà, per guardare meglio gli oggetti e i temi stessi evocati e messi in sistema dal discorso serio. Ciò che è rilevante, narrativamente parlando, come ciò che non lo è, produce modelli diversi di identificazione immaginaria e di costruzione della credibilità del mondo.
Ma la cristallizzazione delle identità di genere non passa soltanto dal soggetto, o dall’oggetto dell’enunciazione. È per questo che adesso leggeremo un incipit:
Nella luce prima, un ragazzo la spia. È immersa nell’agguato ventoso e salato dell’alba che si leva ancora vergine dal mare, per tuffarsi poi nelle strade avvolte dalla penombra.
Le frasi e le immagini fatte inondano il discorso; c’è una pretesa di enfasi pseudodannunziana (“che si leva ancora vergine dal mare”) e una cura per la ridondanza che – con movimenti letteralmente e figuralmente maldestri (l’agguato dell’alba, che si tuffa poi nelle strade…) – tendono all’illusione di un’esperienza estetica alta, al kitsch catartico. Niente di male: siamo, più o meno consapevolmente, dentro i territori di una scrittura molto convenzionale, tant’è vero che il topos della verginità evocata dallo sfondo di uno scenario atmosferico suggestivo richiama un po’ le tonalità dell’incipit di Mimì Bluette fiore del mio giardino, di Guido da Verona:
Perdette la sua verginità, la prima volta, una sera del mese di Aprile, per uno di que’ casi accidentali cui si espongon le vergini, le quali sono per natura destinate a non esserlo più.
Mimì Bluette è del 1931. È passato quasi un secolo; eppure, come si vede, il modello ha resistito con vitalità, e semmai è variato in relazione a un altro ambito, nel senso che oggi non si farebbe fatica a credere che si tratti dell’attacco “vibrante” di un romanzo scritto da una donna – volendo usare un aggettivo tanto tremendo quanto usato per recensire libri di autrici. Magari si tratta dell’incipit di un volume “rosa”. E invece è l’attacco del nuovo romanzo di Alessandro D’Avenia Ciò che Inferno non è (Mondadori, 2014); e a questa citazione, a dire il vero, si potrebbero accostare molti brani, altrettanto allagati di retorica, tratti dall’ultima fatica di Alessandro Baricco La sposa giovane (Feltrinelli, 2015).
Proprio questi esempi ci aiutano a considerare che non sono soltanto i temi, o le forme, ma anche, talvolta soprattutto, i modi della percezione (un tempo si chiamava estetica della ricezione) a produrre sistemi di riconoscimento e di significato, ordini simbolici che, attraverso il linguaggio, costruiscono familiarità col mondo. Ragionando su questi piani allora: quali discorsi, quali storie possono disporre di una credibilità narrativa indifferenziata, e quali no? Non è una domanda inutile, visto che, a quanto parrebbe, e non solo leggendo i romanzi ma la produzione di discorso critico che li circonda, a seconda che si tratti di un’autrice o di un autore a firmare l’opera, i modi della percezione possono variare. Tant’è vero che il sentimentalismo elegiaco, anche nei suoi effetti più kitsch, se ha una titolarità maschile può essere riconosciuto e consumato come l’emozionante sorpresa, la miracolosa rottura, l’eroica crisi di una vita pensosa, e può far parte, tecnicamente parlando di una tensione narrativa. Nel caso femminile, viceversa, il sentimentalismo, quando non sia stato recintato in partenza dentro un target di genere, non è serio, è trattato paternalisticamente, insomma si sgonfia molto più facilmente in una risata – plausibile si può aggiungere – per la maldestra prosa di un registro patetico malgestito.
Se questa spartizione di scaffali e di relativi campi letterari e simbolici agisce; se esiste questa diversa quota di credibilità narrativa, ciò succede anche perché opera un immaginario che riposa, ora tranquillamente, ora no, su una grammatica definita da precisi ruoli e identità che, è banale dirlo ma non inutile, proviene da lontano; da così tanto lontano, per certi versi, da aver reso questa struttura impercettibile, guardata, consumata esteticamente, riprodotta, ma mai vista davvero. Nel prossimo esempio, che è tratto dall’opera di uno degli autori che più apprezzo, potremo sperimentare la sostanza letterale dei termini “guardare”, “vedere” che ho appena usato. C’è un racconto di Calvino Il nome e il naso, dedicato al senso dell’olfatto, e poi raccolto ne Il sole giaguaro. Il protagonista è un seduttore parigino rimasto conquistato dall’odore di una dama sconosciuta incontrata a una festa in maschera. Dopo aver cercato in tutti i modi di rintracciarla, finalmente giunge all’abitazione, dove si svolge però il funerale, e il profumo ormai è sempre più confuso con l’odore della morte. Il nome e il naso uscì per la prima volta nel novembre del 1972 sul primo numero dell’edizione italiana di «Playboy». E non fu l’unica collaborazione: sulla medesima rivista uscì un’intervista a Calvino, e un altro suo racconto. Persino Montale, per dire, rilasciò un’intervista a «Playboy».
(E a questo punto del discorso spero che mi siano perdonate tre parentesi. Prima parentesi: mi sono soffermata con molto divertimento sull’effetto di stranezza, sull’avvertimento del contrario che, fantasticando, mi ha procurato lo scenario di una situazione simile ma rovesciata: con, ad esempio, Alessandra Sarchi, Helena Janeczek, Monica Pareschi – per indicare intanto le scrittrici qui presenti – intervistate, ritratte in posa pensosa a una scrivania, e messe accanto al “paginone centrale” ripiegato in tre con qualche fenomenale macho fuori formato, o magari, che so, con un nudo di Riccardo Scamarcio. Seconda parentesi: è il rovesciamento, appunto, e in particolare gli effetti di spaesamento che ci procura, che mostrano bene come la replica eventuale – quante volte ripetuta da coloro che ben pensano – su una certa vena “moralistica” di questo mio discorso, su una presunta postura censoria, non c’entra nulla, perché la libertà è un’istanza etica, anziché un alibi, quando rimane un argomento serio per tutti – e per tutte. Terza parentesi: la riprova di quanto sfogliare le pagine di «Playboy» non fosse niente affatto un gesto indifferente, ce la offre la prima sequenza del romanzo di Moravia Io e lui, in cui il protagonista, a p. 12 della prima edizione, del 1971 – Moravia evidentemente si riferiva alla versione americana – sorpreso dal giornalaio a sfogliare la rivista, dice «La fiamma della vergogna mi investe il viso»).
Torniamo dunque a Calvino, a Montale, o ai molti altri autori intervistati o chiamati a collaborare con «Playboy», e ricominciamo a guardare questa immagine, che torna dal passato come la foto ingiallita di un carissimo zio immortalato in un safari degli anni Settanta. Di cosa ci parla questo gioco di verità, guardato dentro quell’epoca – oggi il discorso sarebbe in parte diverso; di cosa ci parla questa progettazione degli spazi in cui stanno i corpi, questa pratica di accostare come anche di vedere accostati maschile e femminile secondo una sintassi che più biopolitica – secondo Foucault – cioè più capace di costruire un immaginario che disciplina i corpi lavorando sul desiderio – non si potrebbe: da un parte il femminile in quanto corpo muto e spogliato; dall’altra e in sequenza dialettica il maschile in quanto logos.
Dunque, e soprattutto, di quali campi di forze sociali, di quale orizzonte d’attesa ci parla il senso di assoluta normalità con cui si afferma la scena della presa di parola – di allora come di oggi: la sede dell’intervista o dei racconti tutt’al più è citata con qualche risatina, ma mai prestando attenzione all’immaginario implicato da quella situazione, mai provando a stupirsi per questa nostra mancanza assoluta, se non altro di curiosità, con cui registriamo “il dato”. Come si vede, la resistenza del modello, e delle abitudini di sguardo da esso previste, fanno tornare in campo la categoria simbolica e narrativa a cui si accennava sopra: quella di credibilità.
I rapporti tra i sessi e tra le generazioni sono, come spiega la sociologia, alcune delle coordinate principali intorno a cui si costruiscono le biografie private delle varie epoche. È interessante trasferire quest’idea in ambito narrativo, perché allora diventerà meno semplice rispondere alla domanda di partenza (esiste una scrittura maschile?) con un unico NO. Ora, infatti, potrebbe cominciare a essere interessante la possibilità di dire invece SÌ, ammettendo cioè che esistano dei marcatori di genere molto datati, è vero, ma non per questo percepiti come tali, o spariti, o in crisi – almeno in tanti casi. Potrebbe perfino cominciare a diventare interessante, per la discussione, osservare che gli accenti di genere più marcati, molte volte, riguardano proprio la scrittura d’autore anziché d’autrice. E il discorso conserva cifre addirittura più evidenti, spesso, proprio in Italia: dove è ancora molto ricorrente e desta una certa impressione di sfasamento temporale, soprattutto se si guardi al paesaggio da una prospettiva internazionale, la persistenza di un’abitudine alla scrittura come compiacimento per l’autoaffermazione “virile”; o come passione quasi inconsapevole, per così dire, per lo sputtanamento (la parola va intesa anche in senso letterale oltre che metaforico), cioè per il bisogno di dare forza comunicativa al discorso attraverso strali, guizzi spassosi, spiritose strutture d’appello che di passaggio, tanto per ricordarsi di essere molto simpatici oltre intellettuali, già che si trovano buttano là una battuta sessista; così, indifferentemente, come nella meravigliosa canzone napoletana, o per il gusto di fare una cosa un po’ sporca, dicendo le parolacce tanto per scandalizzare, come se si imbrattassero i muri del bagno del collegio. Oppure potrà trattarsi della persistenza, spesso mi pare impercepita, quasi fosse una reazione automatica, su una certa idea d’antan di ironia come ammiccamento a vivere piacionescamente da veri uomini, attraverso l’allusione a un femminile pronto all’uso (- A voi italiani è rimasto questo chiodo fisso qui! – gridava Totò, era il 1959, nel bel film Arrangiatevi!, di Bolognini).
Un altro esempio rapido di quest’ultima ricorrenza, tratto dall’inserto culturale del più importante quotidiano nazionale: su «La lettura» del 7 aprile scorso è stata pubblicata l’Introduzione alla nuova edizione di Rabbit, preparata da Alessandro Piperno ma rifiutata all’ultimo momento dagli eredi di Updike. Il testo esordisce paragonando la diversa fortuna critica di Flaubert, studiatissimo, e Balzac, molto meno studiato, proprio perché avrebbe scritto tanti, troppi libri. «Così scoprii che la prolificità è nemica della fortuna postuma. E che uno scrittore, per risultare seducente, deve tirarsela: proprio come una bella ragazza».
A quali assetti, a quali costellazioni narrative contribuisce a dar forma l’attitudine a questo sguardo sul mondo? Quali sistemi di opportunità e di crescita modella, quali campi d’azione e di espressione, quali parabole di trasformazione, quali attese intorno alla definizione di un destino pubblico come privato, mette in scena? Se recuperiamo queste domande per sollecitare i testi – vale la pena precisarlo: spesso anche di autrici – la dominante di destini letterari, di trame che, radiografate, ci riportano alla sintassi dei ruoli e alla grammatica di quei numeri di «Playboy» di cui parlavamo poco fa ricorrono molto più di quanto non si pensi. Non è così abituale, insomma, incontrare modelli narrativi del mondo non così esclusivamente costruiti attorno a parabole virili che si tendono in primo piano, mentre sullo sfondo operano le due varianti di un femminile familiare muto, o peggio ancora lagnoso, da un lato; e, dall’altro lato, di un femminile esotico che svolge, come un animale tropicale, la funzione del perturbante animalesco. Quasi che certa letteratura, talvolta, riluttasse ancora ad accogliere i segnali di mutazione già registrati da Donna Letizia in un libro che meriterebbe di essere mandato a memoria per evitare i cliché, nelle scritture, nelle sceneggiature, vale a dire il manuale Saper vivere (1960). Ci sono infatti tante donne, tante storie di donne che, come constatava appunto l’autrice, stanno viaggiando, e potrebbero trovare più spazio per i mondi di carta:
non è raro che delle donne sole mi scrivano […] per confidarmi il loro imbarazzo: vorrebbero fare un viaggetto, prendersi una vacanza fuori del paese o della cittadina dove vivono, ma al momento di decidersi mille interrogativi le angosciano. Potranno recarsi sole al ristorante? E la sera potranno uscire senza essere accompagnate? E se capita loro in treno, in pullman, in albergo, di fare qualche conoscenza maschile?
Eppure i sistemi di relazione o di conquista di un’autonomia definiti dai mondi d’invenzione messi a punto dalla narrativa contemporanea non rimangono sempre distanti dagli stereotipi già stigmatizzati come anacronistici da Donna Letizia. E la distanza di cui parlo non è solo tematica, ma, soprattutto, di stile, di costruzione di sguardo attraverso la scrittura. Me la caverei facilmente se – usando il modello di Simonetti nel suo bel saggio su cosa desidera la narrativa contemporanea – invocassi soltanto esempi stabiliti dal mercato dei bestseller; farei presto, troppo presto, cioè, a citare la coppia Gamberale&Gramellini, o Facci, o Volo, o di nuovo Baricco – eppure, detto di passaggio, proprio questi modelli di desiderio favoriti dal mercato creano simmetrie significative, non solo in termini di tirature, con i bestseller esposti in una delle Librerie Cattoliche più importanti d’Italia, quella di Via della Conciliazione, a Roma, dove càpita di vedere messe accanto la colonna delle copie di Ero gay. A Medjugorje ho ritrovato me stesso, di Luca Tolve, e la pila di Sposati e sii sottomesssa, di Costanza Miriano.
Non è solo quella che un tempo si chiamava paraletteratura ma anche, certe volte anche di più, la letteratura di qualità che continua a raccontare il mondo come era ai tempi della Coscienza di Zeno (tanto per citare il romanzo più bello del Novecento, ambientato nella società di cento anni fa), o all’epoca in cui il codice Rocco condannava l’aborto come «attentato alla stirpe». Permane insomma, talvolta come dominante, la messa in scena di un mondo femminile fissato in una relazione ausiliaria (madre, figlia, sorella, moglie) o come termine di una contrapposizione schematica (amante versus moglie) stabilita dalla cultura borghese ottocentesca e lì rimasta. Diciamolo attraverso Lacan – che non è solo l’autore della legge del padre – la narrativa molte volte mette in scena, ingenuamente, uomini ingombrati dal fallo per i quali la donna è sintomo, senza che ci sia godimento dell’altro in quanto tale. E non solo in termini di energia psichica, ma in termini di costruzione dei soggetti e della storia. E il problema, spesso il guaio, è che tutto questo potrebbe interessarci, anzi senz’altro ci interessa, perché nessun tema di per sé va scartato a priori; però è troppe volte raccontato senza ironia, senza extralocalità, ma, al contrario, con una persistente/residuale tendenza al priapismo normalizzato che non c’è niente da fare: non diverte più, non è traducibile all’estero e, soprattutto fuori dall’Italia, di solito anzi annoia:
All’epoca dei miei vent’anni, quando mi veniva duro con una scusa qualsiasi, e a volte anche senza motivo, quando in un certo senso mi veniva duro a salve, avrei potuto essere tentato da una relazione di quel tipo […] ma adesso ovviamente era fuori discussione, le mie erezioni, più rare e accidentali, esigevano corpi sodi, elastici e senza difetti (Michel Houellebecq, La sottomissione)
Passaggi simili sono modi vecchi di scrivere. E non è un problema di età – Theodor Fontane pubblicò Effi Briest a settantacinque anni – ma di capacità di costruire un punto di vista, di disponibilità a guardare il mondo senza credere a tutto quello che si pensa, come invece accade al protagonista di Houellebecq, in un romanzo completamente sottomesso a un monologismo senza extralocalità, senza ironia, senza il meraviglioso umorismo – per citare non una strada unica ma un esempio – con cui Zeno Cosini conquista sempre di più e di nuovo chiunque legga La coscienza.
Un altro esempio di esibita marca maschile: tratto da un libro che è un romanzo importante, per l’ambizione del progetto narrativo e per l’edificio testuale che gli dà forma:
Un tempo, quando il Pianeta era più freddo, anche qui era più freddo e il vento era più forte, più secco, e tutto ciò che era sotto un certo peso prima o poi volava via. Ti volavano via i capelli dalla testa e i peli dal pube, finivano sul mare e oltre, a posarsi sugli altopiani dell’Asia Minore, in Anatolia, in Siria (Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace, p. 109)
Il fatto è che mentre il desiderio femminile – inteso come tema, come eros, ma anche come spinta narrativa al racconto, nel senso indicato da Peter Brooks in Trame – è per lo più percepito e riproposto come discorso interno al genere della narrativa “rosa”, il desiderio maschile vale ancora come pulsione di affermazione, carburante avventuroso. Ora, il punto è che questa idea può sfiorare pericolosamente il ridicolo; se la maschilità rimane un presupposto che si fonda in se stesso, se insomma resta una mitologia, per quanto sostenuta da una eroica tradizione che attraversa i poemi epici e la chanson de geste, rischia, nel ventunesimo secolo, di ricordare, più che Omero, il romanzo mitomane di Marinetti Mafarka il futurista (1909); in altre parole, e rapidamente, questo immaginario, se agisce solo come interesse esclusivo a raccontare la storia unica del maschio affamato di poligamia per necessità biologica di affermazione di potenza e conquista di libertà sessuale, diventa e rimane poco più di un cliché. L’antimateria dell’io in letteratura – come altrove – è l’ironia in quanto senso pieno della finzione: se questo dislivello sparisce, l’immaginario maschile può diventare monotona ripetizione di sé, come accade, magari non ingenuamente, nell’ultimo volume di Francesco Piccolo (Momenti di trascurabile felicità, 2015), così brutto rispetto a La separazione del maschio (2008); mentre invece un altro libro, stavolta di Covacich (Prima di sparire, 2008), metteva in scena un io maschile vulnerabile più interessante, anche nel suo egoismo, dei racconti troppo uniformi del recente La sposa. Mi pare che sia Domenico Starnone, col recente Lacci, lo scrittore italiano più disponibile alla narrazione di un immaginario virile situato nella storia anziché nel mito.
È tempo di concludere. Vorrei farlo aggiungendo un’ultima possibile serie di considerazioni. L’attitudine culturale, spesso incontrollata e impercepita – quasi fosse un impulso o comunque un uso che arriva da un immaginario arcaico – a tener sottomesso, recintato il femminile, fissa una genealogia del maschile che certamente esprime un’ansia di aggressione, come è stato osservato, studiato, detto, tante volte – tutte necessarie. Ma forse vale la pena di considerare meglio come questa violenta negazione non assecondi soltanto un’istanza di dominio, ma esprima anche altro, come tutte le aggressioni, vale a dire un sentimento di apprensione, la paura di un pericolo immaginato, o immaginario. Per spiegarmi meglio citerò un brano tratto da uno dei libri più belli di Pavese, Dialoghi con Leucò, che è una raccolta di ventisette brevi rielaborazioni di situazioni mitiche reinventate in forma dialogica per delineare una sorta di fenomenologia dell’uomo moderno. Il passaggio che stiamo per leggere è dedicato al mito di Meleagro, la cui vita era legata a un tizzone che la madre Altea cavò dal fuoco quando le nacque il figlio (in uno scatto d’ira la donna ributtò il tizzone nel fuoco e lasciò incenerire il figlio):
Meleagro. Una madre… nessuno conosce la mia. Nessuno sa cosa significhi saper la propria vita in mano a lei e sentirsi bruciare, e quegli occhi che fissano il fuoco. Perché, il giorno che nacqui, strappò il tizzone dalla fiamma e non lasciò che incenerissi? E dovevo crescere, diventare quel Meleagro, piangere, giocare, andare a caccia, veder l’inverno, veder le stagioni, essere uomo – ma saper l’altra cosa, portare nel cuore quel peso, spiarle in viso la mia sorte quotidiana. Qui è la pena. Non è nulla un nemico. [4]
Non è nulla un nemico. Questo disperato risentimento maschile per il materno ricorda un passaggio dell’ultima intervista a Bolaño:
– Cosa avrebbe detto a Gabriela Mistral se l’avesse conosciuta? –
– Mamma, perdonami, sono stato cattivo, però l’amore di una donna mi ha fatto diventare buono –
Mamma, perdonami, sono stato cattivo. Torna in mente il Codice Canonico, nel punto in cui prescriveva, durante i matrimoni, che gli uomini amassero le donne come Cristo la Chiesa. Torna in mente, per non uscire dal tema, che di solito si trascura di discutere veramente il titolo del romanzo di Littell Le Benevole (Les bienveillantes, 2006), vale a dire le Furie, le figure mitologiche del rimorso, che più di tutte incarnano il fantasma di un femminile furioso e persecutorio, mitologicamente spaventoso, perché evocatore di sangue e ferimento. Come lo spacco di Lucio Fontana nella copertina: un’immagine così fortunata da essere poi ripresa per le edizioni non solo italiane, forse perché l’energia figurale di quel rosso spaccato di traverso allude anche a qualcosa di profondo. Lo voglio dire – perché se la letteratura non insegna a saper usare le parole vere non serve a molto – quella copertina ricorda anche una fica. Ciò che evoca il mondo femminile, e non solo in letteratura, molte volte fa paura, produce passioni inconciliate come la vendetta, la violenza, il rimorso. Come il fantasma di una madre che incombe. E del resto la scrittura d’invenzione – e il discorso vale anche per il cinema – riesce più spesso a parlare della madre in caso di morte.
Mamma perdonami dice Bolaño, e forse ci aiuta a riflettere sulla possibilità di una relazione tra due circostanze, vale a dire tra il fatto che l’Italia sia il sistema culturale in cui i figli maschi sono più legati dalle proprie madri, e il fatto che sia anche il paese in cui quegli stessi figli talvolta scrivono narrazioni così tanto colonizzate da vecchi stereotipi sul femminile. Forse ci aiuta a dire meglio che il prezzo al maschilismo non lo pagano soltanto le donne – e che decolonizzarsi, uscire dalle maglie strette di una storia unica, è quasi sempre un vantaggio, e in genere non soltanto letterario.
[Questo testo è stato letto il 18 aprile 2015 alla Biblioteca delle Donne di Bologna, in occasione della giornata di studio Davanti e dietro la scrittura. Donne e uomini alle prese con identità di genere, ruoli, gerarchie e riconoscimento pubblico, organizzata da Alessandra Sarchi e Annamaria Tagliavini. Hanno partecipato Daniela Brogi, Tiziana de Rogatis, Luisa Finocchi, Helena Janeczek, Roberta Mazzanti, Giulio Mozzi, Luca Pareschi, Gino Ruozzi, Alessandra Sarchi, Annamaria Tagliavini, Grazia Verasani, Giampiero Rigosi, Bia Sarasini. La registrazione degli interventi è visibile presso questo link: http://tinyurl.com/qz2gofp
Per favorire l’esposizione orale sono stati evitati o ridotti al minimo i riferimenti bibliografici e le note]
[1] A. Munro, Uscirne vivi, in Racconti, a cura e con un saggio introduttivo di Marisa Caramella. Traduzioni di Susanna Basso, Mondadori, Milano 2013, p. 1775.
[2] Per cui cfr. Anna De Biasio, Studiare il maschile, in «Allegoria» 61, 2010, pp. 9-36.
[3] Torna periodicamente anche nei dibattiti americani; indico il link di un articolo a titolo di esempio: http://lettura.corriere.it/narrativa-sostantivo-maschile/
[4] C. Pavese, Dialoghi con Leucò, Mondadori, Milano, p. 84.
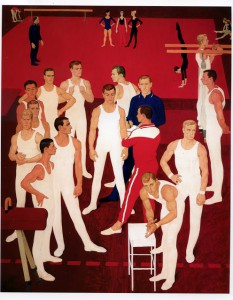
Devo ammettere che ho qualche difficoltà con la tesi sostenuta in questi appunti, che immagino sia più che altro una proposta provocatoria.
Daniela mi perdonerà se mi permetto di precisare che il contrario di misoginia è misandria: un termine forse poco noto, ma il fatto che si affermi che non esiste va a favore degli argomenti combattuti in questo articolo, ed è solo per questo che mi sembra utile chiarirlo.
Non afferro bene neanche l’esempio delle amiche geniali e dei feroci: le prime sono una trovata pubblicitaria ridicola e piaciona, esattamente come potrebbero esserlo i secondi. Perché dobbiamo sostenere, seppur provocatoriamente, che “le amiche geniali” sono “rilevanti, cioè credibili”? soltanto perché questo esempio è stato usato? Non è un po’ azzardato affermarlo solo perché questo esempio si inserisce in un immaginario comune, ricco – su questo siamo tutti d’accordo – di clichés da superare? Senza contare che il concetto di amicizia cattura positivamente l’attenzione del potenziale cliente, laddove la ferocia è connotata negativamente.
La stessa operazione in cui si scandagliano gli esempi letterari mi sembra parecchio arbitraria – il che non è necessariamente un male, ma dove ci porta? Magari a identificare esempi di “scrittura virile” nella maggior parte dei romanzi scritti da uomini, ai quali pure riconosciamo un valore letterario, ingigantendo il caso che ci interessa e tralasciando il resto, il contesto. Houellebecq è solito utilizzare un determinato approccio al sesso per caratterizzare i propri personaggi: proprio nella citazione qui in oggetto, a me salta agli occhi la sua ossessione per la giovinezza (che travalica il sessismo); mi viene in mente anche l’ossessione per il corpo liscio, cifra della contemporaneità, di cui parlava Baudrillard.
Mi piacerebbe sapere da Daniela Brogi se questa della scrittura maschile resta una proposta provocatoria, una ipotesi sociologica, che trova il suo posto all’interno del dibattito attuale; o se ha e/o dimostrerà di avere, a suo avviso, anche un fondamento letterario (come è chiaro, su questa seconda ipotesi sono più perplessa).
Siamo state 2000 anni lontane dalla storia scritta. (LOnzi). Ci sarà pure una differenza nello scrivere, nel percepire ed essere percepite, anche nella confusione di identità, legittima ,per carità,ma solo odierna , dei gender,transgender,omo etc.Abbiamo tradizioni etniche nostre generazionali, delle ave,orali e scritte,dipinte.Vanno esaminarte come linguaggio e modo di abitare il corpo e il mondo.
Il linguaggio è importante. Parliamo e insegnamo ai nostri figli, nenie, favole, canzoni, inventate da noi o tramandate.
Semiotica, linguistica, identità di genere
(dice Benveniste: “E’ nel linguaggio e mediante il linguaggio che l’uomo si costituisce come soggetto; poiché solo il linguaggio fonda nella realtà, nella sua realtà il concetto di “ego”. […] La coscienza di sé è possibile solo per contrasto. Io non uso io se non rivolgendomi a qualcuno, che nella mia allocuzione sarà un tu.”)
L’identità può essere individuale o di gruppo, in entrambi i casi può darsi solo come concetto oppositivo. Perché un gruppo si ponga come unità compatta è necessario espungerne le eccedenze, le singolarità che potrebbero comprometterne l’effetto di omogeneità; l’unica maniera per riuscire in tale compito è crearsi un “nemico” a cui affidare tutte le differenze, su cui proiettare tutte le proprie marginalità.
Se è vero che tale operazione è stata compiuta in maniera sistematica e radicale nella contrapposizione uomo-donna, per cui il soggetto sociale e linguistico che ha parlato più forte è riuscito a tematizzare la differenza dell’altra, definendola alla luce delle proprie paure, del lato oscuro del proprio desiderio che rischiava di scompaginare l’unità del proprio gruppo, unità peraltro indispensabile nella ricerca e nel consolidamento del potere, è altrettanto vero che anche vedersi riflesse nello specchio dell’uomo ha permesso alle donne di trovare delle categorie di riferimento di gruppo a cui affidare il compito di sancire le proprie peculiarità: la differenza sessuale rimane uno dei modelli di identificazione a cui far riferimento e che vengono introiettati in maniera assolutamente capillare. Da un punto di vista linguistico, possiamo parlare di stereotipie, “luoghi comuni”, cioè luoghi del discorso che presuppongono la comprensione condivisa dei gruppi che ne fanno uso e quindi rinsaldano l’idea di appartenenza.
Non credo che si possa uscire da tale meccanismo avvilente e restrittivo semplicemente valorizzando la differenza di genere e dandole uno statuto forte, offrendo la possibilità alle donne di parlare con più autorevolezza per creare i propri modelli di riferimento comportamentale e di pensiero. L’operazione sarebbe speculare all’altra, sposteremmo la nozione di soggetto da universale a sessuato, il che, in realtà, implica un’altro lavoro di universalizzazione, di definizione e dunque di marginalizzazione delle singolarità.
Una maniera per sottoporre ad investigazione critica i luoghi in cui gli stereotipi di genere si sono consolidati ed hanno contribuito ai meccanismi di dominio ed esclusione delle donne dagli spazi del potere e della libertà è rinunciare alla pretesa di trovare cause, origini o verità del desiderio femminile e dell’identità sessuale, e riconoscere la natura relazionale di concetti come donna o femminilità. Le categorie dell’identità sono gli effetti di quelle istituzioni, discorsi e pratiche politiche che svolgono compiti di definizione ed il soggetto femminile per il quale si cerca di ottenere rappresentanza politica è esso stesso “prodotto” dai sistemi giuridici di potere che poi lo dovrebbero rappresentare e tutelare. Naturalmente asserire tutto ciò non implica negare l’esistenza della ripartizione in “generi” dell’umanità, bensì evidenziare come tale ripartizione non sia relativa a dei “corpi innocenti e naturali” e dunque precedente ad ogni tematizzazione concettuale o inscrizione nel simbolico, ma profondamente marcata dalle pratiche discorsuali e filosofiche che li hanno così suddivisi e gerarchizzati.
Sono veramente due i sessi? Non potremmo rivisitare transvalutandolo il concetto di “neutro” e riutilizzarlo come spazio della non-definizione, del “né l’uno né l’altra”, dunque anche come spazio etico di rispetto per l’alterità che ci si rifiuta di tematizzare, mantenere tale spazio come sfondo che sembra interrogare le certezze acquisite per rimetterle sempre in gioco? Non si tratta di riproporre la finta neutralità del soggetto che ha posto la propria parzialità mascherandola con l’universale. Si tratta piuttosto di cercare luoghi del discorso e del pensiero in cui non si rinsaldino altre universalità, per quanto di segno femminile.
Naturalmente non è possibile essere ingenue o troppo radicali: non si può rinnegare la nostra appartenenza al simbolico, o rinunciare del tutto ad utilizzare concetti, categorie e tutte le altre “stampelle” linguistiche e filosofiche che ci servono per tenere a bada l’angoscia del non-sapere e per entrare in relazione con gli altri grazie ad un codice almeno in parte condiviso. Se è vero però che i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo possiamo provare a dilatare questi confini mettendo in dubbio quelle certezze sulla ripartizione binaria del mondo che si pongono come naturali evidenze ed invece, a ben guardare, sono costruzioni storiche e di discorso.
Proviamo a focalizzare la nostra attenzione sulla pratica della scrittura letteraria. Sono recenti e diffusi i tentativi di caratterizzare una “scrittura femminile”, di definirne gli aspetti salienti e ricorrenti in modo da contrapporla ad una modalità maschile di produzione di opere letterarie e da avere un corpus di testi in cui identificarsi, a cui far riferimento, in cui trovare risposte. Perché cercare nei testi di scrittura l’identità di genere? Proprio qui dove ogni concetto di identità, coerenza e compattezza del soggetto si rivela illusorio, viene messo in crisi o rivelato come inganno, dove si rendono visibili conflitti e contraddizioni di significato attivare una lettura critica del testo che voglia rintracciare somiglianze, caratteristiche comuni o addirittura definire le peculiarità di una scrittura femminile risulta restrittivo e funzionale ad un pensiero incapace di decostruire le opposizioni dicotomiche tra maschile e femminile e che ha necessità di inventarsi i propri “luoghi comuni”, ad un pensiero che non riesce a figurarsi l'”eterogeneo”, il “misto”.
Vorrei portare un esempio tratto da un testo letterario. C’è un racconto lungo di Doris Lessing che ha per titolo The Fifth Child [Il quinto figlio] , la cui lettura produce un effetto inquietante anche perché risulta difficile inserirlo all’interno di una categoria di “genere”. Non è facile decidere se si tratti di un racconto realista o se appartenga alla fantasy, ma l’effetto più propriamente sconcertante è dato dalla tematica che affronta, cioè quella della maternità. Questo luogo sacro del femminile, da sempre soggetto alla retorica più melensa o più subdola, viene rappresentato come carico di ambivalenza ed indecidibilità.
Il racconto si apre con una coppia felice, Harriet e David, che a dispetto di ogni ostacolo è in grado di costruire la vita da sempre sognata: una grande casa accogliente sempre piena di amici, quattro figli che nascono desiderati e che si integrano perfettamente nelle coordinate del progetto familiare. Quando la donna rimane incinta per la quinta volta qualcosa accade qualcosa di indefinibile. Il suo rapporto con il bambino che ospita non ha più nulla della gioiosa vitalità che aveva caratterizzato le altre quattro gravidanze; c’è una istintiva, fisica repulsione per questo essere che invade l’interno del suo corpo ed asserisce la sua presenza con prepotenza, scalciando e provocando una serie di sintomi insopportabili. Sia il momento del parto che la successiva presenza del bambino rafforzeranno tale impossibilità di relazione: c’è nel bambino una vitalità spaventosa, che lo rende non inquadrabile nelle definizioni della normalità che di solito si danno, ma neanche tematizzabile come “diverso” da un punto di vista diagnostico. Riesce difficile classificare tale neonato che, però, con la sua sola presenza riesce a disgregare la serenità della vita familiare, a rompere l’incantesimo di un’esistenza immune dal conflitto e dal dolore: Ben non è bello o amabile, ma non è neanche fragile o malato al punto da poterne avere compassione. Al contrario è robusto, molto più pesante della media, muscoloso, resistente, forte. Su questa immagine di bambino ogni retorica dei buoni sentimenti si rivela inadeguata: “mostro”, “alieno”, “fatto di una sostanza differente”, “nemico”, non ordinario” sono alcune delle parole che nel corso del racconto vengono utilizzate per definirlo e che ne rimandano l’inclassificabilità.
Anche il momento dell’allattamento è carico di sgomento in quanto l’avido neonato sembra volere prosciugare la donna, succhiarle tutto il suo essere, svuotarla di ogni nutrimento. In queste descrizioni viene messo in luce il lato oscuro di un’esperienza come quella della maternità che è sempre stata espurgata di ogni inquietudine per ricondurla alla solarità di una funzione sociale condivisa e necessaria alla riproduzione del sistema. Invece essa emerge dal racconto come un’esperienza assolutamente singolare, non tematizzatile, ai limiti dell’ abiezione e relativa al rapporto tra due esseri (madre e figlio) che, pur essendo inscritti in una realtà storica, linguistica e sociale che ne determina e sancisce in buona misura i comportamenti, rimangono eccedenti l’uno all’altra: Ben è pensato come l’alieno, appartenente ad una razza diversa da quella umana, impossibile da comprendere e con cui non si può entrare in relazione se non abbandonando i codici sociali condivisi per cercare uno spazio di comunicazione in grado di leggere l’idiosincraticità dell’altro.
Probabilmente Ben si dà come il lato oscuro dell’infante (di ogni in-fante) nel momento in cui viene al mondo e porta con sé la possibilità di disgregare con la sua atopia ed imprevedibilità ogni strutturazione familiare: è il paradosso dell’altro non ancora inscritto nel codice – quell’altro che anche noi eravamo e di cui ci resta forse un’oscura memoria – che viene ricondotto al noto con un’operazione di nominazione e categorizzazione atta a disattivarne la potenziale minaccia.
Nel racconto la protagonista accetta di tenere quell’essere indefinibile ed eccessivo accanto a sé, rinunciando a comprenderlo, ma tentando sempre e comunque di entrare in rapporto con la sua vita: il prezzo da pagare è alto; significa sancire la rovina definita del sogno di vita familiare armonica ed esente dal dolore che solo la rimozione del “diverso” potrebbe ancora permettere. Nel momento in cui riconosce il diritto inalienabile all’esistenza di Ben lei valica quel confine che stabilisce i criteri della normalità e dell’umanità e si avvicina al territorio estraneo che l’altro occupa. Questo luogo di frontiera diviene così uno spazio di relazione reale benché inclassificabile, legata esclusivamente ad un “guardare reciproco carico di domande senza risposta.
Mi sono dilungata su questo testo perché mi sembra ponga indirettamente delle questioni interessanti relative alla tematica di cui sto trattando. La “figura” del quinto figlio (il suo essere maschio rafforza la distanza dall’identità della protagonista rendendo ancora più difficile ogni forma di “identificazione” con lui) è l’ingombrante presenza di ciò che non può essere codificato nel discorso, la disturbante invadenza dell’inaddomesticabile, che pur avendo origine all’interno di sé si pone immediatamente come altro. E’ la singolarità assoluta che richiede un rischio assoluto per poter essere ammessa a far parte del sociale.
Eppure ancora più dirompente potrebbe essere leggere questo Ben come la propria stessa vitalità resa estranea, soffocata, che il discorso potrebbe forse definire “maschile”, che ha familiarità con il dolore e la violenza, che non può riconoscersi in un’immagine limpida e definita, ma riceve dallo sguardo degli altri la condanna per la propria eccedenza. “Aspra e massiccia insorgenza di un’estraneità che se mi è stata familiare in una vita opaca e dimenticata ora m’incalza come radicalmente separata, ripugnante”. Riconoscere in sé la presenza di un’eterogeneità siffatta senza averne orrore, accettando il rischio che essa comporta di una confusione delle categorie, comprese quelle di genere, significa operare una svolta radicale rispetto a quei discorsi sulla differenza sessuale che rischiano di riproporre un femminile pacificato nella contemplazione della propria comunità di simili.
Ciò porta ad auspicare e a lavorare per un mondo che mutili il meno possibile le differenze e non le riduca a luoghi di simmetria speculare dell’identità. Infatti solo tutto ciò che eccede l’identità può dar vita a quello spazio di transizione tra sé e l’altra\o in cui è la relazione a creare i soggetti ed a modificarli e che si pone come unico luogo di eticità possibile.
Sono d’accordo con quanto lei ha scritto. Occorre liberarsi degli stereotipi rassicuranti, che semplificano le individualità e le ingabbiano in ruoli funzionali al sistema e alla sua perpetuazione.
Bisogna saper guardare a sè e agli altri considerando anche le eccedenze rispetto alla ‘normalita’, definita dal consenso irriflesso, e dotarsi di uno sguardo capace di riconoscere la propria e l’altrui complessità, per un’eticità responsabile.
La scrittura letteraria, indistintamente, nei suoi esempi migliori, svela l’incongruo e, così facendo, avverte il lettore riguardo a ciò che il senso comune lascia per definizione nell’ombra.
Trovo stimolante questa sollecitazione ad analizzare la categoria del “maschile” e i suoi effetti di verità e di autorevolezza, a partire da quali figure dell’immaginario muove, quali spazi, identificazioni e proiezioni informa. In effetti è categoria pericolosa, giacché tende ad additare una ‘essenza’, che invero vorrebbe smontare, o rischia di evocare sterili dualismi (in effetti mi immagino già un libraio scaltrito che accanto all’espositore delle “amiche geniali” mette quello dei “feroci” – perché no?); non mi pare però peregrino considerarla come un polo importante (ancora poco esplorato in Italia, credo) del vasto crinale delle relazioni di genere, sesso e sessualità che ci permettono di leggere bene tanta letteratura. Sul fatto che è giunta l’ora di finire di considerare un certo posizionamento maschile come quello di default mi sembra si possa concordare.
L’altro giorno aspettavo un amico per prestargli un libro di Sereni, La tentazione della prosa. Nell’attesa l’ho aperto a caso, su una pagina di diario scritta all’indomani dell’8 settembre: “non c’è nulla di più arduo e straziante, nulla che annienti di più e rubi un uomo a se stesso, nulla che faccia sentire più vinti i vinti, che il mettere loro sotto gli occhi le cose di prima, quali vivono e passano in occhi altrui e per altrui vicende. Così una donna amata e passata ad altri: si muove e parla, o tace, e ancora si sa che cosa c’è dietro quei moti e quei silenzi, ma non è il sapere che tutto ciò è per altri che ti dà pena – o non è solo questo -, è il sentire che altri ne prova delizia e ci legge e ci scopre, quasi fosse lui il primo, quanto già tu vi hai letto e scoperto; o, peggio, ci vede altro da ciò che tu vi avevi visto e cancella i tuoi segni, per sostituirvi i propri, dalla lavagna che è lei.”
Non è straordinario (e straordinariamente disturbante) come in queste poche righe Sereni riesca a far convergere l’idea della patria sconfitta e dei vinti umiliati nella figura di questa donna-lavagna, passata ad altri e, ‘peggio ancora’, scritta da altri? (Lei, ‘ovviamente’, non scrive, tutt’altri più “parla” o “tace”). Ancor più significativo però è come da questa commistione giunga ad affermare che l’autorevolezza della propria individualità (“maschile”, appunto – lui la chiama “animo virile”) consiste nell’avere il controllo “delle possibilità d’interpretazione e d’azione” “su una materia ancora viva” (=la donna/il paese).
Ci piaccia o no quel che abbiamo in eredità – la memoria culturale, la tradizione letteraria, lo spazio in cui i letterati si muovono – è (anche) questo, inestricabilmente commisto a tutta la *bellezza che autori come Sereni hanno indubbiamente creato. Il campo delle scritture è inevitabilmente affetto dal portato di questi immaginari, e dai tanti modi in cui siamo chiamati a curarli, reinventarli e/o sfidarli. Mi piace, dunque, l’invito di Daniela Brogi a pensare le scritture “maschili”, e la ringrazio di questo contributo.
Mi scuso per il passaggio rapido, ma intanto ringrazio per i commenti, utili a capire meglio, e in particolare sono tanto grata a Morresi perché introduce un passaggio nuovo e molto produttivo rispetto a quanto ho scritto: lo migliora e lo arricchisce perché questa mi pare la strada giusta; vale a dire proprio usando sguardi diversi si può comunque riuscire a dar valore alla cultura del passato senza appunto rifiutarla in toto, ma accogliendola con modalità più complesse- Sereni con Rosselli Fortini Zanzotto restano a mio parere tra le più grandi voci poetiche italiane del secondo Novecento.
il fatto che un uomo che scrive d’amore e sentimenti sia visto come più “autorevole” di una donna non dipende da come scrivono gli uomini rispetto alle donne ma dai pregiudizi di chi legge
Michel Houellebecq non sccrive di sesso nel modo in cui ne scrive senplicemente perchè è un uomo ma perchè è Houllebecq, non escludo che una scrittrice possa scrivere di sesso e corpi in un modo simile a lui, nè che un uomo possa scrivere di eros in un modo simile ad Anais Nin.
Quanto al parlare di mogli, amanti, madri e del rapporto complicato tra amanti, mariti e mogli, madri e figli ecc.bè sono cose che fanno parte dell’umano e la letteratura di questo si occupa poi ogni scrittore e scrittrice lo racconterà secondo la propria sensibilità ma non so quanto questa sensibilità abbia a che fare con il genere maschile o femminile cui appartiene chi scrive.
Poi, scusate la banalità, in un romanzo l’importante è avere personaggi e situazioni plausibili a prescindere dal genere di chi scrive
Quando si parla di “genere” spesso si fa un pasticcio confondendo identità di genere e identità sociale di genere (ruolo di genere).
Il pasticcio qui inizia con il blocco di testo in cui è citato Giulio Mozzi:
<>
L’autodefinirsi attiene all’identità di genere.
L’autoposizionarsi attiene al ruolo di genere, cioè come la persona cerca/trova un equilibrio (o il minor disequilibrio possibile) rispetto a come la società norma il genere. Ora siccome il genere considerato socialmente è un sistema di norme, un “ordine”, noi possiamo definire che cosa per una data società in un dato tempo sia il genere. Dal punto di vista del ruolo di genere, abbiamo a che fare con fatti sociali conoscibili.
Quindi possiamo confrontare la produzione letteraria con questa descrizione per stabilire che cosa è, secondo la nostra cultura, letteratura femminile o maschile, e persino, non dimentichiamolo, transgender o intersex.
Ma non possiamo connettere la produzione letteraria con l’identità di genere, perché questa non può essere ridotta in stereotipi come invece accade per la veduta sociologica sul ruolo di genere (persino l’autodefinizione è problematica dovendo fare i conti con un linguaggio collocato in un ordine di genere).
So che la psicologia ha tentato in tanti modi di operare una riduzione dell’identità di genere agli stereotipi di genere, ma ha dato risultati aberranti, si veda per esempio Money.
Quindi dal punto di vista dell’identità di genere, di ciò che intimamente una persona è, non ha alcun senso per esempio domandarsi se esiste una letteratura femminile o maschile o transgender o intersex, perché queste sono categorie definite in base a stereotipi di genere.
Se dovessi sintetizzare, direi: la letteratua è scritta da creature.
E che l’identità di genere non ha bisogno di definizioni ma di libertà.
Quando scrivo:
“la psicologia ha tentato in tanti modi di operare una riduzione dell’identità di genere agli stereotipi di genere”
mi riferisco, per esempio, a test diffusissimi come il MMPI che ha una scala m-f con item che fanno leva sugli stereotipi di genere, per es.: “mi piacciono i fiori”, “mi piacciono le riviste di meccanica”.
Si tratta di un test che pretende di afferrare tratti di personalità. Davvero grottesco.
Riporto la citazione che è saltata dal mio commento precedente:
“… esiste il genere, che non è una circostanza casuale, un’ideologia alla moda; ma, tanto per cominciare, è una situazione e un progetto di sé che – come scrive anche Giulio Mozzi nel suo blog – non consiste banalmente nell’indossare capi diversi di biancheria intima, ma produce autodefinizioni e posizionamenti differenti – in termini di linguaggio, di bisogni emotivi, di consapevolezza, eccetera).”
Caro Andrea, la parola su cui siamo più d’accordo e su cui possiamo costruire comunità, sperimentando anche forme diverse, è l’ultima che usa :”libertà”. ma il fatto è che la libertà è un punto d’arrivo, non di partenza. e sulle distinzione che poi lei introduce, penso che per certi versi possa aver ragione, e d’altra parte il brano dal racconto di Alice Munro citato nell’articolo mostra bene, mi pare, come le distinzioni e le opposizioni secche forse non funzionino così bene: autodefinirsi e autoposizionarsi sono dispositivi di formazione di destino che si intersecano, direi. ma grazie per le sue osservazioni. sia indulgente, perché come precisato alla fine del testo, e come mostra lo stile del discorso, l’intervento qui riproposto era stato preparato per un confronto seminariale, vale a dire contiene come suo presupposto il dialogo. grazie ancora.
La parola “libertà” implica diritto, quindi diritto all’identità di genere, che come lei saprà non esiste nel nostro ordinamento giuridico (esiste un surrogato giurisprudenziale chiamato “diritto all’identità sessuale”).
Quindi non è un punto di arrivo, sto parlando di un diritto umano fondamentale: è un punto di partenza in un sistema come il nostro che si ritiene personalistico, cioè che deve assicurare lo sviluppo della persona.
La distinzione tra “identità di genere” e “identità sociale di genere” non è una coppia binaria di concetti a cui lei pare alludere (“opposizioni secche”). Stanno su due piani diversi. L’identità di genere attiene all’etica, è un limite. L’identità sociale di genere è un fatto sociale, conoscibile come gli altri fatti, empiricamente.
Può capire meglio il mio discorso dalle implicazioni: l’identità di genere di una persona è autodefinita dal soggetto, non eterodefinita dallo psicologo.
So bene come funziona ciò che viene chiamato “dispositivo di sessualità”. Cerco di mettere a punto degli strumenti proprio per evitare che i concetti di cui ci serviamo, anche quelli che si incontrano negli studi di genere, producano soggetti configurandoli in un certo modo. Per questo insisto sulla distinzione che dicevo sopra e sulla necessità di introdurre un limite etico.
Grazie Andrea per il chiarimento; sono d’accordo e credo che le sue aggiunte possano aiutarci a pensarci meglio.
Il fatto che le risposte maschili tendano a “caldeggiare” la scrittura come unisex, almeno dal punto di vista dello scrittore/scrittrice visto come individuo, la dice lunga sul fatto che il punto di vista “maschile” esista, eccome.Negare questa differenza è sinonimo del senso di colpa del genere dominante, credo. Naturalmente questa considerazione non riguarda prettamente la letteratura di genere (che sì esiste, e non è un pregiudizio di chi legge ). E’ che sia donne che uomini negano che esita una psicologia femminile contrapposta a una maschile, da lì discendono volenti o nolenti (dalla natura) i diversi posizionamenti, desideri e linguaggi. Non esiste l’ unisex (per quanti generi si vogliano citare), esiste una forma dell’ anima diversa, al di là delle ragioni sociali, che differenzia nell’ identità di genere ma anche di ruolo. E anche quella di ruolo discende dalla diversa natura.
Murakami scrive che sono più le differenze individuali che quelle di genere/gruppo, e penso che non a caso si tratti di un uomo.
E Sì, tutta la storia del silenzio scritto delle donne si ripercuote nella letteratura odierna e indubbiamente lo farà anche il futuro.
boh. sia l’articolo (riccamente argomentato) che più di un commento mostrano un’invidiabile solidità culturale e analitica. eppure non riesco ad affrancarmi dall’impressione che maschile e femminile siano concetti astratti, simpatiche categorie kantiane del pensiero. se già nell’applicare la loro connotazione squisitamente binaria alla tangibilità fenotipica degli organi genitali si può cadere in fallo, ehm, figurarsi com’è buffo immaginare di poter suddividere l’intero mondo soggettivo e/o intersoggettivo in base a tale dualismo. come assai spesso accade, un approccio scientifico alle cose più o meno umane del mondo tende a descrivere curve a campana (gaussiane) dove le infinite sfumature di grigio trascrivono più fedelmente il mondo di un tifo contrapposto bianco-o-nero.
ah, peraltro, con l’occasione segnalo che un’altra parola squisitamente astratta è “libertà”.
: )
uno dei grandi malintesi invero è pensare che le astrazioni, o le generalizzazioni, o addirittura le menzogne, concezioni del mondo completamente inventate (per es.: l’idea di razza) non abbiano effetti di realtà.
Il punto è proprio trattare gli stereotipi di genere – attraverso i quali individuiamo i supposti due sessi sociali – come fatti sociali.
La letteratura maschile esiste eccome, ma come fatto sociale (di oppressione eccetera), non in quella psicologia metafisica che evoca sopra Elisabetta e che per un secolo ci hanno propinato psicoanalisti e figli della psicoanalisi.
sì, infatti è proprio quello che sto dicendo: maschile e femminile non sono confezionati nell’iperuranio, stanno invece in un continuum che modella le nostre vite reali (anche quelle ‘irreali’, per la verità, immaginate, desiderate e temute)
Il concetto giuridico “libertà” non è affatto astratto. Non potresti nemmeno uscire di casa se fosse astratto. Forse tu non hai idea della complessa struttura di diritti che permette la tua esistenza.
forse tu dovresti leggere meglio quello che ho scritto :)