Nel nostro mondo fluttuante
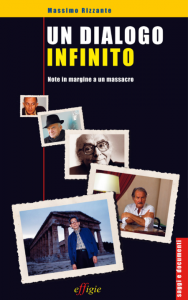
Pubblichiamo un estratto da Un dialogo infinito. Note in margine a un massacro appena apparso nella collana Saggi e documenti di Effigie.
di Massimo Rizzante
Un amico di Tokyo mi dice: «Sai, i giapponesi sono lotofagi. Mangiano letteralmente le radici del loto». «In questo caso – aggiungo – è il popolo che più di tutti gli altri dimentica il passato. E perciò è anche il più saggio della terra». «Non saprei – mi risponde un po’ perplesso. Forse desiderano dimenticare in fretta quello che è successo, abbandonarlo alla corrente del fiume. Preferiscono vivere nel presente, catturare l’istante…». «Sì. Eppure hanno vissuto la fine del mondo da molto vicino: Hiroshima, Nagasaki, Fukushima… Sai, sono stato a Hiroshima due settimane fa. Ho voluto andar- ci a tutti i costi». «Perché?». «Non lo so. A Hiroshima tutto è finito e tutto è cominciato». «Che vuoi dire?». «Dopo Hiroshima, l’uomo ha potuto verificare il potere della sua cospirazione contro la vita. Ha potuto constatare che è fatto della stessa sostanza delle ombre, come quella che si vede ancor oggi impressa su un muro in rovina della città. L’uomo non è niente, non è che un’ombra. Eccone la prova!». «D’accordo, ma la cospirazione non è mica finita…». «No, certo. Avendo constatato in concreto che poteva fisicamente scomparire dalla faccia della terra, l’uomo ha cominciato a credere che l’unica via di fuga per non trovarsi di nuovo di fronte alla catastrofe, fosse quella di scomparire in quanto individualità, in quanto individuo inimitabile…». «Pensi che lo abbia fatto apposta?». «In un certo senso sì. Qual è per un individuo il miglior modo di far scomparire la sua anima conservandone allo stesso tempo l’involucro, il corpo? Nascondersi dietro a un’uniforme; sviluppare un sistema burocratico molto elaborato e molto efficace, a volte assurdo ma in grado di diffondere una divina fiducia nella sua longevità; adottare comportamenti simili a quelli degli altri al fine di eliminare qualsiasi azzardo, qualsiasi gesto solitario e inconsulto che lo sprofonderebbe di nuovo nell’incubo; creare un sistema tecnologico tale che le relazioni umane non comportino più alcun piacere, non provochino più alcuna azione disinteressata, ma che, al contrario, sia in grado di assoggettare le funzioni fisiche e mentali delle persone attraverso un controllo gerarchico, graduale e meticoloso… Tuttavia, ricordati che tutto questo non è che un travestimento, un gioco, un modo di evitare la catastrofe che l’umanità ha già vissuto e che non vuole più rivivere». «Sembra un po’ il Giappone. O parli in generale?». «Ma te l’ho appena detto: il Giappone è il popolo più saggio della terra! Non solo i suoi abitanti dimenticano in fretta il passato abbandonandolo, come dici tu, alla corrente del fiume, ma soprattutto, meglio di tutti gli altri popoli, riescono a camuffare la loro anima. Non è che non ce l’abbiano, è che vivono il terrore da più vicino…». Mi domando: in che cosa consiste la tragedia più grande? Nel dimenticare il passato, o nel ricordarlo? Forse davvero la saggezza è nell’oblio. Forse questa umanità, così vicina alla fine, si rende conto che la tragedia è all’ordine del giorno e perciò preferisce dimenticare. In ogni caso, tra un anno o un secolo, bisognerà ricominciare da zero.
∞
«Noi tutti che apparteniamo al mondo fluttuante…». Amo molto questa frase. «Sai, il termine ukiyo (il mondo fluttuante) viene dalla tradizione buddista, secondo la quale tutto quel che c’è su questa terra è mutevole, effimero, insignificante. In altre parole, in questo mondo tutto è relativo, nulla è bianco o nero, nulla è certo, tutto è in bilico e quindi la sola saggezza consiste nell’aderire all’eterno cambiamento delle cose». «Beh, è più o meno ciò che in Occidente, dopo venticinque secoli di pensiero filosofico, facciamo ancora fatica a capire. Il romanzo, tuttavia, lo aveva compreso fin dall’inizio, all’incirca cinque secoli fa. Qui, in Giappone, mi sembra che il buddismo abbia scoperto questa verità già nel IX secolo: il mondo fluttuante sfugge alle convinzioni, ai pregiudizi, alla volontà di razionalizzazione. Perciò è vero che Budda può essere in qualsiasi luogo… del tempo e dello spazio!». «Devo precisare che il termine ukiyo ha conservato il suo senso originario fino al X secolo, fino all’epoca Heian, quella che ha prodotto il più grande classico del Giappone, Genji monogatari (Storia di Genji), di Murasaki Shikibu. Dall’epoca Muromachi (XVI secolo), e soprattutto durante l’epoca Tokugawa o Edo (1600-1867), il senso è cambiato. Il mondo fluttuante è diventato il mondo moderno, alla moda, il mondo dei quartieri del piacere i cui protagonisti erano gli attori del teatro kabuki, i ricchi mercanti e le corti-giane. È in questo momento che nascono l’ukiyo-e, il celebre genere pittorico (Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Sharaku ispirarono Van Gogh, gli impressionisti, Klimt), e l’ukiyo-zōshi, la prosa romanzesca che ha un grande fondatore, Saikaku Ihara (1642-1693), autore di almeno due opere affascinanti, Vita di un libertino e Vita di una donna licenziosa». «Ah sì, quest’ultimo l’ho letto… Davvero bello. È la storia di una vecchia prostituta, il cui corpo aveva conosciuto “più di diecimila uomini”. Racconta le sue avventure a una giovane coppia di fidanzati che per caso capitano nel suo ultimo rifugio. Se ricordo bene la vecchia a un certo punto confessa ai due giovani che “non c’è al mondo niente di più triste del mestiere della cortigiana”. Tuttavia, anche se dice di essersi trasformata in “un’erba d’amore appassita”, non rinuncia a offrirsi agli “insetti” che preferiscono “le foglie amare della sanguinaria” e a cui piacciono le carni avvizzite. L’ultima frase del romanzo è molto significativa. “Mi sono abbandonata alla corrente, ma il mio cuore non ne è stato intorbidato”. C’è stato un tempo in cui le prostitute godevano di un certo prestigio in Giappone (ma anche in Occidente), in cui lo studio di una donna che vendeva il suo corpo ci rivelava, come dice lo stesso Saikaku Ihara, “quante diverse sfumature vi siano in una stessa condizione alla deriva”. Da sempre ho nostalgia di quell’epoca. Non so perché…». «Forse perché dentro di te – dice il mio amico ridendo –, dietro quel tuo viso gentile e raffaellesco, si nasconde un libertino incallito, un uomo da bordello…». «Sì, forse. Ma soprattutto perché ogni volta che ho incontrato una puttana mi sono visto nei suoi occhi come in uno specchio». «E che cosa hai visto nello specchio?». «Un uomo disponibile, vulnerabile, disperato: tre delle innumerevoli sfumature di “una stessa condizione alla deriva”». «Pura fantasia, tu non sei un uomo alla deriva…», esclama il mio amico. «Forse, ma è così. All’inizio della Vita di una donna licenziosa, la vecchia cortigiana cita un breve dialogo tra due uomini: “L’unica cosa che vorrei è che il liquido dell’amplesso non si estinguesse mai, come la corrente di questo fiume”. L’amico, meravigliato, risponde: “Io invece vorrei che ci fosse un paese assolutamente privo di donne. Andrei subito ad abitarvi, se esistesse, così la mia vita, che tanto mi è preziosa, durerebbe più a lungo e potrei contemplare a mio agio le cose di questo mondo che incessantemente mutano e si trasformano”. Capisci la mia disperazione? C’è un paradosso insuperabile in questo nostro mondo fluttuante: se niente è stabile, se tutto è transitorio, dovremmo vivere mostrandoci sempre vulnerabili, disponibili a ogni avventura, a ogni piacere, a ogni cambiamento, come se fossimo in un’eterna condizione alla deriva. Ma proprio questo comportamento ci impedisce di contemplare e perciò di comprendere qualcosa di questo mondo che non cessa di trasformarsi». «Mio caro, a questo proposito mi viene in mente un detto di Bashō, contemporaneo di Saikaku e inventore dello haiku. Nel suo Elogio della quiete scriveva: “Più un uomo è stupido, più possiede dei pensieri”. «Ma non è Gombrowicz che lo ha detto?», ribatto in modo quasi meccanico. «Chi?», domanda, un po’ sorpreso, il mio amico.
∞
«Allan Watts, un filosofo inglese, amico di C. G. Jung, ha scritto nel suo Way of Zen: “Se provi a camminare sull’acqua, cerchi di afferrarla, e così anneghi. Per nuotare, devi rilassarti, offrire il tuo corpo all’elemento liquido. Se ti lasci andare, l’acqua ti sostiene; infatti, in un certo senso, il tuo corpo e l’acqua sono una cosa sola”», mi dice il mio amico mentre stiamo passeggiando nella folla di Shinjuku, il quartiere degli affari di Tokyo. «Che vuoi dire? È arcinoto il fascino che l’Occidente, nel corso degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, ha sentito nei confronti di questo “elemento liquido” e inafferrabile del pensiero orientale. La maggior parte di quella gente è passata dal satori agli allucinogeni. Come il tuo Allan Watts che ha finito i suoi giorni seguendo i seminari di Oscar Janiger, il guru della ricerca sulle proprietà creative del LSD. Forse ti sembrerà una follia, ma non è un caso se ancora ai nostri giorni dei sociologi tanto à la page quanto imbecilli scrivono libri sulla “società liquida” per spiegare che la ragione moderna occidentale, dal momento che il cittadino si è trasformato in consumatore, è fottuta. Guarda, anche qui il consumatore si abbandona alla corrente del fiume, o meglio del mercato… Il satori lo illumina nella scelta di un nuovo gadget? Pensi che la sola spiegazione sia che non c’è più niente di solido, nessun valore morale né in Oriente né in Occidente? Noi tutti viviamo da sempre in un mondo fluttuante! E questo genere di teorie non è altro che LSD per il grande pubblico». «D’accordo, ma non è per questa ragione che ti ho citato Watts. Volevo sottolineare ancora una volta il fatto che l’identità giapponese è malleabile, perfino schizofrenica…». «Forse dipende dalla storia del paese…». «Soprattutto a partire dalla Restaurazione Meiji (1868-1912), quando nello spazio di qualche anno il Giappone da società medievale si è trasformato, appropriandosi del modello tecnico e industriale occidentale, in una potenza economica moderna. Fu un’e- poca esotica, come quella che l’Occidente ha vissuto almeno due volte a distanza di un secolo, nel XIX e nel XX secolo. La transizione è stata drammatica, certo, a volte grottesca nel suo desiderio di imitare i gaijin (stranieri), ma penso che in Giappone la nozione di crisi sia diversa. Gli occidentali pensano che è nel momento della crisi che bisogna decidere (la parola greca κρίσις significa per l’appunto decisione) qualcosa, cambiare atteggiamento nei confronti del mondo. Vivono la crisi in modo patologico…». «Come adolescenti che un mattino, scoperti i primi peli nel pube, corrono a sverginarsi…». «Se vuoi. Ma come non sbagliarsi se l’errore esiste fin dall’inizio? In altre parole, che cambiamento è possibile in un mondo concepito come eterno cambiamento? La crisi, qui in Giappone, è una delle innumerevoli sfumature di una stessa identità in costante mutamento. Tale mutamento è ancor più privo di ancoraggi e punti di riferimento per il fatto che qui nessun pittore, nessun Dio ha mai disegnato l’uomo a sua immagine e somiglianza… Si possono perciò imitare gli altri, ciò che i giapponesi hanno fatto lungo tutto il corso della loro storia, senza perdere la propria identità che, del resto, non è costruita con il cemento ma affonda nelle sabbie mobili». Erano le sei del pomeriggio. La pioggia fine di metà giugno ci alleviava un po’ dal calore. Andammo in un caffè. Pensavo che c’era un altro modo di vedere la paura di sbagliare che appartiene al codice esistenziale dei giapponesi, questo popolo privo del mito del Labirinto… Sembravano timidi, distanti, perfino snob a volte, ma in realtà non facevano che interrogarsi su se stessi, su quello che dovevano fare o non fare in ogni situazione della vita. Tutta la loro cura, tutta la loro lentezza, tutto il loro perfezionismo venivano dalla paura, dalla paura di perdersi in un mondo che non aveva mai conosciuto il Labirinto e dove non c’era nessuna Arianna, nessun filo, nessuna logica, nessun logos, e questa paura perciò non potevano superarla attraverso l’analisi, attraverso il lavoro della coscienza che implica la crisi, ma per mezzo della grazia dell’istante che sa abbracciare allo stesso tempo l’armonia e l’azzardo. Ho compreso allora che per loro parole come tragedia o apocalisse non significavano niente. La tragedia implica sempre una ricompensa, non importa se fisica, psicologica o morale. Anche l’apocalisse implica una ricompensa: il paradiso, la resurrezione, un’altra vita. Ma in Giappone non esiste ricompensa: nel mondo fluttuante il disastro avviene a ogni istante. E tutti i disastri possono allo stesso modo trasformarsi in successi grazie a un istante privilegiato.
Che io sappia, si tratta di due ukiyo differenti. L’ukiyo che vuol dire “mondo flottante” viene scritto 浮世, mentre l’ukiyo della tradizione buddista, caratterizzato dalla transitorietà della vita nel suo ciclo di reincarnazione, viene scritto 憂世 o, nella grafia più moderna, 憂き世, letteralmente “mondo infelice“. Sempre a quanto ne so io, l’ukiyo del mondo flottante, con la sua connotazione edonistica, nasce come gioco di parole basato sull’ukiyo del mondo infelice.
Nota sull’editore. Effigie è una piccola grande casa editrice fondata da un editore – Giovanni Giovannetti – che ha dovuto sopportare intimidazioni persino da parte della ‘ndràngheta. Ma che non l’hanno comunque fermato.
Ho chiesto al Prof. Victor Mair del dipartimento di lingue e civiltà dell’Asia orientale dell’Università della Pennsylvania qualche informazione ulteriore sull’etimologia di ukiyo. La sua risposta esauriente è stata pubblicata oggi sul Language Log.