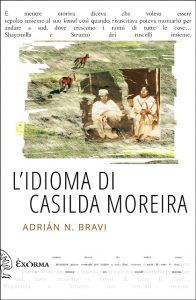Come nascono le parole di Adrián Bravi
di Marino Magliani
Mi piacerebbe sapere come nascono le parole di Adrián Bravi, non dico le storie. Le parole, le cose che immagino dipendano in qualche modo da quella che come la chiama lui in un libretto stupendo, La gelosia delle lingua, è: “La maternità di una lingua [che] non ci insegna solo a parlare, ma ci dà uno sguardo, un sentire, un punto di vista sulle cose”.
Mi piacerebbe dunque essere lì e seguire quello sguardo (gli occhi che poi sorridono, perché), i polpastrelli sulla tastiera, il reticolato che si stende davanti a questo signore proveniente da oltre pozzanghera, da un luogo liquido quasi quanto lo è proprio l’oceano che separa i suoi mondi, luogo pieno di isole, di banchi di sabbia, di paesi talvolta inondati e riemersi diversamente, la terra del fiume che ha popolato le rive di silenzi e racconti, vite, per citarne un paio, quella di Haroldo Conti con Sudeste e di Juan José Saer con El río sin orillas, e dell’Adrián Bravi che sembra essersi caricato sulle spalle un’altra chiatta di letteratura anfibia. Dico mi piacerebbe scoprire come nascono le parole nelle sue storie, perché sta lì il segreto della sua prosa. In uno scarto (ce n’è poi un altro di scarto, quello dell’altra lingua, ma lo vedremo) ci dev’essere un attimo, dopodiché qualcosa è stato inventato. Quello scarto avviene fin dalle prime pagine ne L’idioma di Casilda Moreira, l’ultimo romanzo di Adrián Bravi, uscito da un mese circa per l’editore Exorma. La buona comicità è un ibrido, può contenere una miscela di più culture, lingue, soluzioni, paesaggi, e certe cose di queste che a Adrián Bravi riescono alla perfezione. Occorre essere andati via (non arrivare in un luogo, come sostiene lui, ma andarsene da uno), e andati via davvero, intanto, coltivare in quella lontananza, ne parla Antonio Prete, l’appartenenza. Ma oltre all’essere andati via, manca qualcosa, io ad esempio sono andato via da bambino e quello che chiamavo lo scarto dell’altra lingua non l’ho mai conosciuto, forse, un po’ sì, nel passaggio dal dialetto all’italiano, una forzatura assurda, l’ammissione per un bambino che la frutta dissetante non esiste solo in una lingua ma anche in un’altra, e che se altra frutta quindi, con altri nomi, riesce a dissetarti, allora tutto dev’essere possibile al mondo… Poi non più, il francese che giungeva dal prossimo confine, l’inglese della strada, il castellano tra Spagna e Latino America, il nederlandese degli ultimi miei trent’anni, no, lo scarto dell’altra lingua non c’è mica mai stato. La lingua è una corazza, ti difende, mi pare dicessero Todorov o Brodskij. Poi giri l’angolo e lo scudo non lo trovi più. Nabokov non lo trovò più, o lo scudo non era più lo stesso. Neanche per Konrad. Si può tradurre da una lingua, si può imparare a scrivere in un’altra lingua, ma sentirne una nuova come una corazza, una tartaruga che si disfa di una cosa o che su quella cosa sente crescerne un’altra… Adrián Bravi c’è riuscito, scrive ormai solo in una lingua, la cui bellezza sta quasi in una traduzione perfetta di gesti, stili, paesaggi. Comicità.
Il romanzo inizia in una terra che assomiglia a quella delle Marche, terra di adozione dello scrittore. Il professor Montefiori, a causa di un incidente di percorso in quell’habitat liquido (mare, pozzanghera, fiume, canale, catalogo acque dell’ossessione braviana) non può fare il suo viaggio in Argentina, nel Nord della Patagonia, specie di sud profondo della Pampa, alla scoperta degli ultimi due rappresentanti del popolo günün a künä: che pare parlino una lingua che si estinguerà, un’antichissima lingua, il günün a yajüch.
È questo l’elemento scatenante. Annibale è uno studente di etnolinguistica, che segue il corso del professor Montefiori. E Annibale compirà quel viaggio. Giungerà, in aereo, treno e camion, alla meta: Kahualkan, microcosmo di case, tettoie e lamiere, una stazione del ferrocarril, in quel vasto contenitore di pianure e venti, ben a sud del sud della Pampa, dove inizia la fine del mondo raccontata Arlt, Payró, Chatwin, Gimenez Hutton, Osvaldo Bayer. E a questo punto la narrativa braviana tradisce un po’ quello che è l’asse liquido, inondazioni ecc. ma è come se il mare, delta, e questo tipo di elementi in genere, fossero assorbiti da quello che a tutti gli effetti diventa il mare del romanzo: la lingua, o la questione della lingua.
La lingua va bene, ma poi in Argentina succederà un po’ di tutto. Ci sarà l’amore, la violenza, il paesaggio, la lingua si salverà, e ci saranno i personaggi, fantastici, e le cose che faranno saranno pure loro fantastiche, ci saranno persino venditori ambulanti che proporranno agli abitanti di quella fine del mondo l’acquisto anticipato della propria cassa funebre. E ci sarà la vita, con le sue assurdità e la sua comicità, come non mancano mai dalle pagine di questo narratore giunto da lontano, che ogni tanto esce di casa e alla svolta si ferma a guardare, mettendo le mani sulla righiera, per guardare l’Infinito esattamente dal punto in cui lo guardava Giacomo.