Postcritica?
di Francesca Tullii
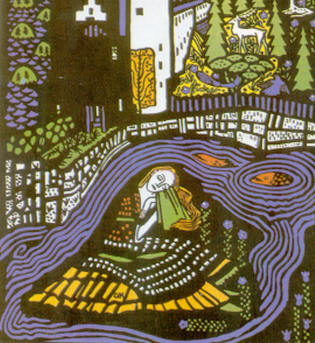
Mariano Croce, Postcritica. Asignificanza, materia, affetti, Quodlibet, Macerata 2019.
Alla ricerca di una linea di fuga dalla secca alternativa tra serietà e ironia, Gilles Deleuze proponeva un vero e proprio elogio dello humor. Dove l’ironia si delinea come la ricerca di un principio o di una causa primaria, come il tentativo di risalire a un archè ancor più primario di quello sul quale pretende di sprofondare la serietà; diversamente, lo humor trascura i principi, configurandosi come una tecnica delle conseguenze e degli effetti. Soprattutto, spiega Deleuze, “[l]o humor è traditore, è il tradimento. Atonale, assolutamente impercettibile, esso fa filare qualcosa. È sempre nel mezzo, sul cammino. Non sale o non risale mai, è alla superficie: effetti di superficie, lo humor è un’arte degli eventi puri” (G. Deleuze, C. Parnet, Conversazioni, Ombrecorte, Verona 2019, p. 67).
Ed è proprio una pratica del tradimento quella che Postcritica. Asignificanza, materia, affetti (Quodlibet, Macerata 2019) offre al lettore. Sin da subito, balza agli occhi l’impercettibilità di cui è intessuta la lingua del testo: già nella settima pagina, la pre-messa, figura abituale e codificata della saggistica, cede il posto a una pro-messa dichiarata a partire da un tradimento la cui “cifratura è un prefisso derivato dal latino che indica la durezza di una scelta: post” (p.7): il tradimento della teoria critica, riconoscimento della crisi del paradigma della critica come lente interpretativa dei fenomeni sociali e avanzamento di un atteggiamento alternativo – sperimentale – verso il mondo che insiste su affetti e legami. Ma un tradimento non è necessariamente un divorzio, al contrario, nella sua assoluta impercettibilità, fa filare qualcosa. Si tratta dunque di una rottura che, d’altro canto, si tiene con la teoria critica in un duplice laccio di anteriorità segnica (post-) e posteriorità concettuale (ciò che viene dopo la critica), ovvero con una propensione che ha fatto e che fa del sospetto il paradigma dominante della teoria sociale, a partire da una ricerca quasi ossessiva dei meccanismi profondi, affatto nascosti, che dirigerebbero il mondo – per fare qualche esempio, linguaggio, capitalismo, società. Tuttavia, se si tratti di una frattura scomposta, di un superamento o, ad andamento alterno e incerto, di un allineamento con la critica, è una via intenzionalmente e dichiaratamente non battuta da Mariano Croce, al fine di non consegnarsi a una “contrapposizione futile e fin troppo accademica” (p.69), sacrificio di un taglio operazionale, di composizione e ricomposizione di linee, riprova della sua rilevanza pragmatica. La promessa è infatti di fare postcritica con il proprio dire, adozione di una postura di maniera e sobrietà. Un dire, sospeso tra registro filosofico e linguaggio pamphlettistico, tra perizia argomentativa e fuggevole pennellata impressionista, nel quale è possibile udire l’eco del legein greco, in quanto esercizio di legatura.
***
Postcritica si inserisce direttamente in un dibattito internazionale che ha assunto crescente rilevanza in numerose discipline, tra cui la filosofia, la critica letteraria, la linguistica, la teoria sociologica e l’antropologia, riproducendone al suo interno il carattere assolutamente interdisciplinare. Sarebbero quindi molte le linee argomentative da poter seguire per sviluppare il discorso di Croce (anche solo riferendoci al sottotitolo asignificanza, materia, affetti); tuttavia, come si confà alla logica frattale che contraddistingue tale postura, ci si può arrischiare a dire che ogni linea racchiuda già tutte le altre. Ciò che preme qui è pertanto fare emergere uno dei nodi cruciali di Postcritica, ossia il chiasma materiale e squisitamente sinestetico di un “tocco ottico” e di “una visione tattile”, di un patchwork in continua variazione che si propaga e coinvolge tutti i sensi assieme, di un occhio miope che non guarda le cose ma si aggira tra di esse in cerca più di una via d’uscita che passi per uno scivolamento interstiziale che di un obiettivo fisso. In cerca di una finestra dimenticata socchiusa più che di una porta da scassinare. Tra le incombenze della postcritica allora non può che esserci quella di marcare il carattere tutto materiale degli effetti e delle int(e)razioni, del darsi di una realtà unica, esito, ma non mera somma, di eventi emergenti con peculiari conformazioni – a cui sono dedicati il terzo e il quarto capitolo, rispettivamente Le operazioni della materia e Le combinazioni e gli effetti – riservando alla materia e al tocco lo stesso statuto di “possibili accessi al mondo” al pari di ogni altro linguaggio. In altre parole, il mondo non ci si dischiude e non ci si rende comprensibile solo attraverso il linguaggio, bensì attraverso l’esperienza o, meglio, la continua sperimentazione. Ma questo allora vuol dire che non vi è una via d’accesso privilegiata e che, forse, proprio non si accede al mondo: vi si è già sempre, già da sempre; si è sempre nel mezzo, tra una molteplicità di molteplicità. In tal senso “l’individuazione del dettaglio, che fa la scena, è un’opera di taglio e ritaglio, che coagula certe singolarità privandole di molti elementi” (p. 68). Ma cosa vuol dire che l’individuazione di una singolarità è un’opera di ritaglio? L’individuazione di un dettaglio, di una entità, di un corpo, di uno stato di realtà, è sempre esito di una operazione di taglio, motivo per il quale ogni corpo è già sempre un individua(bi)le e mai un già individuato. Il ritaglio consiste allora nell’emergenza di certi rapporti di movimento a scapito di altri: possiamo venire a conoscenza di un corpo, di cosa un corpo può, solo di volta in volta, a ogni istante, e in base a un nostro preciso, ma non necessitato, modo di collocarci, e dunque di rapportarci, con gli altri corpi. Ecco perché fare e conoscere sono la medesima cosa. In un’ontologia monista che ha messo al bando il tempo (forti riecheggiano Deleuze, Spinoza e Carlo Rovelli) in favore di istanti operazionali emergenti che non si iscrivono nella durata, quella della sperimentazione resta la modalità par excellence per intravvedere il modo di connessione e di composizione di ogni linea, di ogni corpo e di ogni molecola. Individuare il dettaglio è cioè sempre un’opera che elude il controllo (tanto le manie di controllo quanto la società del controllo), motivo per il quale la postcritica si lancia in quello che Croce definisce un “elogio della sfocatura” (p. 69), metodo che presenta numerose corrispondenze con quello raccomandato da Bruno Latour. Se l’individuazione segue dunque la misurazione degli effetti, è d’obbligo altresì dichiarare l’incapacità di registrarne tutti, sicché la sfocatura è un’approssimazione e un diradamento dei contorni che avviene nel processo di individuazione e nel quale non è più chiaro cosa si sta cercando di osservare, nel quale la singolarità si individua rendendosi anonima, mostrandosi già sempre deformata, frastagliata, qualcosa di continuamente diverso da ciò che forse ci si aspettava, sfuggendo a qualsiasi riferimento, modello o significato. È infatti l’asignificanza, a dare forma a nuove combinazioni di corpi (p. 59), corpi che si cuciono tra loro in maglie dalle trame strette e fitte lungo anse di coinvolgimento sensoriale. Tutto il corpo e tutti i corpi sono coinvolti. La postcritica appare dunque una maniera di partecipazione a un mondo senziente che non è fatto di soggetti e oggetti di percezione; piuttosto, per dirla con Tim Ingold, è la percezione stessa a ereditare il movimento creativo di emergenza in cui le cose – come sostiene Merleau-Ponty – diventano cose, a favore di una reversibilità nella quale toccare coincide con l’essere toccato, e “ci si appropria di quanto accade con una presa di posizione che ci restituisce una natura molecolare vettrice di energia” (p. 82). Com’è evidente, si tratta di una maniera partecipativa segnata dalla reciprocità, dalla riflessività, dall’orizzontalità, ancor più radicalmente, dalla piattezza: l’appropriazione mi restituisce, ciò che tocco mi tocca, ciò che guardo mi guarda. O per richiamare una delle figure portanti di questo testo, Clarice Lispector, “il mondo si guarda in me, tutto guarda tutto, tutto vive nell’altro. In questo deserto le cose sanno le cose (p. 75). Ma ciò vuol dire anche che quel che critico mi critica, avviando un processo di trasformazione poroso. Non vi è più l’occhio dello spettatore (o del critico) separato e al riparo da ciò che vede e giudica: la torre d’avorio sempre più spesso imputata a coloro che esercitano l’intelletto è ormai un atelier, un laboratorio mobile che coincide col mondo in divenire, un legame pluri-direzionale in cui si sfocano soggetto e oggetto, agente e paziente, dando vita a nuove e inedite composizioni di elementi non solo umani: umani e non-umani, organici e non-organici e tutti questi assieme. In questo senso l’asignificanza è già una materia che, continuamente, si (ri-)compone seguendo linee assemblative dell’affetto considerato in quanto carattere capace di tenere “assieme come corpo […] qualcosa di più dei corpi che implica – senza però che il tutto sia più delle parti, perché la parti e il tutto abitano pur sempre uno stesso piano” (p.75).
Quello con il libro è dunque un incontro lieto. Indubbiamente portatore di quel quantum energetico di cui parla l’ottantunesima pagina, Postcritica sana la pretesa di avvicinare chi legge facendo postcritica. La promessa è pertanto mantenuta: tocca e si lascia toccare.