Istruzioni per l’uso di miracoli e tamburi
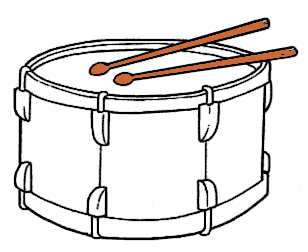
di Giuseppe Rizzo
Scongiuravamo la neve per tre motivi: casa nostra sarebbe crollata, mamma sarebbe morta, papà l’avrebbe ammazzata. Era lei che desiderava la neve. Nelle baracche di Fondo Picone, al fiume Oreto, tutti sognavamo un tetto da quando Gesù aveva inventato le case popolari e il sindaco di Palermo le aveva distribuite come ostie. A noi, niente. Secondo mamma perché eravamo dei peccatori. Secondo papà perché erano dei cornuti. Lei però insisteva: «I morti viaggiano nei fiocchi di neve, e portano miracoli per i vivi». Non era vero, ma era possibile, e ci credevamo perché avevamo un gran bisogno di miracoli.
Papà iniziò a crederci quando si convinse di poterci fare sopra un sacco di piccioli. La buona notizia era che aveva un piano per farlo. La cattiva notizia era che aveva un piano per farlo. Avevamo un bancone al mercato di Ballarò dove ogni domenica mattina vendevamo la roba recuperata dai cassonetti della monnezza la settimana prima. E questo, secondo lui, era già un buon inizio. (Per noi, invece, quel bancone rappresentava la metà dei nostri problemi. L’altra metà era Fondo Picone, ammasso di baracche cadenti che visto dall’alto sembrava un cimitero di denti cariati).
«A Capodanno al massimo siamo fuori da questa fogna», disse una sera, catafottendo la porta di ingresso con un calcio. Era la vigilia di Natale, e questo evidentemente lo aveva fatto sentire in diritto di fare un’entrata spettacolare. Tornava dalla taverna di via Filiciuzza, e si vedeva. E si sentiva. Puzzava. Barcollava. Gli scarponi pieni di fango, le spalle cariche di pioggia, gli stracci portati come se qualcuno glieli avesse tirati addosso. Entrando, disegnò a terra un’ombra di tristezza col fango. Poi si tirò su i pantaloni e spiegò IL PIANO:
«Lo vedete questo, questo è il più bel regalo che il Nazareno ci poteva fare per quest’anno».
Si riferiva al biglietto che aveva tra le mani. E a Gesù, ovviamente. Mamma si morse la lingua per entrambe le cose. Bestemmie non ne poteva sentire. E manco minchiate.
«È un biglietto della lotteria?»
Rosetta, a 6 anni, non aveva ancora capito che quando papà parlava di sorprese intendeva dire minchiate.
«È un biglietto del treno».
«Te ne vai in vacanza?»
Nino, a 18, aveva capito già tutto.
«Zitto, malacarne», lo freddò papà. Poi serrò gli occhi e il cervello e lesse: «“Palermo-Paradiso solo andata, seconda classe, carrozza numero 2”».
Ci guardammo come se avesse appena parlato un’altra lingua.
«Santa Rosalia Santissima – mi disse mamma – Teresì, vai a chiamare al dottore che a tuo padre si è intruppato il sangue alla testa».
Beh, poteva essere. Lo guardai. Poi guardai lei. La sua faccia di rughe appiccicaticce come le mensole della cucina. Era stato lui a modellare entrambe. Perciò. Scelsi lei e feci per alzarmi. Ma lui mi bloccò.
«Ferma, dai un’occhiata a questo, vediamo se cambi idea».
Mi passò il biglietto. Argento. Con le lettere ricamate sopra in oro. Dei fiori stilizzati in amaranto che correvano lungo tutti i bordi. E quella frase: Palermo-Paradiso solo andata, bla bla bla.
«Allora, a chi credi ora, a me o alla gallina vecchia».
Li squadrai di nuovo. Lo sguardo mi si incollò ancora su mia madre.
«Pezzi di minchia. Questo qui domenica lo mettiamo sul bancone a Ballarò. Ci facciamo i piccioli come niente. Con un paio di questi scherzetti gli leviamo pure le sedie da sotto il culo ai Di Fresco».
I Di Fresco. I nostri nemici numeri uno. Quando Palermo si accorse di Fondo Picone, sindaco, preti e giornalisti vennero a montare un po’ di circo sulla sponda dell’Oreto e ognuno di noi si votò al proprio santo. I Di Fresco riuscirono a sbloccare a loro favore la graduatoria per la casa popolare oliando le tasche di un assessore chiaramente in odore di santità. Papà, invece, scelse la via artistica. Si incatenò davanti alla nostra baracca e minacciò di darsi fuoco. L’indomani, al comune, gli dissero di riprovare con una cintura di esplosivo. Che la nostra, di pratica, s’era proprio persa.
«Quelli quest’anno si fanno il Natale sotto un tetto vero, e noi sotto la lamiera», ricordò mamma a papà.
Nino ci mise il carico: «Seh, vuoi mettere Fondo Picone con Brancaccio. Lì c’è pure il rischio che hanno l’acqua corrente!»
Papà gli si lanciò contro come un cane. Lo afferrò per il collo e iniziò il nostro gioco preferito. La lotta greco-palermitana: padri contro figli, mogli contro padri, figli contro resto del mondo. Non era il primo Natale che passavamo così.
Tre giorni dopo, domenica 28 dicembre, eravamo a Ballarò ad abbanniare le meravigliose invenzioni che secondo papà la gente avrebbe apprezzato, elogiato e infine comprato, aiutandoci a Fottere-Fondo-Piscione. Ed ecco i prodotti ecominchiacompatibili della ditta “Tirone e Figli”: anime usate (barattoli di nutella con dentro cotone e formalina), tramonti sull’Etna (occhiali con le lenti scarabocchiate d’arancio), qualche ettaro di cielo (contrattualizzato con carta intestata al comune, regolarmente rubata) e, ovviamente, biglietti di seconda classe per il Paradiso. Il primo ad avvicinarsi fu Lillino Tabbutu, casciaro e compagno di bevute di papà.
«Che è, Totò, novità?»
Aveva il ghigno di chi come lui campa costruendo bare e si aspetta in risposta una sola notizia. Quella definitiva. Papà, però, gli fece capire che non avevamo ancora bisogno che ci prendesse le misure.
«Ammuttamu, Lillì».
«Vero è, però oggi articoli nuovi ci sono. Se non te ne inventi una ogni domenica proprio non può essere».
«Tutte cose proviamo, Lillì. Per il bene delle creature questo e altro».
«Giusto, magari il Signore te la fa la grazia di diventare normale un giorno».
Casciaru se ne andò. Aspettai che svoltasse l’angolo con Rua dei Formaggi e tirai mio padre in disparte.
«Quanto deve durare questa minchiata?»
«Levati, che sei ancora piccilidda tu. A 18 anni Nino manco piscia all’in piedi, e tu a 15 la lezione mi vuoi fare?»
Sbottai.
«Ha ragione mamma, sei un fallito. Quando sentono la tua puzza, pure i cornuti cambiano marciapiede».
Abbassò gli occhi e se ne tornò dietro al bancone. Nino gli sputò sulle scarpe e se ne andò. All’ora della riffa, verso mezzogiorno, non c’era fesso che non ci aveva coglionato su quella storia delle anime e dei biglietti per il Paradiso. Don Calò, bottegaio di professione e usuraio per passione, sorteggiò il numero. Sei.
«Chi fu, chi fu?»
Nino esultò. Papà provò a protestare, aveva il 9.
«Ma com’è che si capisce che uno è 6 e uno è 9. Basta che lo giro, ecco qua. Uguali sono!”.
«Levati da davanti i miei occhi, cosa inutile».
Don Calò consegnò i due chili di baccalà di premio nelle mani di mio fratello e gli diede le spalle. Papà strinse i pugni e se ne andò. Mamma, vedendoci tornare senza di lui, non ci chiese neanche che fine avesse fatto.
Si rimaterializzò a Fondo Piscione la sera del 31. Entrando, la baracca rabbrividì ancora di più.
«Marì prepara il caffé. E fallo bello forte».
Mamma sturbò. Lo guardò per un attimo, poi fissò il braciere su cui eravamo tutti piegati. Si alzò per afferrarlo e catafotterglielo in faccia quando da dietro le sue chiappe si affacciò un tale con un bastone.
«E quello cos’è?», chiese Rosetta scivolando giù dalle ginocchia di mamma. Quello, il tale ad altezza chiappe, era un nano.
Papà: «Lui è il Principe».
Nino: «Seh, amunì, e io sono il Papa».
Io e mamma avevamo le mascelle ad altezza ginocchia.
«Allora, questo café?», fece il nano, andandosi a sedere a tavolino.
Per chi avesse ancora dubbi che la cosa fosse negoziabile, ci sbatté sopra il bastone. Poi iniziò a guardarci, accarezzandosi la lunga cravatta nera che gli scendeva fino al pipino. Papà capì che forse era meglio prepararlo con le sue mani, il café.
Smontò la macchinetta: «Il Principe qui per la casa è»..
«Vendiamo?», fece Nino.
«Non la nostra, la sua».
Papà era calmo. Sapeva il fatto suo. Il Principe tirò fuori dalla giacca una chiave appesa a una catenella d’oro. L’ottusità pendeva ancora dai nostri nasi. Papà mise i sottotitoli alla faccenda:
«Il Principe è interessato a quel biglietto, ricordate?»
Inghiottii. Vermi e chiodi arrugginiti.
«Ah, quello, il biglietto, certo».
Nino mi aveva detto che se vedeva ancora quel biglietto mi avrebbe scannata. E infatti non perse occasione per ribadire il concetto.
«I biglietti li vendono alla stazione».
Prima che si sbranassero, filai in camera a cercare quel pezzo di carta schifo. Mentre frugavo tra i panni miei e di Rosetta e di Nino, sentivo mamma balbettare di là:
«Facemmo un po’ di ordine, sa, sistemammo tutte cose, ora glielo troviamo, però».
Se non fossi ritornata in tempo col biglietto, probabilmente si sarebbe buttata ai piedi del Principe.
«Ecco qua il biglietto».
Sapevo che Nino mi avrebbe strappato la testa per averlo conservato. Prima che si alzasse dalla sedia per farlo, intervenne mamma:
«Il café è pronto».
Ci invitò tutti a tavola, ma il Principe bevve il suo come se fosse fuoco.
«Si può avere uno stecchino?», chiese.
Gliene presi uno. E lui puntò la macchia lasciata dai residui del café in fondo alla tazzina.
«Vedete, questa è la mia vita, una vita di merda, finché non ho incontrato mia moglie. Un angelo che ci volevano vero occhi per guardarla. Ora sono qui”.
Con lo stecchino indicò un punto in cui la macchia si assottigliava e lasciava intravedere il fondo della tazzina, disegnando una specie di nuvola nera affusolata al centro e rotonda ai lati.
«Vedete, qua devo saltare da una parte all’altra, sono sicuro che Giulia mi aspetta dall’altra parte, ma devo essere sicuro di farcela, e per questo ho bisogno del vostro biglietto».
«E in cambio ci da la casa, non fa una piega. Amunì, questo qua la farina doppio zero c’ha in testa», fece Nino.
Il Principe lo squadrò per un paio di secondi. «Deve essere dura per uno intelligente come lei vivere in un posto del genere, giusto?»
Mio fratello sembrò sentirsi capito per la prima volta nella sua esistenza. Le sue labbra disegnarono una “o” stupidissima. Stava per infilarci dentro qualche parola, quando il Principe lo seccò:
«Se ha una pistola la libero da questo peso. L’intelligenza mi è sempre stata sui coglioni, mi creda».
Le facce ci si colorarono di rosso, come se il sangue stesse friggendo nelle vene. Fu Rosetta a soffiarci sopra.
«Ma tua moglie te le lasciava dire tutte queste parolacce? Mamma non vuole assolutissimamente».
Piano piano, lentamente, il volto ingrugnito del Principe si sciolse in una risata.
«Quando arriverò a destinazione, smetto. Che dici?»
La mossa successiva ora stava a me. Guardai mio padre. Le rughe sulla sua faccia. Mai notate. Gli schiacciai un occhio e allungai il biglietto al Principe.
«Grazie».
E quella fu l’ultima parola che disse prima di andarsene.
Poi accaddero tre cose. L’indomani provammo la chiave nell’appartamento di via Libertà di cui il Principe ci aveva lasciato l’indirizzo: apriva. In serata si seppe che un tizio si era impiccato nei bagni della stazione centrale: un nano. Nella nottata, cadde su Palermo della strana roba bianca: neve. Nevicò per una settimana intera. Mamma non ebbe dubbi: in uno di quei fiocchi c’era pure il Principe. Mio padre la prese da un altro verso: «Chi ti dice di non suonare il violino, ti dice una minchiata, tu continua a suonare il tamburo».
Sapevo che non era vero, ma era possibile, e imparai a crederci perché il tamburo era lo strumento che volevo suonare da grande.
puro realismo magico, bello V.
Rizzo, ormai la tua Palermo è diventata un appuntamento abituale su questo sito. Una città infernale che come tutte le città infernali regala favole di immensa bellezza a chi le sa raccontare. Auguri.
m
Con i racconti dei due Peppe (Rizzo e Fiore) ci avete regalato un po’ di respiro in quest’afosa Italia ferragostana. Bravo Fiore, perché lucido e preciso. Bravo Rizzo, perché lirico e sognante.
martina
Quasi ogni frase è un’invenzione e lo stile è palese. Di questa Palermo malconcia e visionaria si sente l’odore: o forse la puzza che,come nelle migliori favole,diventa profumo.