Will, Grace, Franco Tritto e la Br # 1
di Giorgio Vasta
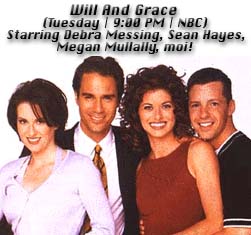
Quella che segue è la risposta a una domanda sul dialogo. Questa risposta (esattamente la domanda è: Quali regole seguire per scrivere un dialogo?), in una forma leggermente tagliata, verrà pubblicata insieme a molte altre in un volume dal titolo FAQ. Domande e risposte sulla narrazione (Holden Maps/Bur), in uscita nei primi giorni di maggio 2004. Il libro – che nel titolo si rifà alle Frequently Asked Questions dei siti internet – come si deduce è composto da domande e da risposte sul raccontare storie. Le risposte sono state affidate a narratori e a studiosi della narrazione. Mi permetto di riportare su Nazione Indiana la versione uncut della mia risposta. Si parla anche di logica dell’ironia, o meglio di “regime” dell’ironia, argomento discusso in questi giorni in diversi commenti.
Per una questione di praticità divido la risposta in due parti.
Per scrivere un dialogo non ci sono regole date a priori, così come regole simili non ce ne sono pressoché per nulla di quello che riguarda il narrare. Voglio dire che le regole non preesistono astratte ma vengono generate a partire da un’intenzione narrativa. Se stai scrivendo una storia che è come una partita di calcio, allora una delle regole sarà che non puoi toccare il pallone con le mani; se ne stai scrivendo una che è come una partita di basket, non potrai toccare il pallone con i piedi.
Detto questo, è utile, nello scrivere un dialogo, così come per tutto il resto della scrittura, ragionare sul valore (reale o preteso) di alcuni precetti. Tra i più diffusi, tra quelli che sono ormai diventati dei tormentoni tanto sono stati ripetuti e ribaditi, c’è quello per il quale un dialogo credibile (e vedremo man mano di riflettere su che cosa si vuole o si può intendere per “credibile”, sui parametri consueti di questa credibilità) non dovrebbe essere troppo “scritto”, non dovrebbe far sentire troppo la scrittura, anzi non dovrebbe farla sentire per niente, riuscendo a esistere nell’ascolto del lettore come un parlato vero e proprio e in quanto tale persuasivo.
Partiamo da questo assunto, quindi: un buon dialogo è quello che induce nel lettore un senso di realtà attraverso una serie di accorgimenti di verosimiglianza. Quando un dialogo è troppo scritto, sa troppo di scritto, allora non è riuscito bene, non è adeguatamente credibile.
Prendiamo i dialoghi della serie tv Will & Grace. Va in onda, nel momento in cui scrivo, tutte le sere alle 19,30 su Italia 1.
Non sono un appassionato spettatore di questa serie, ne ho una conoscenza limitata a un piccolo numero di puntate, o più esattamente di frammenti di puntate, orecchiati nelle ultime settimane. Ho diversi amici che me ne hanno parlato molto bene, mi hanno detto è bellissimo, divertentissimo, vale la pena di vederlo. Come ho detto, io un po’ ho seguito, ma non mi sono appassionato. Nessun coinvolgimento, soltanto un senso di imbarazzo, di malessere (del quale dirò dopo).
Will & Grace è una sit-com importata dagli Stati Uniti, dove ha un grande successo ed è diventata un piccolo fenomeno di costume. Anche in Italia ha avuto e continua ad avere successo, la gente ne parla molto bene.
Will è un avvocato di Manhattan. È bello, è gay. Grace è una sua amica. È carina, è eterosessuale. Accanto a loro ci sono altri due personaggi: Karen, l’assistente svampita di Grace, e Jack, un amico comune, anche lui gay. Ogni puntata dura venti minuti (pubblicità esclusa) e mette in scena i diversi accadimenti della vita di Will e Grace. Accadimenti che si manifestano essenzialmente sotto forma di dialogo. Buona parte delle scene è ambientata in un soggiorno, uno di quelli tipici delle sit-com, con al centro un divano sul quale stanno seduti a turno i quattro personaggi già descritti, oppure una delle guest star che più o meno a ogni puntata visitano la serie (in queste settimane ho visto Michael Douglas, Glenn Close, Cher). Per i venti minuti della puntata (pubblicità esclusa) Will, Grace, Karen, Jack e la guest star di turno, assortiti in combinazioni diverse da due a tre personaggi per volta, pronunciano battute di dialogo. Pronunciano battute di dialogo. Che vuol dire che quei personaggi non stanno parlando tra loro, nella convenzione della fiction, nella credibilità determinata dai succitati accorgimenti di verosimiglianza, ma stanno scambiandosi frasi che sono potentemente connotate dal proprio essere scrittura, script, sceneggiatura. Sono coerenti essenzialmente a un copione, piuttosto che a una qualche altra istanza interna alla storia. A un gusto, a un’estetica, non alle ragioni di una trama.
Addirittura, quando ascolto i dialoghi di Will & Grace ho la sensazione che gli attori stiano masticando pagine di copione (ottime pagine di copione, a quanto pare, ma pur sempre pagine di copione, script, appunto). Mi sembra persino di scorgere, a ogni battuta, frammenti di carta appiccicati sull’orlo delle loro labbra.
I dialoghi di Will & Grace sono considerati oggi, dagli “addetti ai lavori” italiani (sceneggiatori, script editor, story editor, dialoghisti, tutta la compagine della fiction televisiva che lavora principalmente a Roma, e un po’ anche a Milano), un esempio perfetto di composizione dialogica, un preziosissimo ordigno linguistico al quale ambire ma in sé inimitabile (inimitabile dalle penne italiane), perpetuabile soltanto dalle mani sante del team di sceneggiatori americani.
Will & Grace è considerato un esempio di grandi dialoghi. Questi dialoghi sono caratterizzati dalla brillantezza di ogni battuta, dalla loro acutezza-raffinatezza-sagacia-ironia implicita o esplicita-capacità allusiva, nonché dalla perentorietà dell’esecuzione, ovvero da una tempistica implacabilmente perfetta. Ogni alveo di silenzio, quando non è utile in sé a suscitare sorriso o risata, è immediatamente colmato da un gruppo rapido e ilare di frasi. Tutte metalliche, metallizzate, rilucenti. Una scultura di parole modellata in una lega al contempo elastica e resistente.
Will & Grace è considerato tale esempio di grandi dialoghi non “nonostante” il loro carattere artificioso bensì “a causa” di questo carattere, direi “attraverso” questo carattere. I dialoghi di Will & Grace sono perfetti nella misura in cui sono inverosimili, incredibili (nel senso di privi di quella credibilità fondata sugli accorgimenti di verosimiglianza realistica di cui nel nostro assunto di partenza), una giocoleria di parole del tutto sganciata dal terrestre e dai suoi criteri, e letteralmente “scagliata” nello spazio siderale della parola gloriosa. Voglio dire, cioè, che i dialoghi di Will & Grace, nella loro brillantezza (una brillantezza che constato ma che non considero implicitamente un pregio), sono dialoghi funzionali non tanto – o in minima misura – allo sviluppo della trama o di una singola scena, sviluppo ottenibile ugualmente con un numero molto inferiore di battute, di parole e in particolare di esclamazioni (Will & Grace è infatti una sit-com profondamente esclamativa, nella quale i personaggi impostano ogni loro scambio sulla constatazione più o meno stuporosa e scandalizzata di qualcosa, e se è vero che questa attitudine a una visione esclamativa dell’esistenza è un connotato proprio di un po’ tutta la sit-com, in Will & Grace questa attitudine raggiunge il parossismo), quanto alla spettacolarizzazione della parola intonata, della parola brillante, luccicante.
Ogni puntata di Will & Grace è un fuoco di fila di battute. Ognuna di queste battute è esorbitante, eccessiva (pur volendo essere sempre legata a una modalità understatement di comunicazione, ovvero alla sottrazione di enfasi e di retorica: quindi ogni battuta di dialogo è eccessiva in misura direttamente proporzionale alla volontà di sottrazione e di ridimensionamento).
Restando nei pressi della parola ‘esorbitante’, in Will & Grace assistiamo a uno spettacolo di battute che orbitano intorno a un nucleo ideale, il cuore tematico-atmosferico della puntata, battute che vorticano velocissime, quasi impercepibili (impercepibilità determinata anche dalla allusività delle battute stesse), senza mai scontrarsi tra loro. Si raggiunge il parossismo, ma sempre all’interno di una geometria indefettibile. Il collasso della comunicazione per surplus di comunicazione, un ammutolimento doloroso dei personaggi, evento secondo me interessantissimo e auspicabile, è soltanto minacciato, sollecitato, ma non accade mai. Ogni scena si risolve in una armonizzazione perfetta delle lingue e dei toni, senza nessuna crisi reale. Solo eleganza, coreografia linguistica. Del resto – e non lo sto dicendo ironicamente o con sufficienza – si tratta di entertainment.
Provo a inserire qui una considerazione circa quel senso di disagio e di malessere al quale facevo riferimento prima, quello che provo quando guardo e ascolto Will & Grace.
Si tratta di un malessere generato da quello che è il tono dominante di questa sit-com (ma il discorso può valere anche per la maggior parte delle sit-com). Un tono ironico-euforico con sporadiche venature isteriche (indotte, nel caso specifico, dai due personaggi-nevrosi, Karen e soprattutto Jack, il cui falsetto si accompagna e si interseca al modo di parlare “normale” di Will e di Grace). Un tono che sta all’interno di tutte le puntate, le permea integralmente, e insieme si inietta nell’aria tutt’intorno, e nella percezione di chi guarda e ascolta. Io non sono immune alla seduzione di questo tono, lo avverto come lo avverte chiunque (almeno credo che chiunque lo avverta), soltanto non riesco ad assecondarlo, ad accogliere questo tono godendone come si dovrebbe, come mi propone.
Avverto la seduzione e oppongo resistenza, la resistenza genera il malessere, Will & Grace mi fa stare male. Se questa resistenza non ci fosse, andrebbe tutto bene. Ma questa resistenza c’è, e c’è a partire da un sospetto, un sospetto che poi è un timore. Che Will & Grace, nei suoi limiti – da non sopravvalutare assolutamente pena lo scadimento nella più cupa paranoia – sia oggi così gradito e mitizzato perché costituisce in qualche modo una sintesi della sensibilità che tende a instaurarsi nella nostra cultura, nel nostro Occidente giovane ed evoluto (per lo meno in parecchi di quei settori ai quali viene riconosciuta oggi una rappresentatività). Una sensibilità, un modo di vedere il mondo, che dovrebbe essere una forma di progresso, un’evoluzione delle strutture di percezione e conoscenza, considerato che pone a propria base lo svuotamento della retorica e l’abbassamento dell’enfasi, l’abbattimento dei valori tradizionali e la sistematicità implacabile del dissacrare tutto e tutti, concentrandosi sull’ironia come condizione comune a tutti i linguaggi. Ugualmente, per quanto in astratto possa essere d’accordo con queste premesse, quando ho la sensazione di vedere tutto ciò incarnarsi in una puntata di Will & Grace, io sto male. Sto male perché ho paura dell’istituzionalizzarsi dell’ironia, della sua santificazione (dell’ironia come nuova retorica leggera e fiammeggiante), tutte operazioni che sottraggono all’ironia qualunque potere corrosivo ed eversivo riducendola a piccolo totem neutralizzato, a un costumino corrivo e omologante(-si), una pistola caricata a salve (si pensi all’intrattenimento televisivo anche non fiction, qui in Italia, dalle Iene a Zelig alla Gialappa’s Band a Camera Cafè: sì, mi diverto, mi diverto ma sto male).
E sto peggio quando, non all’interno di una fiction tv ma dal vivo, di sera, durante una serata tra amici, mi rendo conto che per trenta secondi o per un intero minuto le battute si combinano perfette e raffinate, tempisticamente ineccepibili; mi rendo conto che sono lì con Francesca e Massimiliano ma insieme a noi, seduti intorno al tavolo in cucina, ci sono anche Will, Grace, Karen, Jack, ironici e tempistici anche loro, nostri amici e maestri di percezione e di sguardo sulle cose della vita. Quel senso di intesa che viene a instaurarsi, quel livello di condivisione compiaciuta della propria brillantezza, la consapevolezza che una patina di fiction esplicita e imitativa (indubbiamente proporzionale al nostro stesso desiderio di fiction) si è venuta a depositare leggera e serena sui nostri corpi, tutto questo mi fa stare molto, molto peggio.
Ecco, è esattamente questo che non sopporto di quei dialoghi e della tonalità loro relativa: l’impazzimento razionalizzato, divertito e divertente, l’idea che il legame, la relazione tra le persone, possa consistere al suo meglio in un carambolarsi reciproco di parole. Sento tutto questo come un lineamento sempre più diffuso, sempre più accolto e condiviso. Dovrebbe piacermi, mi fa stare male.
Fatta questa considerazione, e riprendendo da quanto dicevo prima, il nostro assunto di partenza non vale più, o deve essere sostanzialmente modificato. Un dialogo, in determinate circostanze e rispetto a ben precise finalità, può essere fondato sull’eccesso e sulla non verosimiglianza. La credibilità fondata su un generico realismo non è quindi il parametro decisivo per pensare a un dialogo.
Ma andiamo avanti. A me interessa infatti riuscire a individuare, se è possibile, un’altra credibilità, un altro livello di percezione dei dialoghi; vorrei riuscire a comprendere se è possibile, e in che modo, dare fiducia a un dialogo, indipendentemente da tutte le questioni relative alla verosimiglianza.
Restiamo ancora su Will & Grace.
Mi sono accorto che quando ascolto i dialoghi di questa sit-com mi vengono in mente gli Harlem Globe Trotters. Gli spettacoli degli Harlem Globe Trotters.
Gli Harlem Globe Trotters sono una squadra di basket, se non mi sbaglio composta solo da neri americani, che se ne va in giro per il mondo giocando le sue partite. O, meglio, più che giocando delle vere e proprie partite, mettendo in scena il basket in chiave spettacolare-clownesca. L’obiettivo degli HGT non è vincere la partita – nonostante poi la vincano sempre – quanto esaltare la spettacolarità del gioco mescolando l’atletismo all’intenzione comico-grottesca e all’ironia. I giocatori, vestiti con una divisa sgargiante, si ritrovano ad arrampicarsi uno sull’altro per sovrastare il canestro, si nascondono il pallone sotto la canottiera mentre i loro stessi compagni si guardano in giro disorientati domandandosi dove sia finito, organizzano sequenze di palleggio con passaggi velocissimi e perfetti, la sfera rimpallata con mani gomiti spalle e testa, lo spettacolo circense della pallacanestro. Uno spettacolo, mutatis mutandis, molto simile a quello dei dialoghi di Will & Grace, appunto.
In nessuno dei due casi l’obiettivo è quello di far andare realmente avanti l’incontro, in entrambi i casi l’obiettivo è intrattenere. La tensione è simulata ma non c’è, perché se ci fosse potrebbe generare ansia nello spettatore, e questo risulterebbe controproducente. A mancare, in una partita degli HGT, così come nei dialoghi di Will & Grace, è la dimensione agonistica. I dialoghi in Will & Grace esistono separati, lo si diceva prima, dalla necessità reale di far andare avanti la narrazione. Non sono agonistici, non hanno interesse a raggiungere un risultato che stia loro oltre. Il loro risultato coincide con il loro stesso darsi all’ascolto, sono apparizioni di parole del tutto immanenti a se stesse. Va bene così, come si è detto si tratta di intrattenimento, soltanto che nello stesso modo in cui una partita di basket degli HGT non è una partita di basket credibile in quanto priva di una reale dimensione agonistica, alla stesso modo i dialoghi di Will & Grace non sono, per me, dialoghi credibili perché indifferenti, a priori, all’intenzione di spingere avanti non tanto la narrazione – tutto sommato quello è un fatto secondario – quanto una tensione reale, un’incandescenza concreta, il volere e potere fare del male.
Secondo me i dialoghi di Will & Grace, nella perfezione della loro fattura – relativamente agli obiettivi che la sit-com si propone – non posseggono credibilità perché non ambiscono mai a sfondare le proprie stesse parole. Preferiscono mettere in scena questa visione delle cose, incapsulata nel già detto spazio siderale, senza sporcarsi le mani con l’umano.
Dunque. Credibile sul livello che dà credibilità a un dialogo non verosimile rispetto a determinati canoni, Will & Grace non è credibile su un altro livello, quello complesso articolato e contraddittorio dell’umano. Will & Grace è del tutto indifferente a tutto ciò che è grossolanità, incompiutezza, sbavatura, affanno, in sostanza alle declinazioni del terrestre. È un compartimento linguistico stagno, nel quale l’umano inteso come odore forte, come consistenza amara, come cosa antiestetica, o meglio non-estetica, disarmonica e sgradevole, non entra mai. Desidera un empireo dialogico, gode della sua messinscena.
Condivido tutto, dalla prima all’ultima riga.
Mi è servito anche per chiarire a me stessa cose che già pensavo o intuivo, ma confusamente.
Trovo eccellente questa maniera di spiegare e di divulgare.
Grazie Giorgio. Intervento notevolissimo. Ora leggo anche la seconda parte. Fino a oggi avevo avuto poco tempo.