introduzione
di Giacomo Verri
La vicenda editoriale di questo libro è insolita e bizzarra.
Tutto ha avuto principio con un «c’era una volta», o quasi. Nell’estate del 2008 mi capitò tra le mani un articolo apparso il 25 aprile 1958 su un settimanale locale, il Corriere Valsesiano (la Valsesia è la parte settentrionale della provincia di Vercelli), dove l’uscita di un ‘Gettone’ Einaudi dovuto a un tale Remo Agrivoci era data come fatto certo. Il paragrafo non portava firma, o sigla, e pensai a uno stelloncino redazionale. Tuttavia l’articolo, che titolava «Anche la Valsesia avrà un ‘Gettone’» era troppo ampio per essere uscito dalla penna di un redattore anonimo e, allo stesso tempo, troppo breve per l’importanza che il fatto meritava. Inoltre lo stesso giornale, né prima né dopo quella data, faceva altro riferimento al ‘Gettone’ valsesiano.
Inutile dire che il libro di Agrivoci non uscì mai; anzi, proprio in quel 1958, l’esperienza dei ‘Gettoni’ giungeva gradualmente al termine. Così tornai a rileggere l’articolo ponzato d’enfasi, di retorica spiccia e di poco garbato campanilismo, del quale conservavo copia in un quaderno dalla copertina limone:
Era tempo che la grande editoria prestasse attenzione alla nostra piccola valle e agli artisti che la popolano: Remo Agrivoci è uno d’essi e ci ha annunziato che pubblicherà presso Einaudi, nella oramai avviata collezione dei ‘Gettoni’, un suo romanzo neorealista, Partigiano Inverno, con il quale dipinge un bellissimo, aggraziato e intenso quadro dei nostri luoghi e un fiero ritratto degli uomini più nobili tra quelli che, schiacciato il cuore dal piede invasore, liberarono la Patria col coraggio e la fede nella libertà. Tra città e monti si muovono, nel cuore dell’inverno del 1943, tre personaggi che rappresentano le età della vita: Umberto, un giovinetto di dieci anni o poco più, che, seppur imbevuto della rettorica del regime, finisce per trovare una propria visione della vita, nobile e dignitosa, lontana dalla logica assurda che gli veniva inculcata; Jacopo, un ragazzo, fresco nel corpo e nell’animo, che sa prendere, appena terminati gli studi liceali, la decisione giusta, quella del sacrificio personale in vista del bene comune, e sale fiero sui monti; infine Italo, un professore di Italiano in pensione, che, dopo una vita lavorativa trascorsa a Vercelli, decide di tornare a Borgosesia, sua città natale, dove gli è rimasto un fratello, di lui più anziano: qui scopre il rimorso di essere stato lontano per tanto tempo ma ottiene una proba redenzione ponendo a repentaglio la sua mediocre esistenza. Siamo felici per il nostro Remo Agrivoci ma più ancora per la nostra Valsesia, di cui finalmente, in questo romanzo di formazione, son tessute le esatte lodi e sono cantate le virtù, le doti, i meriti di cui mai gli abitanti di questa valle difettarono.
Capirete che molti elementi non quadrano: Vittorini non avrebbe mai avallato un libro come questo. Pensai a una burla, voluta da qualche valsesiano per vellicare la sopitissima ambizione dei convalligiani, ma infine dubitai di poter accordare tanta lepidezza a gente fatta come me. Allora il romanzo doveva pur esserci stato, almeno come manoscritto, e giunsi ad altre congetture: forse Agrivoci s’era risentito per una delle celebri beccate di Vittorini, o temette che la severità dei suoi baffi si sarebbe sgravata su un ‘risvolto’ troppo aspro, come quelli che capitarono a Fenoglio o a Zolla. Forse ci fu un ripensamento di Vittorini. O forse Remo Agrivoci spedì il manoscritto e il siciliano rispose che il romanzo poteva interessare e che avrebbero dovuto vedersi a quattr’occhi. Può darsi che si fossero incontrati e che il progetto fosse naufragato sul nascere. Ma nel frattempo il precipite Agrivoci poteva aver raccontato a qualche amico articolista del contatto con Vittorini e l’articolista poteva aver fatto, avventatamente, il resto.
La realtà si presentava multipla, spinosa, a strati fittamente sovrapposti, come un carciofo, e alla fine deliberai di tener buone tutte le ipotesi, e nessuna. Così decisi di provare a riscrivere il romanzo.
Questo è il primo romanzo che scrivo, o meglio: riscrivo. Come è naturale in questi casi, avrei dovuto trovare un manoscritto, più o meno integro e leggibile, e trascriverlo con innocenza, come hanno fatto tanti altri, e più fortunati, prima di me. Non è stato così, come ho detto.
Presi in considerazione l’anno, il 1958, nel quale avrebbe dovuto uscire il volume: molti iniziavano a dimenticare o avevano dimenticato la guerra di Liberazione, e il romanzo italiano stava entrando a far parte della quantità di beni superflui di cui ognuno poteva fruire. L’universalità del contenuto (valida per l’immediato dopoguerra, secondo l’opinione di Calvino nella Prefazione del 1964 al Sentiero dei nidi di ragno) stava sgretolandosi già negli anni Cinquanta, più ancora nei Sessanta (e Calvino lo conferma): oggi è estinta e restano solo i segni dei testimoni. Gli uomini, nel declinare degli anni 50, avevano altro per la testa: da un canto miravano su, al cielo stellato, non con vagheggiamento lunare ma con curiosità scientifica e il timore che all’improvviso lo Sputnik o qualche altra diavoleria potesse cadere loro sulla testa; dall’altro canto guardavano in basso, tra le gambe, follemente preoccupati per la Legge Merlin. Angelo Roncalli saliva al soglio come 261° Papa e metteva a soqquadro la Chiesa. La pretesa ch’ebbe Agrivoci di scrivere, in quel frangente, un romanzo ‘neorealista’, dopo la decretata fine del ‘neorealismo’ mi sembrava un’assurdità.
Ma a volte le cose stravaganti sono le più attraenti. Ero affascinato all’idea di narrare di un tempo in cui eroi e poeti stringevano sodalizi (nella milanese casa dell’architetto Filippo Maria Beltrami, futuro “Capitano” di una delle prime formazioni partigiane dell’Ossola, Montale andava a bere il caffè, e chiosava di suo pugno le poesie di Giuliana Gadola, moglie del “Capitano”), di un tempo in cui i soldi si vincevano proditoriamente – per chi faceva la spia – con le taglie sulla testa invece che coi quiz. Volevo raccontare queste cose adesso che la memoria resistenziale fatica a resistere, in quest’epoca moralmente imbarazzante nella quale ci si imbarazza di fronte all’impegno.
C’erano due problemi, uno di forma, l’altro di contenuto. Iniziamo dal secondo: scrivere l’ennesimo libro sulla guerra e la Resistenza? con quale coraggio? e perché? Non posso mettere avanti una ragione convincente né per i lettori, né per me: un altro libro sulla Resistenza non serve perché il più bello e quello dopo il quale non si può dire più nulla è già stato scritto: è Il partigiano Johnny. Mi diedi quindi una risposta da fanciullino: ho scritto perché me ne è venuta voglia (cosa che nessuno scrittore direbbe mai); ho scritto perché amo l’inverno e il titolo Partigiano Inverno non poteva che stimolarmi; ho scritto perché da tempo desideravo raccontare una storia dove protagonista fosse la Valsesia.
La cosa più cruda che c’è in questo romanzo è la fucilazione di dieci persone (tra civili e partigiani): cosa piuttosto frequente negli anni della guerra civile, sorprendente oggi, a figurarcela nella piazza del nostro paese. Si dirà che anche adesso gli omicidi di mafia o gli assassinii in serie ci mettono la morte in faccia. È vero, ma è una morte dipinta con altri toni: giunge veloce, anonima, inaspettata, si consuma in privato; la fucilazione di ieri si svolgeva come una sacra rappresentazione, coi gesti lenti delle cose sovrumane poste sotto l’egida d’una presunta amministrazione della giustizia, col flemmatico corteo dei condannati verso la morte, il tempo sospeso di chi ammira il teatrino dell’equità con la messa in scena delle iniquità e delle insensatezze: spettacolo assurdo, surreale e, per noi, inconcepibile.
Ma in che maniera parlarne, oggi che “l’inesperienza è la condizione trascendentale dell’esperienza attuale” (Antonio Scurati, La letteratura dell’inesperienza)? Mi sembrò sensato far affiorare l’idea che l’uomo d’oggi può paragonarsi a quello di ieri solo se posto di fronte alle cose della natura (e non della storia), che sono uguali da migliaia di anni. A fare le azioni importanti non sono i protagonisti del romanzo (Umberto, Jacopo e Italo) ma Cino Moscatelli, Giuseppe Osella e gli altri che ci furono davvero; i miei personaggi per la maggior parte del tempo si limitano a passeggiare, a rievocare proustianamente; attendono qualcosa, o cercano l’Occasione della vita; progrediscono ma non linearmente: muovono disordinati, senza meta, per brevi scarti. Sono soli e perduti, come noi di fronte al passato. Rincorrono qualcosa avanti a loro ma non sanno cosa: la linearità s’inchiocciola e diventa circolare. L’insufficiente diventa evento, o lo diventa ciò che è grottescamente abbondante, ovvero l’eccedenza deforme.
Passiamo al problema della forma. Scartata in partenza l’idea di un narratore interno, mi buttai con entusiasmo sull’eterodiegesi, scoprendomi indeciso se optare per un narratore personale o impersonale. Mi invaghii del primo per ribellarmi all’idea che il romanzo sembrasse essersi fatto da sé, ma scoprii che fare il narratore personale più di tanto non mi veniva. Cercai poi di giocare con la focalizzazione: al principio adottando un punto di vista moderatamente interno, senza malizie, a volte sfocato e scialbo, per passare poi a una focalizzazione più instabile che vuole pigliare tutto tra il grado zero e il punto di vista esterno. Volevo dare al romanzo un ritmo lineare e circolare a un tempo: un ritmo alla ‘bolero’, una struttura ad ‘aria e variazioni’ con ripresa dell’‘aria’ in chiusura.
Ho inteso il linguaggio come un protagonista che subisce un’evoluzione, più grande o evidente rispetto a quella dei personaggi. Esso si carica come una valanga disordinata che rovina giù: diventa bizzarro, insanito, folle, espressionistico a furia di afrodisiaci dialettali e vocabolarieschi. Ho voluto strappare la faccia a certi ceffi col randello della deformazione e, al tempo stesso, col naso del clown, perché m’è parsa l’unica maniera di poter parlare – sempre fallendo – della ferocia e della morte, e di tempi e di uno spirito che non c’è più. Non con la vana speranza di riuscire a muovere qualcuno a pietà ma per dimostrare che oggi, di certe cose, non ci si riesce più a rendere conto.
Devoto alle poche notizie sull’opera, ne ho mantenuto il titolo, Partigiano Inverno, e ho conservato gelosamente, quando non l’ho alimentato, un dubbio: se Inverno fosse il nome di un partigiano, o se Partigiano fosse un attributo o un tributo all’inverno, o entrambe le cose.
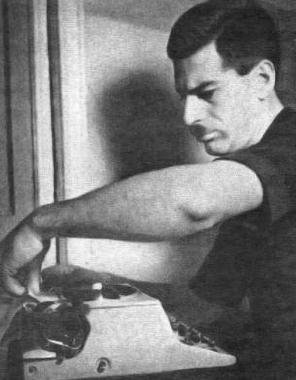
molto bello, complimenti. un tlon, uqbar, valsesia :-)
Grazie Sergio, grazie mille. A ben pensarci, il pezzo potrebbe stare anche da solo, come una ‘finzione’. In realtà è l’Introduzione a un mio romanzo, Partigiano Inverno (ovviamente!), finalista al Premio Calvino 2011.