American dream #4: Paradiso e potere
Tentativo di risposta all’“ayatollah” Tiziano Scarpa
di Helena Janeczek
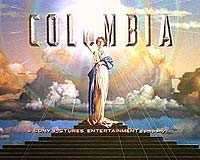 Robert Kagan è quel signore grassoccio che vive a Bruxelles, ma fa parte dei consiglieri di Bush, noto per una vulgata del suo libro Paradiso e Potere che sembra quasi una barzelletta: gli americani vengono da Marte, gli europei da Venere. Noi abitanti delle varie nazioni europee avremmo tratto dalle devastazioni dell’ultima guerra la conclusione che è meglio coltivare il proprio orticello sperando che dia frutti buoni e redittizzi, impegnandoci per renderlo sempre più curato e piacevole sino a farlo sembrare il giardino dell’Eden, mentre loro – Kagan è americano – sono grandi, sono forti, sono una superpotenza che si identifica col proprio potere e quindi, assumendosene tutto l’onere e il rischio, considerano giusto impegnarlo quando e dove gli pare.
Robert Kagan è quel signore grassoccio che vive a Bruxelles, ma fa parte dei consiglieri di Bush, noto per una vulgata del suo libro Paradiso e Potere che sembra quasi una barzelletta: gli americani vengono da Marte, gli europei da Venere. Noi abitanti delle varie nazioni europee avremmo tratto dalle devastazioni dell’ultima guerra la conclusione che è meglio coltivare il proprio orticello sperando che dia frutti buoni e redittizzi, impegnandoci per renderlo sempre più curato e piacevole sino a farlo sembrare il giardino dell’Eden, mentre loro – Kagan è americano – sono grandi, sono forti, sono una superpotenza che si identifica col proprio potere e quindi, assumendosene tutto l’onere e il rischio, considerano giusto impegnarlo quando e dove gli pare.
Volevo leggere questo libro, ma finora non ce l’ho fatta e quindi anche questo mio breve riassunto non è che la ripetizione di cose lette sui giornali. Non importa però, perché basta per il discorso che voglio fare, un discorso che non riguarda la geo-politica dell’Iraq, né i rapporti fra de Villepin e Rumsfeld, ma la letteratura.
Lavoro come consulente per la casa editrice che ha pubblicato sia Paradiso e Potere sia il violentissimo attacco a Bush che è Stupid White Man di Michael Moore e i dati di vendita dicono una cosa sola: che su uno dei non pochissimi lettori di Kagan ce ne sono almeno tre di Moore e questo nonostante la Mondadori sia di Berlusconi, abbia il sostengo di “Panorama” ecc. nonché del fatto che in Italia quelli di destra esistono eccome. Ma le persone che leggono i libri preferiscono di gran lunga un regista ciccione che spara a zero sul suo paese che un politologo (o storico) allineato con i neoconservatives che dica anche nel modo più serio e documentato quelle cose lì. Lo so che lo sapevate anche voi, così come sapete che la stragrande maggioranza degli abitanti delle varie nazioni europee non vede esattamente di buon occhio l’attuale politica imperiale statunitense, ma volevo comunque ricordarvelo.
Perché temo che Robert Kagan abbia ragione. Non perché esprime una verità inappellabile, anzi, ma perché noi – e non soltanto i cittadini U.S.A – ci vediamo e vediamo gli americani proprio come li dipinge lui. Altrimenti non si spiega l’apparente schizofrenia per cui uno va alla manifestazione contro la guerra e poi si compra Palahniuk, Eggers, Roth, McEwan e via dicendo mentre approccia con diffidenza la produzione letteraria nazionale, piglia il libro di un autore straniero in casi rari ed eccezionali e solo ad ogni morte di papa quell’autore non sarà sudamericano, giapponese, israeliano ecc. ma europeo.
Quello che oscilla è soltanto la valutazione data alla stessa immagine preconcetta che poi conferisce una coloritura diversa alle sue varianti opposte. Per cui, se ci guardiamo come soggetti politici e civili, ci rappresentiamo come individui razionali, rispettosi delle leggi universali, capaci di pacate mediazioni e consideriamo quelli d’oltreoceano la barbarica e rozza caricatura del Far West, mentre se mettiamo piede in libreria i romanzi anglo-americani incontreranno il pregiudizio positivo di essere vigorosi e pieni di polpa e quelli nostrani, salvo rare e conclamate eccezioni, il sospetto di essere delle pizze anemiche e noiose. Della letteratura europea neanche a parlarne, perché non basta un occasionale Pennac o Sebald o Javier Marías per elevarla dal suo rango di quantité négligeable.
Alcune precisazioni: non me la sto prendendo con Palahniuk, Eggers, Roth, McEwan o con altri autori anglo-americani il cui richiamo mi sembra perfettamente comprensibile e in certi casi persino doveroso. Ho scelto consapevolmente dei nomi che rappresentassero – magari a livelli e con esisti diversi – la letteratura autentica, non i palloni gonfiati dall’industria culturale di cui se ne vedono sempre parecchi, né tantomento la cosiddetta letteratura di genere o di intrattenimento. E parlo della letteratura-letteratura non solo perché è quella che mi interessa di più, ma perché altrimenti i termini di paragone sarebbero sbagliati in partenza. Si più confrontare una scarpa artigianale “made in Italy” con una scarpa artigianale inglese e americana, ma evidentemente non ha senso paragonarla con la “Nike”. E sia certi casi editoriali internazionali, sia, a maggior ragione i prodotti di gente cone Grisham, Clancy o Stephen King nascono su misura di una gigantesca macchina industriale che non esiste né da noi né negli altri paesi europei.
In più è importante che il pubblico di questi libri sia potenzialmente lo stesso, cioè quello dei cosidetti lettori forti. I grandi bestellers (come dice la parola stessa) li leggono cani e porci, fra cui non necessariamente coloro che rendono visibile l’ambivalenza della “autocoscienza” italiana ed europea.
Di solito le idee e le immagini preconcette conservano – semplificandolo e sclerotizzandolo – un nucleo di verità. Quindi se oggi molti lettori si aspettano di più dai libri tradotti dall’inglese, questo dipende anche dal fatto che spesso questi libri presentano davvero un disegno più ampio, tematiche più avvincenti, strutture narrative più solide e complesse. E allora mi chiedo fino a che punto questo avviene grazie al fatto che anche loro, gli scrittori anglo-americani, si muovano a partire dalle stesse immagini preconcette.
Perché soprattutto gli autori statunitensi così spesso – già da giovani, veramente giovani – scrivono di più, scrivono libri più grossi e ci mettono dentro una tale quantità di piani, motivi, trovate, storie e personaggi da fornire il materiale per un numero imprecisato di romanzi medi europei? Direi proprio perché, anche se sono i più accerrimi critici della loro società – in questo non c’è nessuna contradizione – si sentono americani. Vale a dire che, sapendosi al centro del mondo, danno più importanza al loro lavoro e lo investono di mire più ambiziose. Il che, nel vincolarli a un’idea di grandezza e di potenza, può alla fine segnare il limite preciso dei loro sforzi, vuoi perché non tutte le opere possono essere all’altezza delle aspirazioni, vuoi perché, se queste diventano normative, precludono la libertà di approcci differenti.
Ma un caso come quello di Dave Eggers, il quale, diventato ricco e famoso con il suo primo libro a venticinque anni, si mette a creare una rivista supersofisticata come McSweeney’s, poi si autopubblica il secondo romanzo, poi crea una scuola di scrittura gratuita per i ragazzini disagiati di San Francisco, è comunque una variante impressionante ed esemplare dell’American Dream. E se è chiaro che Eggers abbia potuto fare tutti quei soldi perché aveva dietro l’incomparabile macchina editoriale americana, la sua fama è anche sufficientemente fresca per permetterci di ricordare che quando stava scrivendo L’opera struggente di un’incomparabile genio, per quanto potesse mirare in alto, era comunque ancora un ragazzotto qualsiasi come me o te.
Tutto quanto ho sostenuto finora, l’ho detto, se permettete, con uno spirito da “dialettica dell’illuminismo”. Perché riconoscere degli schemi mentali e il loro effettivo potere d’azione non è solo la premessa per smontarli, ma anche per vedere con più chiarezza dove la realtà non coincide con loro.
Penso che gli scrittori italiani ed europei si siano certo sentiti più marginali in tutti i sensi, meno chiamati a puntare al centro delle questioni che muovono gli uomini e il mondo, diligenti coltivatori del giardino edenico delle patrie lettere e della bella scrittura nelle sue varianti fra il neoclassico al neoavanguardista. Ci sono grandi scrittori che corrispondono perfettamente a questo stereotipo – l’esempio migliore mi sembra Peter Handke – ma ce ne sono molti altri, soprattutto fra gli autori più giovani che sembrano mostrare come le cose stiano cambiando.
Se penso soltanto ai titoli italiani pubblicati nell’ultima stagione letteraria mi vengono in mente Mari, Mazzucco, Covacich, Trevi, Montesano, Franchini, Pariani, Genna, libri diversissimi, ma il cui minimo denominatore comune mi pare rintracciabile in un progetto aperto, non autoreferenziale di letteratura. Scusate se la lista è incompleta per ragioni di gusto o di ignoranza, ma pur ammettendo la sua assoluta soggettività, mi viene da dire che otto libri in sei mesi per un paese piccolo come il nostro non appaiono affatto pochi (specie se consideriamo che me ne sarò dimenticato qualcuno).
E anche in generale la realtà non coincide con le immagini preconcette.
Avete idea di quanti titoli pubblicati e talvolta ben accolti in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e di ogni altro territorio o semplicemente autore anglofono vengono ogni anno scartati dalle nostre case editrici, nonostante il sostegno del meccanismo internazionale che li promuove? Io ne vedo solo una piccola parte perché aiuto un po’ a smaltire l’immensa mole di lavoro che la produzione di lingua inglese rappresenta per gli editori, ma vi assicuro che sono tanti, tantissimi.
Dunque anche in quei paesi la maggior parte dei libri che escono sono mediocri, piatti e noiosi (magari in maniera diversa, ma lo sono). E allora come mai esistono ancora dei capolavori della letteratura anglofona che non sono mai stati tradotti in italiano o che non sono più accessibili da anni? Penso, in primo luogo, a gran parte dell’opera di William Gaddis, indiscusso padre del postmodernismo americano, però di esempi ce ne sarebbero molti altri. E poi mi sembra doveroso riconoscere in primo luogo a minimum fax e Fanucci (ma anche a vari altri piccoli editori) il merito di averci proposto alcuni scrittori americani di indiscutibile statura che le grandi case editrici, incluse quelle di qualità, avevono scartato. Richard Powers, di cui è uscito recentemente Galatea 2.0 presso Fanucci, era da anni libero sul mercato.
Come anche in politica il nemico non è l’America, ma è l’ideologia dominante che sembra coincidere con essa, ma che c’è anche da noi, anzi in noi. Nel caso della letteratura non si rispecchia solo nelle immagini di forza, ma anche di semplicità: ovvero facilità della fruizione del prodotto. Per riprendere gli esempi di prima né Gaddis, né Powers, entrambi scrittori “intelltualistici” e complessi, corrispondono minimamente a simili presupposti. Dunque cedono il passo a un numero imprecisato di casi gonfiati che spesso non fecero altrettanto rumore in patria. Il lettore italiano vuole il suo scrittore americano che ricalchi le sue idee sugli scrittori americani e voilà, il lettore italiano viene soddisfatto.
È ora che questo cambi. È ora che anche quando ci occupiamo di libri opponiamo alla globalizzazione del mercato che con tutta l’ambivalenza illustrata sopra tendiamo ad identificare con gli Stati Uniti e i loro satelliti (nel caso di una koinè linguistica l’idea di coesione è più legittima che altrove) una visione globale libera da cliché in cui conta solo il valore e la coerenza interna di un’opera letteraria. Perché ci si possa finalmente sottrarre dal gioco proiettivo e binario del “noi” e “loro” che forse stronca sul nascere ogni interesse per i libri stranieri in generale ed europei in particolare, in modo da rendere più facile la loro pubblicazione. E soprattutto in modo da avere sempre più conferme che esiste sì un epicentro del potere, ma che le periferie nell’ambito della cultura sono tali solo se accettano di esserlo, indifferentemente se si tratta di favelas o di sobborghi con giardini pieni di rose. Quella che come tale è in pericolo di essere ridotta a uno spazio sempre minore come la foresta pluviale, è tutta la letteratura. Per capovolgere un celebre slogan: “Goodbye, paradise”.
_______________________________________________________
Per inserire commenti vai a “Archivi per mese – Luglio 2003”
Ho letto con particolare attenzione l’intervento della J. E, pur essendo così tardi non riesco a lasciar perdere e andare a nanna.
Dice Lei : Perché soprattutto gli autori statunitensi così spesso – già da giovani, veramente giovani – scrivono di più, scrivono libri più grossi e ci mettono dentro una tale quantità di piani, motivi, trovate, storie e personaggi da fornire il materiale per un numero imprecisato di romanzi medi europei?…
e poi da le sue, solo sue motivazioni che puntano sul senso di appartenenza alla terra, agli Stati Uniti.
Dico io Non credo che questo sia uno dei motivi principali. Credo invece che il punto di vista di un americano, le storie che succedono ad un americano, succedono con modalità diverse da quelle che quotidianamente succedono a noi europei. La fantasia, la rottura degli schemi, l’andare al fondo delle cose appartiene agli americani quanto appartiene agli europei ma qui tutto questo è vissuto in maniera “sentimentale” e il risultato è un lavoro ricco di linguaggio e di autoriflessione.
Molto spesso, e di narrativa italiana ed europea ne leggo tanta, al centro del libro compare l’autore con tutte le sfaccettature umane dell’uomo/donna che vive quella storia sulla sua pelle. Come se il libro assumesse le caratteristiche di un diario di una esperienza vissuta in prima persona durante un viaggio, un incontro, un attraversamento di storie, di persone: un attento collage di esperienze vissute direttamente e indirettamente. Il termine finzione per uno scrittore europeo – non è alla base del processo di scrittura – e naturalmente questo lo dico da lettrice – bensì un artificio di cui l’autore si serve per rimescolare le carte. Carte che sono rubate o prese a prestito da una propria esperienza o pensiero o da un fatto di cronaca che prima di essere pronto alla riscrittura viene metabolizzato, digerito e rielaborato sotto forma di romanzo. Inoltre, in alcuni casi ho sentito potente la sensazione che l’autore vivesse il suo libro, forse durante il flusso conclusivo della scrittura.
Parto, per spiegarmi meglio, proprio dagli esempi di J. evidenziando gli scrittori che conosco meglio:
Mari – Quale Mari? Quello di Tu sanguinosa infanzia? E come non pensare a una finzione nata da una devastante esperienza personale? Una raccolta di lavori che hanno il sapore dell’autobiografia, o almeno in parte, o raccogliticci “sentito dire” che hanno subito il filtro del proprio io d’autore?
Mazzucco – Una storia di famiglia frutto di lunghe e faticose ricerche che hanno portato l’autrice a scoprire le sue origini meridionali e non certo piemontesi come la sua famiglia raccontava
Montesano – Autore dotato di una buona vena narrativo e di arguto spirito critico che racconta, al limite del ridicolo, la sua città. La storia della sua città, della sua terra devastata da quelle stesse persone che lui cita. Il ceto medio borghese, i ricchi che speculano sul popolo…mettendo in mostra una Napoli felliniana e mostruosamente ridicola legata allo streotipo di De Filippo
E per debole conoscenza mi astengo dagli altri!!
Ma posso riportare le stesse sensazioni negli autori inglesi: in Coe, dove le storie scorrono sempre su un filo su cui le eroine si tengono in disperato equilibrio e sembrano anime che vivono attraverso leggere gonfiature di umori da parte dell’autore; Kureishi – dove le storie compaiono sempre marginali ai personaggi densi e sfuggenti a un tempo; in McEwan, Marias… Ma vado anche al nord con Larsson la cui fortuna lo ha portato in Italia veleggiando sul suo Rustica accanto a Long John Silver…
Le storie americane, secondo me sono altro. Soprattutto quelle dei Best sellers… ci sono gli autori che lavorano in uffici con quattro segretarie, un avvocato, un galoppino che fa ricerche… e’ un mondo assolutamente imparagonabile alla nostra letteratura e non solo perché i giovani ce la mettono tutta e si sentono americani, e quindi nel diritto di difendere la propria terra. E’ un modo diverso di porsi, un modo di scrivere che prende a prestito le forme più consuete dei nuovi media, è una letteratura che nasce come immagine e questa immagine poi si trasferisce in parola, in segno, in fantasia: è il processo opposto, o soltanto diverso da quello che caratterizza la letteratura europea. E neanche tanto poi. Andando a fondo scopriamo strane coincidenze, strani rapporti che ci portano sul piano del linguaggio espressivo della facilità o difficoltà dell’espressione verbale, della stessa lingua che in qualche caso vuole qualcosa di diverso, quella musica, quel ritmo, quell’armonia complessa e completa che non c’è nei libri americani citati quali best o long.
Non intendevo tracciare una linea di confine fra autobiografico e “pura fiction”, che non ha senso. Dipende da cosa se ne fa, dal progetto di scrittura che ci sta dietro, per cui anche il libro più privato può essere specchio di molte cose che riguardano tutti. In più, non me la sogno di definire una sostanza diversa della lettertura italiana (ed europea) ed anglo-americana, perché mi sembra una costruzione pericolosamente astrattizzante e perché, per affrontare almeno qualche nodo problematico, ci vorrebbe molto, ma molto più spazio.
Io ho cercato solo di tracciare delle ipotesi su delle autorappresentazioni e sulla loro azione nel lavoro dello scrittore che, come cerco di sottolineare, non coincidono per niente con la realtà: né dei libri, né delle persone.
Fra i commenti che ho letto qui sotto, segnatamente all’articolo della Benedetti, ho letto una sorta di insofferenza a proposito del tema sollevato da Tiziano Scarpa e qui affrontato in maniera ammirevole da H.J. Un’insofferenza comprensibile e a cui cercano in qualche modo di ovviare le risposte sia di Voltolini sia di Genna ma che, mi pare, testimonia della profonda resistenza emotiva che si ha ad affrontare il problema dell’identità, in particolare di quella nazionale. Solo la J. qui, ha esplicitato direttamente quale contraddizione vi sia fra i comportamenti di carattere politico e le letture che fanno preferibilmente le stesse masse che in piazza denunciano la gestione U.S.A. Non importa che ad essere letta sia l'”altra” America, che è una proiezione nostra, un fraintendimento del “loro” sentirsi americani. Condoleeza Rice e Michael Moore si sentono americani in un modo che noi non comprendiamo e che solo noi dividiamo in due parti schizofreniche che loro non capirebbero.
A giudicare dagli interventi nel forum della casa editrice, i lettori della minimumfax sono di sinistra, sono assai giovani, molto colti e anglo-preparati e non possono Non dirsi americani. In definitiva, in un cerchio più ampio della spirale del tempo, mi sembrano ancora i giovani cantati da Guccini in “Fra la via Emilia e il West”. E’ il mito americano, bellezza, e non puoi farci niente. Ed è qui che prende valore la risposta illuminata e illuminante di H.J. a proposito della forza della scrittura statunitense, soprattutto di quella giovanile:
Direi proprio perché, anche se sono i più accerrimi critici della loro società – in questo non c’è nessuna contradizione – si sentono americani. Vale a dire che, sapendosi al centro del mondo, danno più importanza al loro lavoro e lo investono di mire più ambiziose.
Un orgoglio sostenuto dall’economia più forte del mondo, d’accordo, ma, soprattutto e comunque,una consapevolezza di sè. Un senso, in molti casi ci sembrerebbe di poter dire paradossale, di appartenenza. Ma tale da garantire alla letteratura U.S.A., presa nel suo insieme e a prescindere dalle etichette di “bruciati”, spellati”, “afasici”, una sorta di terreno narrativo “epico”, riconoscibile, ad esempio, nello scavo magistrale che molti fanno delle loro lingue popolari. Niente del genere, direi, nella narrativa italiana (purtroppo non conosco affatto altre narrative europee) dove il problema della lingua, ad esempio, trovo che sia centrale. In che lingua scrivono i nostri autori? Come parliamo noi italiani? Che lingua è la nostra oltre a quella televisivamente americanizzata? Come è noto, problema secolare questo; finora, le soluzioni migliori sono sempre arrivate dalla poesia, non dalla narrativa. Eppure, è la lingua che fonda una storia, non viceversa. E la lingua è l’espressione di un’identità. Composita, complessa, multipla e molteplice finchè si vuole ma non scissa, sminuita, evitata, commiserata. Che almeno sia ricostruita umoristicamente. (E’ anche in questo il segreto del successo, tanto criticato, dei comici? Giustamente Genna ricorda Flaiano. Perchè, dopo, in letteratura, anche l’umorismo sulla lingua colonizzata lo lasciamo fare agli americani. Si ha presente Alexander Perchov, una delle voci narranti di “Ogni cosa è illuminata”? Che non mi è piaciuto per niente, fra l’altro.
Sono un forumista del sito minimumfax e siccome spesso vengo a dare un’occhiata a nazione indiana mi sono appassionato a questo scambio di opinioni (Scarpa, Cassini, Genna, Voltolini, Janeczek). Vorrei solo fare una precisazione prima di esporre i miei piccoli pensieri. Se potessi fare una stima, direi che circa il 60% delle mie letture è americano. Dalla Lost generation alla Beat generation, dai vari Roth*DeLillo*Shelby_jr*Pynchon*Bellow*Brodkey, passando per Breat Eaton Ellis e McInerney, fino a Eggers*Foster Wallace*Means*Palahniuk*Lethem.
Sono giovane, ma non sono comunista. Non penso di essere poi così colto e non mi sento per niente “americano”. Insomma non ho il mito del west, quello che ormai credo proprio non esista più oggi.
Mi rifaccio particolarmente al pezzo di Helena Janeczek per due motivi:
mi è piaciuta la partenza politico-sociale del pezzo, con la citazione della parole di Kagan (l’orticello in santa pace)
è quello che più mi ha fatto pensare, quello nel quale ho trovato dei punti che a pensarci un po’ si sono trasformati in spunti.
“Quindi se oggi molti lettori si aspettano di più dai libri tradotti dall’inglese, questo dipende anche dal fatto che spesso questi libri presentano davvero un disegno più ampio, tematiche più avvincenti, strutture narrative più solide e complesse.”
A livello pratico chi lo può negare, anche per la fortuna di vantare un’innegabile e maggiore “potenza di fuoco”. Io sono d’accordo, ma non credo sia il punto di partenza. Come non credo che la lingua, quella italiana, sia questo grande ostacolo. La barriera più grossa mi sembra sia sintetizzata alla perfezione qualche riga più avanti.
“Direi proprio perché, anche se sono i più acerrimi critici della loro società, si sentono americani. Vale a dire che, sapendosi al centro del mondo, danno più importanza al loro lavoro e lo investono di mire più ambiziose.”
Sono ancora una volta d’accordo con quanto riportato sopra. Hanno il potere, sono al centro del mondo e, aggiungo io, hanno anche una grande esposizione e un esporsi da non sottovalutare. Questa è la motivazione principale, quella che in partenza li mette un gradino avanti, ma non è detto che quel gradino sia difficilmente recuperabile o sinonimo di qualità. Ogni lettore è il suo più fedele scrittore, così la vedo io.
E allora torno a minimumfax (ma potrebbero essere altri, tanti dei quali già citati come Fannucci, Sironi, Pequod, ecc ecc) perché credo sia l’esempio positivo dal quale partire. Posso prendere in mano un libro americano o uno italiano (della collana nichel) e trovarci una specie di filo conduttore. Un “mood” comune (anglofilo !! la parola mi è sembrata rendere meglio così le mie intenzioni e poi una sottile provocazione mi scappa anche). Sono sicuro di poter trovare qualcosa per soddisfare il mio piacere. Perché non dimentichiamocelo, leggere come prima cosa, è un piacere. Leggere e la letteratura devono prescindere dal “gioco proiettivo e binario del noi e loro”.
CK