Defecatio Post Mortem (problemi di narrazione viscerale)
di Giorgio Vasta
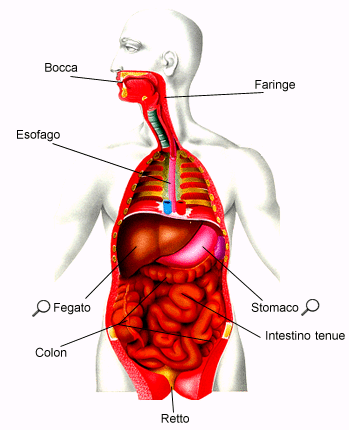 Il nostro sistema digerente è una trama. Una vera e propria trama narrativa. Un cosiddetto plot, organizzato classicamente in una struttura in tre atti. Primo-secondo-terzo atto, esposizione-conflitto-scioglimento. O, secondo altre formalizzazioni, nel caso specifico quella di Joseph Campbell e del suo monomito, separazione-iniziazione-ritorno (ma la sostanza è la stessa).
Il nostro sistema digerente è una trama. Una vera e propria trama narrativa. Un cosiddetto plot, organizzato classicamente in una struttura in tre atti. Primo-secondo-terzo atto, esposizione-conflitto-scioglimento. O, secondo altre formalizzazioni, nel caso specifico quella di Joseph Campbell e del suo monomito, separazione-iniziazione-ritorno (ma la sostanza è la stessa).
Un plot con la sua normale evoluzione: il primo turning point, poco prima della fine del primo atto (primo turning point utile a innescare il passaggio al secondo atto, il passaggio cioè dalla vita domestica all’avventura, dalla fisiologia alla patologia, Cappuccetto Rosso che decidendo di lasciare la via maestra incontra il lupo, con quel che ne consegue), e il secondo turning point, poco prima della fine del secondo atto (l’accadimento che prelude all’individuazione del sistema per venire a capo del mistero, la formula magica, la pozione, il quinto elemento, conquistato il quale si può evolvere fiduciosi verso il finale, passare dall’avventura alla sua ricomposizione, dalla patologia alla nuova fisiologia, il cacciatore che passa vicino la casa della nonna, sente russare e si avvicina, cosa che lo porterà all’uccisione bianca, esangue, del lupo, e alla liberazione del micronucleo familiare incomprensibilmente non masticato).
Per rendersi conto di questo, di come cioè il nostro sistema digerente sia legittimamente paragonabile a una narrazione, è sufficiente visualizzare la forma dell’intestino, il nostro canale alimentare, con le sue anse, i gomiti, le piegature, le curvature, metri e metri di tubo digerente aggrovigliato dentro di noi (il cardias sarebbe quindi una sorta di primo turning point, il piloro il secondo; mi domando a che cosa possa corrispondere il mesenterio). Un plot biologico, un groviglio viscerale concentrato al centro del nostro corpo. Una narrazione ininterrottamente narrata, ininterrottamente cominciata e terminata, ma terminata per essere ricominciata, e terminata e ricominciata ancora, e terminata, e ricominciata, senza soluzione di continuità e quindi sempre in corso, in circolo (perché anche quando il nostro apparato gastrico appare silente è invece comunque vivo, concentrato, a basso regime ma sempre sveglio, laborioso). Una narrazione dotata di attività motoria, propulsiva, che spinge la storia attraverso colpi di scena e di ritmo, tra squilibri e slittamenti di tensione. Una narrazione del tutto autonoma, nel senso di regolata senza che intervenga la nostra volontà, quindi una narrazione che è al contempo nostra e libera da noi, posseduta e arbitraria, quasi in grado di trascenderci.
Ed è una narrazione seriale, la sua struttura si ripete nel tempo, tanto quanto il suo esito. Perché questa nostra fondamentale narrazione corporea è una narrazione dal finale scontato, prevedibile, vincolata a un solo, unico scioglimento. Al limite la stipsi può essere considerata una forma di suspense, la colite un’accelerazione crampiforme della vicenda, ma inevitabilmente, anche dopo un differimento o uno scatto veloce in avanti, il finale sarà quello, questo, la materia fecale conclusiva – l’assassino, il colpevole, l’eroe, il sopravvissuto, l’happy end, il sorriso, il bacio, il tramonto, l’alba, la morte, l’ultima parola pronunciata o scritta, l’ultimo fotogramma percepibile. Un finale che è fuori di noi, mentre la storia della nostra orribile miserrima biologia continua a essere narrata. Un finale che si separa da noi, che va via dalla vita, dalla nostra vita, la nostra merda-finale adagiata in un buco d’acqua e ceramica o su uno strato di foglie, su una radice, sulla sabbia, sul parquet di una camera da letto, sopra un tappeto, sotto un tappeto, dentro un posacenere (cosparsa di cenere, la cenere intrisa), nel taglio aperto di un libro di storia, sopra un fornello acceso (un finale crepitante), dentro una bacinella metallica smaltata bianca (il tac-toff della merda che cade), tra le maglie di una vecchia rete di letto (un finale poroso, a nido d’ape, postmoderno), sopra un faretto al neon puntato verso l’alto (uno di quelli nascosti sotto la pavimentazione di una piazza, il solo raggio che emerge, la merda piena di luce, la merda radiosa), sopra i fili della biancheria (il finale sospeso), tra le buganvillee in estate, nell’armadietto dello spogliatoio in piscina, in fondo alla piscina (intravedere sott’acqua il finale che si immerge piano piano, sbilanciandosi e planando fino al fondo delle piastrelle celesti), sulle gradinate allo stadio, in un turibolo, nel barattolo-portapenne sopra la scrivania, nella carcassa di una capra aperta (il finale che si installa tra le vertebre di calce dolce della capra, nel magma spento degli organi), sul proprio cellulare (sommergendolo), sul cellulare di qualcun altro (sommergendolo), nel banco surgelati di un supermercato (un finale algido), sulla tastiera di un computer (deposta un po’ a nastrino), sul sellino di una bicicletta, sopra una formica di passaggio, sul pianerottolo del piano più su, in un punto della spianata di Waterloo (il finale Cambronne), in una buca del Carso, al centro esatto di piazza Correr a Venezia, in un angolino di Ground Zero, sul soffitto dello scompartimento del treno (come nella vecchia barzelletta di Pierino, e nel film con Alvaro Vitali: un finale antigravitazionale), sui capelli di qualcuno che dorme, in una bocca (il finale parlato, la merda delle parole), in un nuovo ano (attraverso un equilibrismo anatomofisiopatologico, di ano in ano, la nostra merda che si inoltra lungo un colon estraneo, che risale lenta e densa verso la foce, ripercorrendo à rebours un nuovo apparato digerente, la merda esploratrice, il finale che avanza, che sorge…).

In ogni caso sempre congedata, la nostra merda, espulsa, deposta, allontanata. La nostra merda come conclusione sempre e dovunque drammatica di una narrazione che ruota come il criceto nella ruota, eternamente, stolidamente, immaginando forse una via d’uscita, insistendo a correre, a girare, a cercare.
Penso a tutte quelle volte in cui ho letto camminando, ho camminato leggendo, per strada. A tutte quelle volte in cui leggendo camminando, camminando leggendo, ho messo il piede su una cacca, ho pestato una merda, un finale altrui, il finale di un’altra narrazione-digestione, in cui ho schiacciato sotto la mia scarpa un bacio, un morto, l’eroe, una parola d’amore, creando una connessione concreta tra la pagina di scrittura sotto i miei occhi e la merda di cane sotto il mio piede, sprofondando così dentro un finale, percependone l’insidiosa mollezza. Penso al tempo trascorso nella rimozione faticosa delle feci annidate nelle circonvoluzioni geometriche della suola carrarmato della scarpa da tennis, aiutandomi con un rametto di legno appuntito, il petto compresso e il fiato schiacciato, fissando il verde e il rubino inspiegabili immersi luminosi nella deiezione canina. Frugare così dentro a una trama, rimuovendone il finale, eliminando l’atto conclusivo, lo scioglimento, proponendo a me stesso una strutturazione alternativa, la sospensione del senso alla fine del secondo atto, il piede che rimane a mezz’aria, in equilibrio, a pochi centimetri dal tortino sul marciapiede, magari continuando ad avvicinarlo all’infinito, un millesimo di millimetro per volta, progressivamente, asintoticamente, senza mai toccarlo.
I morti
Ai morti, di solito, penso la notte. Quando vado a dormire. Durante il giorno le azioni mi permettono di tenere il pensiero alla larga. Il “fare”, come è noto, è un antidoto. La notte, invece, quando mi distendo supino e appoggio una mano sull’altra all’altezza dello sterno – la mia sola posizione per il sonno – le azioni si riducono a zero e il pensiero dei morti arriva. Posso ancora muovere un poco le dita, piano piano, grattare con il polpastrello del medio di una mano la falange dell’indice dell’altra, ma queste non le posso più considerare azioni, al limite sono un brusio di azioni, pochissimo più di un assoluto silenzio fisico. Quindi, se il sonno non c’è – e non c’è quasi mai – per tenere a bada il pensiero dei morti devo cominciare a mettere in scena la mia insonnia. Prendere e disperdere fiato, girarmi su un fianco, allungare le braccia sotto il cuscino, con gli occhi aperti guardare le lucine della tv e del videoregistratore che lampeggiano, sollevarmi a sedere e aspettare un minuto così, cercare il display della radiosveglia per vedere quanto è andato via e quanto ancora rimane. Poi, alcune volte, quando non c’è proprio nulla da fare, riaccendo la luce e ricomincio a leggere. Devo recuperare le azioni, per tenere a bada il pensiero dei morti. Leggere è, tra le azioni che mi sono possibili, quella che conosco meglio, la più organizzata, strutturata. Una fortezza.
A volte però non vado verso le azioni e resto fermo a letto. Mi dico che forse questa volta ce la faccio. Basta aspettare, e dimenticarsi che si sta aspettando, perché, si sa, se il sonno si accorge che lo aspetti allora non arriva.
Passa qualche minuto. Io sto fermo. Sono teso ma cerco di non pensarci, di non saperlo. Passa ancora qualche minuto. E mi accorgo di che cosa sta succedendo al mio respiro. Nel senso che mi accorgo di avere un respiro, una cosa sempre sveglia, che mi si muove invisibile dentro e viene fuori dalla bocca e nella bocca rientra. Improvvisamente il respiro lo sento, addirittura mi sembra di vederlo. Il fatto è che il respiro ha un senso soltanto nella involontarietà, quando scorre dentro il corpo senza che il corpo sappia che c’è. Quando le cose stanno così allora tutto o quasi tutto può accadere. E di sicuro può accadere il sonno. Il respiro che diventa consapevole, controllato, che con la testa cerchiamo di rendere piatto o sottile, o morbido morbido, un fiocco di cotone, è una condizione impossibile. Lì il sonno è impossibile. Proprio perché è un cercare, un tentativo, perché la nostra volontà di costringerlo a una forma fa attrito e sveglia tutto il corpo, lo fa disperare. Io questo lo so, ma non riesco a farci niente. A un certo punto sento un piccolo rumore nella stanza, ed è come se mi rimbombasse dentro le vene e nello stomaco. Allora non faccio più nessun tentativo. Resto fermo nel pensiero dei morti.
Quando penso ai morti, da sotto le mie mani conserte sullo sterno sento le ossa del petto allungarsi e allargarsi per tutto il corpo – una ramificazione lenta e violenta – trasformandolo in un crampo osseo. Il mio petto è ossa, i morti sono ossa (secondo una rappresentazione grafica infantile e secondo un dato biologico incontrovertibile), il mio corpo è una ramificazione di morti (nel senso che la notte, disteso a letto, il mio corpo diventa tutto intero l’albero dei morti, dei miei morti ma non solo; ogni ramo osseo è un pezzetto di morto, un pezzetto di morte; io resto fermo, guardo in fondo le lucine rosse della tv e del videoregistratore, calcolo il respiro: intanto questo pensiero dei morti, che è un pensiero non creato, accade).
Io, quando penso ai miei morti, non ho nulla che mi sia di conforto. I miei morti non mi compaiono in un angolo in alto a sinistra del pensiero, in uno squarcio di cielo, circonfusi di luce, limpidi, fosforescenti, intorno a loro un cielo azzurrissimo e le rondini nere e bianche, e ancora più sotto le case bianche con i tetti rossi e il comignolo e i fiori colorati, il prato verde chiaro, gli alberi verde scuro, lo steccato arancione, il ruscello celeste e un sentiero che si perde dolcemente in basso a destra, nel grigio quieto.
I miei morti non mi compaiono all’interno del disegno di un bambino. Non stanno in una immaginetta. Non mi sorridono. Non mi indicano una via. Non mi danno i numeri da giocare al lotto. Non mi dicono parole necessarie. Non mi proteggono. I miei morti non mi proteggono e a me non viene in mente di chiedere loro protezione. Non penso sia un mio diritto, chiedere loro protezione. E non penso che sia possibile. Al contrario, sono io a volerli proteggere, i miei morti. Addirittura penso che proteggere i propri morti sia un dovere.
Vedo le immagini. Mi concentro su alcune immagini, la sera del 21 novembre 2002. Fotogrammi. Delle cose secche, come se le immagini fossero impresse su delle lastre piatte di carbone, o su dei cartoncini di pietra. Come se ognuna di quelle immagini fosse possibile tenerla in mano, sentirne il peso fisico – nei polsi, nelle vene – passare la punta delle dita lungo il perimetro ruvido – e magari sentire alcune microscopiche schegge conficcarsi nei polpastrelli – e sulla superficie polverosa. Come se fosse possibile fare pressione su di loro, forzarne la resistenza, provare a piegarle. Come se fosse possibile scagliarle per terra a frantumarsi.
Ma non è possibile.
Le immagini che vedo sono le più terribili (le più terribili che io sono in grado di recuperare, evocare e sostenere: ci sono sicuramente immagini ancora più terribili, ma vanno oltre la mia capacità di visualizzazione).
Il momento esatto della morte biologica. Il cosiddetto ultimo respiro – che in realtà non è l’ultimo respiro, essendo di fatto seguito da almeno uno o due ulteriori pseudorespiri, due masserelle di fiato sgonfie che completano l’esaurirsi della respirazione vera e propria. Due riflessi involontari che servono a chiarire che il corpo adesso è cadavere ed è completamente preda della involontarietà.
Il busto sollevato. Contemporaneamente tirato su dalle spalle e spinto in alto facendo forza sulla schiena, la camicia da notte stropicciata, la testa che ciondola, gli occhi socchiusi, i capelli spettinati, tutti appiattiti da una parte e avvolti su se stessi dall’altra.
Tra le mani degli altri che si muovono, l’immagine della vagina bianca, del tutto priva di peli, porosa, gommosa, e, subito sotto, un uovo di feci molli, marrone, che sbocca dall’ano.
(questa immagine è secondo me emblematica; più esattamente, a essere emblematico è il ricordo che ho di quello specifico momento. Intanto, come detto, è un fotogramma isolato, nel senso di separato, sconnesso, “escluso” dal flusso – come tutta la morte e la memoria della morte è una cosa che sta a parte, separata e sconnessa e isolata ed esclusa; il movimento delle braccia e delle mani intorno e sopra il corpo serve a recuperare connessione, a reincludere, a ricucire quel pezzo di tempo isolato, ma quell’agitarsi di braccia e mani è così disgregato, così sbriciolato nel suo farsi – è un movimento che mi sembra esistere in una continua protratta dissolvenza che però non si completa, non si dissolve mai del tutto – da esaltare quanto sta sotto e dietro, il corpo appunto, il cadavere, la carne dura che si trasforma in buchi, in cavità rigide, tutto il corpo come una pietra traforata, e da dentro i buchi viene fuori e va via ogni residuo molle, nella sua oscenità, la merda a batuffoli, il respiro, l’ultima cosa viva, persino tenera, nel corpo.
Al posto della merda, al posto del respiro, la garza arrotolata).
E se tutto questo – giorgiaccio – fosse solo una regressio alla fase anale? Che Artaud ti benedica e ti conservi nell’anus solaire di Bataille.
Di commenti, osservazioni e meditazioni sulla merda ne ho letti parecchi, da Sade a Joyce a Kundera. Non sono mai riuscito a spiegarmi (salvo, forse in Sade) la motivazione artistica, la necessità di cercare nella merda. Ma, anche quando una motivazione ci può essere, la ricerca dà dei risultati desolanti: alla fine di tutti i ragionamenti, le intuizioni, le associazioni, le metafore, nella merda non c’è altro che merda. Sarò anche ottuso, ma non ci vedo altro che il tentativo di stupire attraverso il disgusto.
Caro Riccardo, è capitato anche a me di leggere pagine sulla merda, dalla fase delle deiezioni della mistica Louise De Neant fino al Sade che tu stesso citi. Penso anche io che il rischio sia quello che individui nell’ultima frase del tuo intervento: stupire attraverso il disgusto. E’ vero, è un rischio probabilissimo, quasi sempre inevitabile e non necessariamente eluso. Lo stesso, penso che se a volte la focalizzazione si sposta su una materia discutibile come quella fecale, ciò non avvenga sempre e necessariamente per morbosità o per la ricerca di un facile effetto. Il mio pezzo, nel caso specifico, nasceva da uno stupore. Uno stupore opinabile, se vuoi, magari inverosimile perché quel che lo ha suscitato può apparire a molti del tutto ovvio: la materia fecale è diverse volte una delle ultime se non l’ultima manifestazione del corpo che muore. La mia intenzione era quella di restare il più possibile distante sia dalla contemplazione compiaciutamente morbosa sia dalla suscitazione di disgusto. Le feci, nel mio pezzo, sono assimilate (nessun doppio senso), nella prima parte all’esito di una narrazione, in una maniera che ho cercato fosse giocosa (attraverso le delocalizzazioni), leggera, fintamente dottorale (nei primi paragrafi da trattatello sulla strutturazione in tre atti dell’apparato digerente); nella seconda parte, invece, quella che si intitola I morti, la materia fecale si configura come residuo del corpo quando muore, il risultato di un meccanismo inerziale fisiologico. Non credo ci sia in questo né morbosità né suscitazione di disgusto, essendo questi solitamente connessi all’estetica della coprofilia, e quindi al legame che si instaura tra la pelle e le feci, legame che mi è del tutto indifferente. A me interessava ragionare sulla separazione, non sulla connessione.
Grazie in ogni caso del tuo ragionamento, davvero.
Un saluto,
giorgio vasta
A me più che una cagata (battuta troppo facile) questo pezzo sembra una gran sega, se devo dirlo. Uno sproloquio piuttosto presuntuoso sul nulla, dopodiché il mondo è tale e quale a prima e uno può andare a vedersi Valentino Rossi in tv o leggere qualcosa.
Mi sono piaciuti i “primi paragrafi da trattatello sulla strutturazione in tre atti dell’apparato digerente”.