dei baroni non si sa niente

di Gilda Policastro
Se il valore del libro di Nicola Gardini si dovesse misurare soltanto in relazione al tema annunciato dal titolo, I Baroni (Feltrinelli, 2009) e dallo strillo di copertina (“come e perché sono fuggito dall’università italiana”), il j’accuse lanciato dalla prospettiva dell’exul immeritus (Gardini è ora docente di Letteratura italiana e comparata a Oxford) e la comedía ivi inscenata, con i nomi tutti falsi di persone tutte vere, sentirebbero più del livore personale, e di una vendetta servita a freddo e senza pericolo, che della lucida analisi di un problema scottante. Del resto, il male dell’università è forse da individuarsi meglio in un cursus intollerabilmente lungo e privo di un approdo sicuro che nella corruzione dei singoli protagonisti.
Da questo punto di vista, concentrando invece l’attenzione sulle vicende personali e i macchiettistici individui che se ne rendono via via comprimari, dal problema strutturale si svierebbe verso quello contingente, non senza una patente contraddizione di fondo: se quell’ambito lavorativo si mostra così impresentabile, perché volerne far parte a tutti i costi, come parrebbe del Gardini agens?
Ma, per fortuna, così non è. I baroni non parla solo dell’università italiana come sistema incancrenito di rapporti di potere, di scambi di favori, di connivenze di tipo più o meno mafioso (così, almeno, ce la racconta il Gardini auctor, che, si badi, perlomeno nelle ultime pagine del libro non nega le proprie responsabilità, integrando opportunamente il j’accuse col mea culpa).
La chiave del libro è, invece, il passaggio in cui l’auctor-agens si definisce «ambizioso ma non competitivo», e l’ottica entro cui se ne può valutare retrospettivamente la tesi si fa perciò più interessante nel particolare e più persuasiva sul piano gnoseologico: lo scontro tra il reale e l’ideale, tra la pretesa diciamola romantica, idealista (o infantile) di trovare inverate le proprie aspettative “poetiche” (di bellezza, resistenza al tempo, armonia coi propri simili) in un mondo che si racconta più fedelmente con una prosa sconcia e volgare, le strategie perenni, i sotterfugi, le menzogne, non ultima l’inflessione intrinsecamente meridionale dei Baroni. Tra le pagine migliori, vi è infatti quella in cui Gardini contrappone al Barone per l’appunto il Poeta: questi, escluso dall’ingranaggio sociale perché incapace, avrebbe detto Pirandello, di “comunque vivere”; l’altro, pienamente integrato in un sistema in cui non contano le persone, ma le funzioni.
Il pungolo ai sognatori pare allora l’obiettivo primario del discorso, perché il loro più autentico sentire non soccomba fatalmente alle imposizioni autoritarie e brutali, e possa invece manifestarsi libero e appassionato. Gardini, cioè, voleva un posto nell’università italiana come l’amante attende corrispondenza dall’amato: l’intensità e la purezza del sentimento creano di per loro delle aspettative, anche quando l’amato si mostri alla prova del vero corrotto e meschino, e la reciprocità e irrecusabilità d’amore (per dirla alla Contini) non meno improbabili dell’agognata corrispondenza tra lo studioso (o il Poeta) e il Barone. Sempre che queste due figure non riguardino, dunque, solo l’università, ma la vita di ciascuno, entro un destino comune che, come emerge con crudezza dal resoconto, quasi impietoso, della malattia del padre, ci riduce inevitabilmente, prima o dopo, a cose inermi: e la nudità «dalla cintola in giù» del «demente», rovesciando vettorialmente la citazione del fierissimo Farinata dantesco, rende nel libro forse meglio dei troppi rimandi esibiti la verità della letteratura che sostiene la vita, che la accompagna, che ne medica i mali.
Conseguentemente, il racconto della morte, rimosso sociale più forte della nostra epoca, vale a recuperare a posteriori un senso per l’esperienza anche più tragica («per me la felicità ha a che fare con il passato», leopardianamente).
L’ «ambizione» di Gardini pare consistere, in definitiva, in un confronto coi simili, dove ve ne siano, meno segnato dall’aridità del contingente: al di là dei sassolini di cui pure la scarpa palesemente era ingombra.
[Questa nota è uscita sul quotidiano Liberazione]
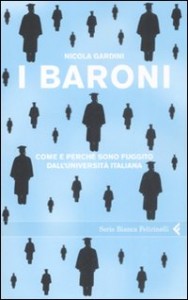
Nicola Gardini, I Baroni, Feltrinelli (2009)
“Del resto, il male dell’università è forse da individuarsi meglio in un cursus intollerabilmente lungo e privo di un approdo sicuro che nella corruzione dei singoli protagonisti.”
Nell’uno e nell’altro, formazione senza sbocco e impianto feudal-mafioso. La “corruzione dei singoli protagonisti” ha tutto il suo peso, come è evidente a chiunque abbia speso qualche anno oltre la tesi di laurea in una qualsiasi università.
“…sistema incancrenito di rapporti di potere, di scambi di favori, di connivenze di tipo più o meno mafioso (così, almeno, ce la racconta il Gardini auctor”
ma non solo il Gardini auctor ce la racconta così, ma – ripeto – anche chiunque abbia speso qualche anno oltre la tesi di laurea in una qualsiasi università…
nel caso, poi, qualcuno fosse interessato non solo a una vicenda esemplare tra tante, ma a uno sguardo un po’ più ampio e sistematico, leggersi: “Un paese di baroni” di Davide Carlucci e Antonio Castaldo, chiare lettere 2008.
Caro Andrea, quand’anche non avessi esperienza diretta del sistema universitario italiano, potrei dedurne dal solo libro di Gardini la differenza rispetto, ad esempio, al sistema anglosassone: lì valutazione dei titoli e del candidato in base alle esigenze di ricerca e didattiche del dipartimento; qui localismo e corsia di preferenza del candidato interno indipendentemente dalle sue competenze. Ma questo non dipende dai singoli docenti, più o meno integrati, più o meno onesti: dipende, a me pare, dall’assenza di un sistema selettivo di tipo meritocratico, a monte. Detto diversamente: se l’introduzione di criteri oggettivi per la valutazione dei titoli (sia pur con tutti i limiti che l’attribuzione di un punteggio, per dire del più importante, a una pubblicazione in base alla sua sede) si deve (sic!) alla riforma Gelmini (peraltro non ancora in atto), e per decenni il criterio selettivo sono state invece prevalentemente le prove scritte di concorso, tu al posto di un docente che avesse i titoli e le competenze per giudicare un candidato (dunque nella migliore delle ipotesi, cioè al posto di un docente preparato e onesto), come ti saresti regolato di fronte alle prove pressoché equivalenti di un candidato interno e uno esterno, il primo dei quali avesse speso anni della sua formazione accanto a te e sotto il tuo magistero, magari collaborando, come da prassi, alla didattica, agli esami e tutto il resto: a parità di merito, ripeto, non avresti favorito il candidato interno? E dunque, l’altro, pur meritevole, che non avesse per sua sfortuna nessun docente di riferimento, di grazia, in un sistema del genere, anche non corrotto, come farebbe a integrarsi? Questo intendevo, con le frasi che tu stralci dalla recensione. Grazie, comunque del suggerimento di lettura.
Cara Gilda so bene che il tuo intervento riguarda la lettura di un libro e non pretende di esprimersi su una faccenda complessa come la crisi dell’università. Ma poiché – in definitiva – se ne parla così poco, vale la pena di sottolineare alcune cose.
Sì, certo, l’assenza di un sistema di valutazione meritocratico.
Ma per certi versi questo è anche un problema dell’Università francese, in cui – senza una prova scritta ma attraverso pura valutazione del dossier da parte di una commissione – il candidato interno, conosciuto e fidato (poco autonomo), è preferibile all’incognita di una candidato esterno, che magari proprio perché molto bravo può gettare ombra.
Ma non è soltanto a questo aspetto che si deve il disastro dell’università italiana. Prendo giustamente l’esempio che fai tu:
“tu al posto di un docente che avesse i titoli e le competenze per giudicare un candidato (dunque nella migliore delle ipotesi, cioè al posto di un docente preparato e onesto), come ti saresti regolato di fronte alle prove pressoché equivalenti di un candidato interno e uno esterno, il primo dei quali avesse speso anni della sua formazione accanto a te e sotto il tuo magistero, magari collaborando, come da prassi, alla didattica, agli esami e tutto il resto”.
Il problema in Italia non si limita ad essere candidato esterno o interno, ma uno deve essere appaggiato dal barone che ha potere, anzi stra-potere. Anche se lavori benissimo da interno per un professore che non ha potere, non hai chances. Vi è dunque una diseguaglianza interna al sistema stesso dei pari, una diseguaglianza che si giustifica secondo parametri di tipo mafioso.massonico-clientelare. E qui già c’è una differenza con la Francia, in peggio.
Poi, in Italia colui che intraprende la carriera per divenire docente deve accollarsi carichi didattici enormi oltreché la ricerca in situazioni dove è sottopagato, e a volte per nulla pagato. Ed è una carriera lunga, disseminata di zone salariali morte. Ciò significa che la nostra è università che dal punto di vista del corpo docenti è iper-classista. Vanno avanti sopratutto coloro che hanno famiglie ricche alle spalle.
Infine, come nel sistema feudale, ognuno è l’uomo di un altro uomo. Se il tuo barone crepa, gli viene unictus, finisce in galera, pur con tutti i titoli, tutta l’affidabilità, tutto il leccaculismo esibito, sei morto, riparti dalla casella di inizio.
Detto questo, la crisi universitaria fa parte di un fenomeno internazionale e congiunturale. All’espansione delle istituzioni su scala mondiale fa fronte una crisi economica di scala mondiale, che produce un inevitabile ma provvisorio compromesso. Per mantenere in piedi l’enorme e costoso baraccone creato, i vertici, ossia i docenti e gli amministratori, sono costretti a favorire lo sviluppo di un sistema a due livelli, con pochi privilegiati sopra (con grande potere, ottimi stipendi, e tanto tempo libero per fare public relations) e una base di docenti precari, che si beccano per pochi euro la maggior parte del lavoro didattico.
Tutto questo è analizzato in modo chiaro ed efficace nel capitolo “Come conoscere la verità? L’universalismo scientifico” di un volume di Immanuel Wallerstein apparso per Fazi nel 2007, intitolato “La retorica del potere. Crisi dell’universalismo europeo.”
Il libro di Gardini non è bene vs male, ma è individuo vs mondo. Racconta la sconfitta dei sogni e degli ideali di una generazione intera, tradita dai padri e dai maestri. Nicola alla fine non trova l’Eldorado, non si salva, non è puro, ma è ALTROVE. Questa è la chiave: finché stava nell’università italiana era un barone pure lui, quasi senza accorgersene, certo senza volerlo. E’ la storia di un dramma, in cui il sistema soffoca l’individuo (senza la violenza di cecità di Saramago, ma forse con una lucidità più spietata, al punto che l’omogeneità linguistica che all’inizio mi sembrava una debolezza comincia a parermi sempre di più un’indispensabile soluzione per esprimere la solitudine e il dramma del soggetto senziente di fronte ai soggetti agenti).
Alla fine non c’è salvezza, né dentro né fuori. Oxford non cambia il suo punto di vista. Risolve la vita. Grande differenza: non vince il soggetto, ma la persona. I suoi sogni feriti e le sue ambizioni disilluse resteranno per sempre. Attenzione: Nicola nel libro non è un puro, anzi è un barone, fin dall’inizio, perché segue tutte le regole e tutti i meccanismi. Ciò che accade alla fine, allora, sul piano simbolico, è la presa di coscienza che non ci sono il mondo della corruzione e il mondo della felicità, ma che ci sono il sistema che soffoca e la cultura del rispetto. La persona si salva, appunto, ma non salva gli altri: i sogni restano infranti, per sempre. L’individuo è ferito, per sempre.
Non resta che stare male, fuori o dentro. Solo che fuori guardi da lontano, vedi con chiarezza, fai trionfare l’intelligenza, mentre dentro sei avvolto dal buio. Il libro è senza soluzione, ma non è disperato: è un invito a soffrire, a lottare, a credere. Il mondo è lì, con la sua carica di violenza e le sue regole sporche, ma l’individuo, almeno, uno sberleffo può farlo.
In addizione al commento qui su, che voleva essere una riflessione poetica a partire dalla recensione, vorrei notare che la recensione individua un punctum dolens che merita, a mio avviso, di essere discusso più approfonditamente (quello in cui sta, tra l’altro, la dimensione letteraria del libro, che è una denuncia, certo, ma anche un racconto): i sogni traditi. Molti s’innamorano dell’università perché la vedono come un’isola felice, una possibilità di realizzazione intellettuale, al di fuori dei rumori del mondo e degli squallori dell’economia, ma alla prova del vero rischiano, leopardianamente, di cadere.
Nulla di particolarmente grave, se ciò dipendesse dall’ingenuità di una società che sa coltivare le illusioni. Gravissimo, invece, se si pensa che l’università avrebbe compiti formativi e selettivi, cioè educare alla convivenza civile e scegliere i migliori per le funzioni direttive o le qualifiche professionali. Come può un’istituzione pubblica, che dovrebbe educare il cittadino all’intelligenza critica e alla responsabilità sociale, alimentare illusioni e mitologie? La risposta è facile, e risiede nel bisogno dell’universitario di legittimarsi non attraverso il lavoro (davvero troppo poco, non come orari, ma come costume e impegno) ma attraverso la mitologia (l’universitario è un genio e vive in un mondo migliore ed è felice).
Mi dispiace per Inglese, ma un libro pessimo come “Il paese dei baroni”, che punta solo alla denuncia spesso faziosa e poco argomentata, non aiuta. Il problema non è il nepotismo (il figlio bravo di un professore onesto non ha il diritto di lavorare alluniversità pure lui?), ma le regole, la chiarezza dei criteri, l’eliminazione dell’arbitrio.
scusate se accenno un commento non sul libro di nicola gardini, che non ho ancora letto – e mi riprometto di farlo -, ma sul merito del ddl governativo.
in realtà NON esiste a oggi almeno una bozza ufficiale del ddl gelmini. ne sono girate diverse, e dicono cose molto differenti tra di loro. è chiaro che la gelmini non sa quello che dice, e si comporta in base a interessi che mediano tra le richieste dei ministri che contano, tremonti e brunetta, e le lobby accademiche, anzi diciamo pure la lobby che è la CRUI.
infatti i rettori ormai detengono di fatto un potere assoluto. e – a livello di governance – questo ddl, nelle varie versioni, sembra ratificare de iure e anzi aumentare questo potere assoluto del rettore manager, mettendogli in mano il cda e svuotando di potere decisionale il senato accademico. cda in cui staranno anche personalità (…) esterne all’acc., tipo roba confidutriale, di nomina del rettore: un monarca.
il reclutamento, a quel punto dipendentissimo dalla gestione di questi monarchi, migliorerà? in una prima versione, non era prevista l’abilitazione sc. nazionale per i ricercatori. mantendendo il reclutamento locale nel ruolo generalmente di entrata, è ovvio che il localismo avrebbe continuato trionfalmente a marciare. mi pare che nella vers. più recente sia prevista l’ab. naz. anche per i ricercatori. ci saranno poi comunque delle valutazioni comp. dei singoli atenei cui potranno partecipare solo gli abilitati.
Le commissioni sarebbero fatte di sette ordinari (solo ordinari) per ogni SSD in carica per 2 anni, sorteggiati tra 21 eletti, più due stranieri designati dall’ANVUR.
L’ANVUR, una agenzia di valutazione, dovrebbe anche definire i criteri “oggettivi” per valutare i candidati.
Tutti sappiamo quanto sia difficile definirli, questi criteri, sptt per i SSD umanistici, in cui l’impact factor non appare un discrimine così dirimente. Va detto che – sec me -, se sono usati come requisiti minimi, possono andare (cioè uno deve aver pubblicato almeno x articoli sulle riviste riconosciute (che sono classificate in A B C, in modo per adesso assolutamente lunare). certo però, se applicato invece per scegliere tra – diciamo – due bravi studiosi, questo sistema porta a favorire quello che ha avuto maggior accesso a sedi sulla carta di prestigio, ma che non garantiscono il valore scientifico dei contenuti, il che può essere avvenuto anche per il patronage del “maestro” o perché lo studioso si è adattato alla linea della rivista, sacrificando magari la sua originalità scientifica, anziché pubblicare su sedi meno istituzionali o visibili.
In sintesi, la definizione di questi criteri va bene per evitare che siano cooptati portaborse senza titoli e pubblicazioni, meno per scegliere tra concorrenti scientificamente forti.
Altro guaio è che la procedura di cui nell’ultima bozza di ddl governativo è molto macchinosa, e richiederà tempi biblici per la prima tornata, e poi comuque tempi lunghissimi per l’espletamento ordinario
Cruciale comunque è il problema del turn over: ormai i rettori giocano talmente al risparmio, che i posti rischiano di essere pochissimi, se la legge avalla questo comportamento.
In ultimo, il PD ha presentato a sua volta un ddl che sec me – è triste dirlo -non è per niente meglio di quello governativo, soprattutto sulla capitale questione della governance.
scusate ancora la lunghezza e il parziale off topic, ma c’è pochissima discussione su questo ddl, e ce ne vorrebbe
@Zublena
Spiegheresti l’ultimo punto (”questione della governance”: se di OT si tratta, è comunque utilissimo, a me pare)?
gilda policastro scrive: “tu al posto di un docente che avesse i titoli e le competenze per giudicare un candidato (dunque nella migliore delle ipotesi, cioè al posto di un docente preparato e onesto), come ti saresti regolato di fronte alle prove pressoché equivalenti di un candidato interno e uno esterno, il primo dei quali avesse speso anni della sua formazione accanto a te e sotto il tuo magistero, magari collaborando, come da prassi, alla didattica, agli esami e tutto il resto”.
è un argomento diffuso, che personalmente non condivido (chi si presta a “collaborare” gratuitamente e fuori da ogni regola è corresponsabile di quanto accade più tardi), ma non voglio discutre di questo. a parte il fatto che non capisco perché una prova scritta debba esulare da criteri meritocratici, il problema non è tanto che – a parità di merito – ossia “di fronte alle prove pressoché equivalenti di un candidato interno e uno esterno”, il “barone” scelga l’interno che si è coltivato (la locuzione di andrea inglese “lavorare per un professore” è sintomatica di una forma mentis profondamente radicata), il problema più di frequente è che o le tracce delle prove scritte sono preparate per il candidato interno, oppure non hanno peso, nel senso che la loro valutazione non è discriminante. per esempio, ho scoperto per esperienza diretta che, quando una commissione stila in un bando una lista di criteri valutativi, che più o meno sono sempre gli stessi, ovverosia:
a- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore scientifico;
b- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
c- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
d- continuità temporale nella produzione scientifica in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.
questi criteri vengono applicati nell’ordine in cui vengono scritti ossia: il criterio al punto (c) viene preso in considerazione solo se (a) e (b) non sono bastati a distinguere tra i candidati. ovviamente il punto (a) è estremamente libero e basta sempre a fare la differenza nel modo desiderato. non c’è impact factor che tenga. questa regola rende anche impossibile i ricorsi.
saluti,
lorenzo
In Francia o in Italia una delle strategie del governo mi pare chiara, bisogna abbassare il numero dei dottorandi. In francia credo che a breve sara’ legalmente impossibile fare un dottorato senza borsa.
Esempi recenti:
facolta’ di storia dell’arte di parigi I (bizantina, medievale, moderna contemporanea) quattro borse (1300 euro), piu’ altre quattro che consistono nel farti lavorare a meta’ tempo in biblioteca in cambio di una salario da tempo pieno: 8 dottorandi all’anno. Cinque volte tanti.
Identica facolta’ a milano, credo due borse ( 990 euro).
l’inghilterra non e’, in questo caso, molto meglio. Courtauld institute, ad esempio, ti abbuonano le alte tasse di iscrizione (4200 euro all’anno) e poi, se non hai fatto i tuoi studi in inghilterra (in quel caso hai qualche chance in piu’), ti arrangi.
@ Paolo
Sono d’accordo con (quasi) tutto quello che dici e ritengo indispensabile aprire una discussione seria sulla definizione di VALORE e MERITO in ambito universitario, soprattutto umanistico.
I criteri di classificazione degli editori e delle riviste sono pericolosissimi, perché a) si rischia di privilegiare logiche di mercato piuttosto che di qualità (perché Einaudi dovrebbe valere più di Donzelli, o Lettere italiane più di Esperienze letterarie, ad es?); b) si rischia di perpetuare logiche clientelari che si vorrebbe combattere (si pubblica con X o Y più spesso per conoscenze o affiliazioni che per meriti effettivi e qualità riconoscibile).
Detto ciò, bisognerà pur far in modo che ci siano dei criteri di valutazione non assolutamente oggettivi (il che toglierebbe valore alla responsabilità di chi giudica, che invece deve assumersi l’onore e l’onere delle sue scelte, magari difendendole e motivandole in pubblico), ma certamente rigorosi e verificabili (cioè, fatta salva la scelta, comunque non arbitrari). Quali possono essere? Temi affrontati, rigore metodologico, conoscenza dei testi, della bibliografia critica, delle problematiche teoriche, strutturazione del discorso, padronanza stilistica e linguistica, chiarezza e artiolazione dell’argomentazione, ecc.? Mi sembra di tornare a scuola, ma forse che la commissione esprima GIUDIZI sui titoli sulla base di criteri limpidi e trasparenti (cioè all’interno di una definizione più omogenea dei possibili metodi e standard di valutazione) non sarebbe male.
La dispersione ormai è tale che per alcuni vale un articolo in inglese, per altri due o tre articoli su un quotidiano, per altri la supermonografia erudita, per altri l’edizione critica, per altri la ristampa anastatica, per altri lo sproloquio, per altri nulla…
Concordo con Stefano sulla pericolosità insita nei criteri di classificazione degli editori… sappiamo tutti che gli editori di saggistica più quotati sono quelli che hanno come direttori di collana docenti conosciuti… e chi faranno pubblicare i docenti conosciuti se non i loro pupilli interni? E’ però vero che c’è un differenza tra chi fa una pubblicazione a pagamento e chi no, e forse questo potrebbe rappresentare una sorta di criterio, poiché esiste un contratto di edizione dove questa cosa è specificata…
Un altro aspetto riguarda le pubblicazioni su riviste o testate registrate online, che in questo paese continuano ad essere considerate meno di zero, senza che chi debba valutarle si sia mai degnato di andare a leggere cosa vi si scrive…
Ad ogni modo siamo nel paese in cui fatta la legge si trova il modo di aggirarla, perciò se non si cambia mentalità si possono fare tutte le riforme di questo mondo, ma il modo di favorire qualcuno lo si troverà sempre… detto ciò, per esperienza posso dire che non sempre per fortuna è così… ci sono anche concorsi dove non è tutto già deciso, o almeno questa è stata la mia impressione partecipandovi…
@Carlucci
Tenderei sempre a considerare, nelle ipotesi, la situazione più retta possibile: cioè, in questo caso, che il candidato fosse meritevole comunque e avesse accettato di lavorare per il dipartimento secondo condizioni non di sfruttamento o di soggezione alla baronia, ovvero con regolare cursus, attraverso borse di collaborazione, assegni di ricerca etc. é evidente che fin qua, con la commissione scelta ad hoc, le prove scritte avessero più possibilità di incontrare gli interessi disciplinari del candidato interno, così la valutazione dei titoli, che essendo espressa con dei giudizi, ed essendo i giudizi stessi insindacabili (in quanti casi è bastato un avverbio in più o in meno a decretare un vincitore a scapito di altri altrettanto titolati concorrenti? ne è piena l’aneddotica universitaria, a me risulta), ha lasciato intatto e per certi versi inattaccabile il sistema della cooptazione (ricordo una puntata di ”Ballarò” dedicata all’università, un paio d’anni fa, in cui un ignaro Floris si chiedeva tra l’indignato e il basito se questo sistema concorsuale non fosse ai limiti della legalità).
@Jossa
I criteri cosiddetti oggettivi, sebbene discutibili e, come spiegava Zublena, orientati alla salvaguardia di interessi non sempre trasparenti, mi paiono comunque l’unica forma alternativa al sistema fallace della cooptazione. Vero, questi criteri vanno ridefiniti per le sperequazioni che più d’uno in questa discussione ha evidenziato. Ma è anche vero che una volta resi noti i criteri di valutazione delle riviste, nessuna redazione seria ha avuto difficoltà a soddisfarli: i garanti esterni, l’abstract degli articoli in inglese…non mi sembrano poi pretese dell’altro mondo, e, anzi, criteri minimi di qualità, ai quali, certo, è indispensabile che si sovrapponga la competenza e l’esperienza di chi giudica, come invocavi tu.
@Inglese
Insomma, nessuna smentita, mi pare, che al di là della corruzione dei singoli o meno, sia il sistema nel suo complesso ad aver difettato fin qua.
in barba ai criteri… io voglio la cooptazione da parte di baroni illuminati. che si assumano la responsabilità delle scelte fatte. basta. voglio poco in fondo no? nessuna cooptazione deresponsabilizzata mascherata da concorso.
Domanda: perche’ non individuate le 20-30 riviste piu’ accreditate (lasciamo da parte qui i come e i perche’ sono accreditate) nel vostro settore a livello mondiale, e non spedite li’ i vostri lavori, opportunamente tradotti? Se hanno “impact”, saranno pubblicati e aggirerete l’orticello feudale. Oltre che crearvi un network ben piu’ solido.
@chi
Mi viene in mente un esempio piccolo, ma utile, credo: so di alcuni ordinari che ritengono la modalità ”trattato” impraticabile nelle pubblicazioni scientifiche, che, vi ambiscano o meno, non giungeranno mai ad abbracciare lo scibile. Più praticabile e meglio valutata è dunque da costoro la raccolta di ”saggi” su un determinato autore o tema che si voglia, tipologia che dà modo e possibilità allo studioso di entrare approfonditamente in un argomento di volta in volta limitato e cricoscritto, sì da consentirgli di proporre una personale idea critica sullo stesso. Altri la pensano all’esatto contrario, che solo le classiche monografie, i saggi onnicomprensivi (per tacere delle famigerate edizioni critiche: la sterile filologia, per qualcun altro ancora) costituiscano titolo consono ad acquistare crediti ai fini concorsuali. Di fronte a questa disparità di vedute, come ci si pone? I criteri oggettivi (ossia la sede: non ne vedo altri) non possono essere una garanzia, di fronte alle pur legittime ”scuole” e ”tendenze” che per comodità in questa discussione stiamo definendo baronali?
scusate, sono di fretta. magari lunedì aggiungo qualcosa.
ma ora rapidissimamente
@ gp
la governance in pratica è la politica che orienta la gestione economica degli atenei. condizionata dai tagli pesantissimi, è sempre più nelle mani, più che del SA, del singolo rettore.
Inoltre non si capisce perché la CRUI (conferenza dei rettori) – o meglio si capisce fin troppo bene – si arroghi il diiritto di rappresentare gli interessi dell’univ. intera come interlocutore del governo. per quello è stato eletto il CUN. I rettori sono stati eletti per fare i rettori dei singoli atenei (alcuni per la terza volta, introducendo abili modifiche ai regolamenti).
i nuovi regolamenti cmq eliminano prove scritte ecc. i conc saranno cmq solo per titoli e pubblicazioni. dovrebbe rimanere la prova didattica. l’el. dirimente è se anche il posto da ric. (o di terza fascia che sia) prevede o no l’abilitazione nazionale. sarebbe meglio di sì.
per quanto riguarda i criteri, tema spinosissimo. io ripeto che sec me dovrebbero definire i requisiti minimi. non si può pretendere che una valutazione quantitativa possa dare un giudizio di merito tra due studiosi di riconosciuto valore. per alcuni SSD, quelli scientifici duri in particolare, ma anche – che ne so – psicologia clinica -, una monografia in italiano non conta niente, un articolo pubblicato su un grande journal internazionale moltissimo.
per un filologo 400ista questo sarebbe un criterio assurdo. bisogna definire criteri per aree omogenee (e invece abolire i SSD, volano per la politica dell’orticello concluso).
concordo cmq con sj sul fatto che si debbano dare dei criteri non rigidissimi, e poi – aggiungo – fomentare attr. dei premi (=finanziamenti) le scelte che puntano sul valore scientifico, anche confermato negli anni.
@ GiusCo: questo sistema è semplicemente inapplicabile a molti settori, e si basa esso stesso sulla mentalità dell’orto chiuso. (perché quelle riviste, perché un settore limitato, ecc)
@ chi: la cooptazione altrove può anche funzionare, in italia…
ci vorrebbero conseguenze devastanti, innanzitutto a livello di sottrazione di finanziamenti a lui e al suo ente di afferenza, per chi abilita o mette in cattedra un cretino/incapace/inoperoso: ma l’italia è il paese dei condoni e degli occhi che non vedono… alla fine il cattivo cooptatore si terrebbe sempre a galla.
visto che si sta avviando una massiva valutazione dei dipartimenti, non sarebbe male iniziare ad assegnare più risorse a quelli che mettono insieme una migliore produzione scientifica. sono però preoccupato di come si viene valutati: su una scelta – un florilegio – di prodotti scientifici, che presumibilmente verranno scelti tra quelli più catchy; e da un peer (cioè un altro dipart., italiano o no, che però viene scelto, per ora dal rettore, da una rosa indicata dal dip. valutando. siamo in italia, e temo il do ut des.
scusate se sono sceso nel tecnico, ma mentre è più facile concordare su alcuni principi generali, è poi difficilissimo accordarsi su quella che poi diventerà la lettera della legge o del regolamento…
spero che nicola non ce ne voglia per aver deviato dalla discussione sul suo libro, ma il tema è molto importante, e vale la pena di confrontarsi
un saluto a tutti i dibattenti
paolo
paolo zublena scrive:
La nuova gestione degli atenei prevede inoltre dei rappresentatnti del personale tecnico-amministrativo (bidelli, segretari, informatici e maneggiatori di apparecchi scientifici) solo nel Senato Accademico e non più anche nel Consiglio di Amministrazione. Questo personale è pari in numero al personale docente, tanto per capirci.
Ancora paolo zublena:
Ad esempio Enrico Decleva, rettore dell’Università degli Studi di Milano ed eletto presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori) quando era ormai al secondo mandato da rettore, che ha fatto modificare lo statuto di ateneo per un terzo mandato a causa “del rilevante interesse per l’università italiana in un momento cruciale di cambiamento” (cito a memoria).
meno male che era rapidissimamente. ora sì che sono in ritardo :)
il principio di carità che policastro intende applicare (“Tenderei sempre a considerare, nelle ipotesi, la situazione più retta possibile”) in questo caso può essere fuorviante, e la questione sollevata da “chi” non va liquidata troppo velocemente. c’è una “falla” del sistema che esula dalle regole concorsuali, ed è il fatto che i professori non sono sottoposti a controlli sulla qualità e quantità della produzione scientifica. ossia non sono tenuti ad essere competitivi. e per tanto non hanno interesse ad esserlo, se non per motivi individuali. per questo non sono motivati a scegliere i loro “collaboratori” in base a criteri puramente scientifici e accademici di competitività. a un livello più alto, le università non sono spinte ad essere competitive nelle assunzioni, etc. se i professori dovessere rendere conte della qualità del proprio lavoro, e se le università avessero a cuore di mantenere alta la qualità del proprio corpo docente, il sistema diverrebbe ipso facto più meritocratico. forse in una misura che non si potrebbe ottenere dal basso con un enforcement a livello di regolamenti concorsuali. come stimolare dinamiche di questo tipo?
saluti,
lorenzo
a Eroicomico, che scrive:
“Mi dispiace per Inglese, ma un libro pessimo come “Il paese dei baroni”, che punta solo alla denuncia spesso faziosa e poco argomentata, non aiuta. Il problema non è il nepotismo (il figlio bravo di un professore onesto non ha il diritto di lavorare alluniversità pure lui?), ma le regole, la chiarezza dei criteri, l’eliminazione dell’arbitrio.”
Il libro di Carlucci e Castaldo non ha nessuna pretesa letteraria, è puro giornalismo d’informazione. Da questo punto di vista non può essere paragonato ad un libro come quello di Gardini, che ha altri intenti e ambizioni. Deve spiegarmi però Eroicomico perché è un libro pessimo. Io credo che il silenzio sia pessimo, su questi argomenti. Poi il libro non denuncia certo solo il nepotismo… Eroicomico l’hai letto? Vi sono citati, con fonti e riferimenti precisi (spesso a procedimenti penali) situazioni molto diversificate. Perché parli di “denuncia poco argomentata”. Certo, ce ne vorrebbero dieci e non uno di libri sull’argomento, e anche propositivi, non solo di denuncia. Ma perchè così tanta fretta di obliare i tanti soprusi che per decenni sono stati considerati usanza legittima?
@ Inglese
non voglio fare una polemica con quel libro, che ho letto e non mi è piaciuto, perché mi è sembrato animato da un intento scandalistico, quasi sempre pronto a selezionare il singolo bersaglio utile anzichè individuare contesti e problematiche. L’esempio notissimo per chi lavora nell’ambito letterario è quello del famigerato concorso di Bari con tre candidati (Canfora-Sanguineti-Campanelli), di cui due (bravissimi, ancorché discutibili) figli di baroni e uno (eruditissimo) figlio di nessuno. Ora, gli autori del libro parteggiano decisamente per l’ultimo, stralciando i verbali in maniera faziosa (tanto da essere stati denunciati), solo perché “non è figlio di baroni”. Argomento ridicolo e deficiente, scusate, perché il problema è, appunto, la serietà dei concorsi, non chi li vince: ad esempio c’era da chiedersi come mai ci fossero tre soli concorrenti, come si era formata la commissione, chi sosteneva chi e perché, ecc. (va da sé che il “figlio di nessuno” tra l’altro non è affatto tale). Tutto ciò nel libro non c’è.
E’ un solo esempio, lo so, ma altri se ne potrebbero fare. Secondo me il libro sbaglia completamente il tiro e gli obiettivi. Secondo me non ce ne vorrebbero dieci di libri sull’argomento, ma diecimila di processi penali per le irregolarità di fatto e di diritto (notissime e provabili, ma spesso non denunciate per paura: a partire dagli inviti, + o – espliciti a non partecipare a questo o quel concorso) e diecimila di dibattiti politici come questo.
@ tutti
noto nel dibattito la solita grande assenza quando si parla di università in Italia: gli studenti. Siamo tutti preoccupati (giustamente) per il reclutamento, ma si rischia di dimenticare la funzione pubblica dell’istituzione. Se ha senso – almeno finché non verrà privatizzata – è perché si occupa di FORMAZIONE. Altrimenti che sia un’istituzione di ricerca pura, ma ciò dev’essere chiaro preliminarmente. Chi vince un concoso, quindi, dev’essere bravo a insegnare! porsi domande che vadano al di là del bel compitino da pubblicare sulla prestigiosa rivistina e coinvolgere persone in orizzonti di senso collettivi (anche per rimetterli in discussione). Altrimenti non si parla più di UNIVERSITAS, ma di un’altra cosa, il che può pure andare bene, ma va, appunto, chiarito.
@ Stefano
sono d’accordo con te che i criteri vanno stabiliti, ma non troppo rigidamente. Cioè, voglio dire, i commissari, come dici tu, se li devono leggere, ‘sti benedetti titoli (magari tre o quattro anziché cinquanta, però li devono leggere). Se danno, che so, 5 punti a quello su Nature, 4 a quello su Science, 3 a quello su National Geographic, e così via ( magari con 0.75 se supera la 20 pagine, 0.5 tra 15 e 20, 0.25 tra 10 e 15, ecc.), la commissione viene totalmente deresponsabilizzata sul piano politico e i giochi si faranno altrove (cioè nella battaglia, lancia in resta, per pubblicare, nel caso dell’esempio, su Nature). Ridicolo.
a proposito, per rimanere in tema, un romanzo (non un’inchiesta) sul mondo dei concorsi universitari (e non solo) è “La testa di Ale”, di Gaia Mencaroni, uscito nel 2008 per “Lampi di stampa”.
Qua la recensione che feci a suo tempo: http://www.scrittorisommersi.com/gruppo-di-lettura/gruppo-di-lettura-la-testa-di-ale-di-g-mencaroni/
@Eroicomico
Ho chiesto al fratello fisico all’ENS di Parigi di darmi una testimonianza della situazione francese. La riporto, perchè mi pare utile alla discussione, specie sulla questione da te sollevata della formazione:
”Dunque: la situazione francese è che ci sono due percorsi
paralleli di reclutamento: il CNRS a cui si accede con concorso
nazionale, per titoli e colloquio, e in cui si è ricercatori senza obblighi didattici,
e l’università, che bandisce invece un concorso separato per ogni posto disponibile.
Ai concorsi per l’università si accede solo dopo aver ottenuto la “qualification”, che viene data
sulla base di un dossier, esaminato da due “rapporteurs” che devono stabilire
se il candidato è in grado di insegnare in francese, il che evidentemente favorisce i candidati francesi.
Quindi per i posti universitari l’enfasi è totalmente sull’insegnamento a livello della qualification,
mentre a livello del concorso effettivo dipende molto da caso a caso, e non saprei dire se ci siano
fenomeni paragonabili al baronismo italiano, nella mia limitata esperienza personale direi molto meno comunque.
Per il CNRS invece, normalmente la selezione è più aperta, anche se nella maggioranza dei casi
i candidati che vincono sono in qualche modo legati al sistema francese, cioè raramente entra un outsider completo
che non ha nessun rapporto con qualche laboratorio o dipartimento in Francia”.
Nemmeno quel sistema, a quanto pare, è esente da limiti e contraddizioni, ma quello italiano si conferma il peggiore di tutti, in ogni caso…
@ gp
L’italiano è il peggiore, sembra proprio di sì…
Io posso solo portare alla discussione il mio ossservatorio dall’INGHILTERRA, riallacciandomi così indirettamente al punto di partenza, cioè il libro di Gardini.
In Inghilterra i posti sono banditi SOLO sulla base delle esigenze didattiche: se aumenta il numero degli studenti, o se si trasferisce o va in pensione qualcuno, si bandisce un posto. Si va in pensione a 65 anni – questo è un elemento culturale importantissimo, perché si ritiene di solito che si debba insegnare DA GIOVANI, quando si hanno entusiasmo ed energia, e fare ricerca da anziani, quando si hanno conoscenze ed esperienza – discutibile, certo, ma sta di fatto che in tal modo si entra di solito relativamente giovani, prima dei 30 anni, e si va in pensione con tanta voglia di continuare a lavorare e scrivere, col risultato che spesso i migliori contributi di ricerca arrivano da studiosi che hanno più di 60 anni.
Il posto viene bandito all’interno di un settore disciplinare molto ampio (come italiano, o inglese, o economia, o biologia), ma sulla base delle esigenze didattiche, quindi se c’è bisogno di un insegnante di poesia contemporanea o di fissione nucleare, al concorso, benché bandito per italiano o per fisica, saranno certamente favoriti gli specialisti della competenza richiesta – ma non necessariamente vinceranno, poiché l’importante è che il candidato sia in grado, appunto, di insegnare la materia, senza doverne per forza essere il massimo o unico esperto. Le caratteristiche del candidato ideale non sono segrete, naturalmente, ma sono esplicitate dal bando (cosa maldestramente importata in Italia qualche anno fa col solo obiettivo di favorire il candidato interno, fino al paradosso di avere a un concorso una sola domanda, quindi niente concorso, of course! – statisticamente il 90% dei concorsi degli ultimi dieci anni – il dato è “a senso”, online non lo trovo, sarebbe bello se qualcuno potesse produrlo).
Al concorso in Inghilterra non si presenta praticamente mai un solo candidato. Di solito, anzi, le domande sono moltissime. La commissione, che è composta da due professori della disciplina (italiano, inglese, fisica, biologia) + un membro del Dipartimento ma di altra disciplina (un ispanista, ad es, se il concorso è d’italiano, o un matematico se il concorso è di fisica, dipende però dalla composizione dei dipartimenti) + un membro della dirigenza (preside o direttore di altro dipartimento, dipende anche qui dall’organizzazione) + un membro dell’amministrazione, sceglie una lista di candidati adatti al posto sulla base dei soli titoli (di solito al massimo 10 per un posto).
Avendo ciascun candidato fornito i nomi di almeno due referees, a questo putno la commissione interpella i referees. Dopo aver ricevuto le risposte, la commissione riduce i candidati a 4-5 per le prove.
Le due prove consistono in una lezione, in cui il candidato deve, su un argomento scelto dalla commissione e comunicato in anticipo, dimostrare la sua abilità didattica e una discussione di titoli, progetti e competenze.
La variabilità dei singoli passaggi e delle singole prove è alta, ma la procedura è sempre la stessa. I criteri di valutazione sono generici, come qualità, impatto, prestigio delle sedi, ecc., ma secondo parametri sempre prestabiliti e pubblici. Il candidato che sa che in quel concorso un articolo su nature sarà valutato di più di uno su Science e non ha un articolo su Nature potrà arrabbiarsi, ma almeno sa già da prima cosa è richiesto e cosa no. Viceversa chi ha l’art su Science non sarà affatto sicuro di vincere, perché magari un altro ne ha due, o perché magari ha solo quello e ci sono altri requisiti, ecc.
La chiarezza delle regole e la responsabilità della commissione a me sembrano i due elementi qualificanti del sistema inglese. In particolare il secondo mi sembra importante: se assumi un cretino, sei un cretino. La responsabilità eè tua e solo tua: non esistono metodi per far passare per intelligente un cretino o per bravo un mediocre o per serio un siuperficiale o per lavoratore uno scansafatiche. Esiste un giudizio della comunità accademica che è forte, condiviso e vincolante; esiste una DEONTOLOGIA professionale, che vuole dire un’etica della comunità universitaria, che in Italia si è persa da circa quarant’anni. Certo, si dirà, in Italia c’era al tempo dei Baroni con la B maiuscola, quelli degli anni 50 e 60; ora abbiamo i baronetti, ma non si comportano diversamente, anzi.
L’Italia non ha saputo fare i conti con l’Università di massa, ma resta aperta la domanda che si faceva già all’inizio degli anni Settanta: come si fa a coniugare qualità e comunità, selezione e diffusione, formazione delle élite e uguaglianza delle opportunità, premio del merito culturale e perequazione delle disparità socioeconomiche? L’apertura di un doppio livello, formazione alta e formazione di base, è chiaramente sbagliata (anche perché finora è avvenuta, come nel caso dei cosiddetti istituti di studi supriori e delle scuole di eccellenza, su basi valutative ben poco chiare e spesso di apprtenenza di gruppo, difetto storico dell’università italiana). Allungare la formazione è ancora più sbagliato, perché ritarda l’accesso al mondo dl lavoro. Pensare a una formazione sul lavoro, invece, potrebbe essere già un buon passo in avanti. Se avete altre proposte al riguardo, ne sarò felice!
Resta ovvio che i difetti del sistema inglese sono sotto gli occhi di tutti: fortissima omologazione, chiusura corporativa, torre d’avorio vs impegno sociale, rischio di prevalenza della burocrazia sull’intelligenza critica, riduzione della cultura a amministrazione… Però è un’università più onesta, più trasparente, più chiara nei suoi obiettivi e nei suoi metodi. Su Hegel si sputa da 40 anni, ma la sintesi va cercata o no? Solito dilemma: troppa organizzazione=scarsa libertà; troppa libertà=scarsa efficienza. Un’istituzione pubblica, a mio avviso, dovrebbe puntare all’organizzazione e all’efficienza piuttosto che alla libertà di pochi privilegiati (fatta salva, invece, la libertà di pensiero, che è un’altra cosa- ma il fascismo, si sa, in Italia incombe sempre, al punto da far preferire spesso più aribitrio e più mafia per evitare eccessi di controllo e omologazione).
Vorrei rivolgermi principalmente all’ultimo intervento, quello di Stefano Jossa, anche perche’, non avendo letto il libro da cui origina questa discussione, non ho elementi per entrare davvero nel vivo delle altre questioni sollevate. Ma del blog di Stefano mi ha colpito la contraddizione interna condensata nel paragrafo finale. E vorrei chiederti, Stefano, come pensi possano convivere l’idea di un sistema corporativo, omologato e chiuso difensivamente al contesto sociale e l’idea opposta di una trasparenza onesta e deontologicamente corretta dei suoi reclutatori. Sempre nel capoverso finale alludi a un sistema che difende pochi privilegiati, riferendoti, se non ho frainteso, al nostro italiano, quando invece e’ notorio che sia proprio il modello anglo-americano a concepire l’intera formazione educativa come appannaggio e privilegio di ristretti ceti dominanti. Non scuola di massa, quella, ma palestra di formazione di élite economiche, per principio strutturale.
Beninteso, sono d’accordo con te e con gli altri sulla necessita’ di criticare il piu’ duramente possibile il nostro sistema universitario, per la corruzione e il malcostume ormai gravissimi in cui esso versa, in linea con il degrado di tutte le nostre altre istituzioni sociali, del nostro quadro politico. E tuttavia, diffido di qualsiasi forma di esterofilia che tenda a presentare l’altrove anglo-americano come un eldorado. La mia esperienza di viaggiatore accademico incallito mi ha reso assai scettico anche sui sistemi altrui. Spesso migliori del nostro (ci vuole poco, del resto), ma non certo perfetti o puri o onesti come spesso noi italiani disperati li descriviamo a noi stessi, anche in virtu’ del nostro eterno senso di inferiorita’ e inadeguatezza. Non vorrei essere frainteso. Lo ripeto, la mia non e’ certo una difesa dell’accademia nostrana, che nessuno, credo, potrebbe in buona fede difendere. Ma e’ un invito a introdurre nella discussione qualche nota di scetticismo anche riguardo ai metodi di reclutamento vigenti altrove. Non e’ tutto ora quello che brilla. Proprio no. E vorrei restringere il campo del discorso all’ambito accademico della cosiddetta italianistica (che mi pare sia anche il campo di molti degli intervenuti in questo blog), rovesciando pero’ la prospettiva del ragionamento. Vorrei chiedervi: se il sistema anglo americano fosse cosi’ meritocratico come scrivete, come mai il livello dell’italianistica all’estero, anche in Inghilterra e in USA, resta ancora oggi cosi’ paurosamente e a volte persino commoventemente basso? Certo, si tratta di un settore particolare rispetto a tutti gli altri, di un settore che conta molto di piu’ da noi che altrove, ovviamente. Eppure nelle mie peregrinazioni indefesse presso universita’ straniere, ho spesso verificato una preparazione cosi’ scarsa tra i docenti di italiano, anche tra quelli che ricoprono le cattedre piu’ prestigiose, da far rimpiangere molti non dico docenti, ma persino dottorandi italiani. E percio’ mi chiedo e vi chiedo: come mai la qualita’ resta cosi’ incomparabilmente superiore in Italia, nonostante il declino spaventoso dell’istituzione e lo stesso conseguente, vertiginoso abbassamento della nostra qualita’ – come mai resta comunque aperto un cosi’ grande gap in questo specifico settore di ricerca? La meritocrazia non dovrebbe produrre una maggiore qualita’?
Infine, vorrei chiedere a Stefano se anche a lui risulta, come a me, che la maggior parte dei docenti italiani trasferitisi all’estero dopo la laurea e magari anche ben impiegati farebbero pero’ di tutto tornare a operare nel sistema italiano. Questa e’ una cosa che mi stupisce sempre molto, ma che puntualmente verifico quasi al cento per cento dei casi. Vorrebbero quasi tutti ritornare, nonostante sappiano bene cosa accade nella nostra fatiscente Italia. Spesso si lamentano dei sistemi che li ospitano, e una lamentela ricorrente e’ proprio quella relativa al basso livello scientifico in cui si imbattono negli atenei ospitanti. Anche a Cambridge, Oxford e Londra, persino a Columbia, Harvard e Princeton ho conosciuto docenti italiani afflitti da questo tipo di frustrazione. Come mai? Non e’ strano che si lamentino di strutture che gli altri vedono come eldoradi? E poi le universita’ straniere non sono tutte centri di eccellenza. Esiste una notevole sperequazione tra atenei. Anche in Francia, come nel Regno Unito e in USA, i dislivelli sono fortissimi. E la vera differenza la fanno i bilanci – i soldi – non la pratica del reclutamento meritocratico. In un sistema capitalistico e’ evidente che il merito possa servire al meccanismo economico e come tale – e solo come tale – possa essere in molti casi difeso. Ma il sapere umanistico, che certo serve meno, siamo sicuri che in quel sistema sia veramente alimentato al meglio? Mi chiedo come faccia un docente poco bravo a selezionare il concorrente piu’ bravo in una competizione. Nel migliore dei casi, e cioe’ quando sara’ in buona fede (cosa non cosi’ pacifica e scontata come si crede, all’estero) scegliera’ in base al suo proprio metro non eccelso di giudizio. Ed ecco forse spiegata la causa del persistente basso livello dell’italianistica. Forse. Certo, la meritocrazia assoluta e’ un’utopia. Ma la valutazione del livello scientifico non lo e’. Giudichiamo anche dai risultati, non solo dalla presunta correttezza neutrale delle procedure.
E chiudo ripetendo ancora: il mio e’ un invito allo scetticismo universale, non a una difesa dell’esistente nostrano.
Mi piacerebbe sapere qual è il livello in Italia di Anglistica.
[…] Fonte: dei baroni non si sa niente – Nazione Indiana […]
ieri un mio amico, mentre discutevamo del libro di gardini e del pezzo di policastro, ha chiosato “l’accademia italiana e’ inemendabile”, mi e’ sembrato nostalgico e assai bello.
Grazie, accademico scettico, per i tuoi commenti e rilievi. In particolare apprezzo la nota sulla mia contraddizione, che tale è perché tale voleva essere. Non intendevo, cioè, magnificare il sistema anglosassone, di cui ben conosco pregi e limiti, ma solo mettere in rilievo una procedura concorsuale e una metodologia politica che sono profondamente diverse dai nostri. I due punti che sollevo – chiarezza delle regole e etica della comunità – restano a mio avviso i punti di partenza indispensabili per una discussione che non sia fatta solo di numeri, sigle e correttivi, ma anche di contenuti culturali e civili.
La prospettiva proposta da accademico scettico è interessantissima perché mette in gioco la questione dei punti di vista, allargando lo spettro e intrecciando gli sguardi. E’ certo vero che il livello dell’italianistica all’estero è più basso che in Italia, ma attenzione, perché l’italianistica in Italia è storicamente al primo posto della gerarchia in ambito letterario, mentre in Inghilterra è del tutto marginale. Se si fa un confronto fra sistemi anziché fra discipline, l’italianistica in Italia andrebbe paragonata all’anglistica in UK e USA. Va anche considerato il fatto che gli italianisti in Italia (Fonte sito MIUR) sono oltre 400, mentre in tutta la comunità accademica angloamericana saranno meno di 200 (visto che la disciplina include anche social studies, history, art, + cinema + mafia + calcio + cucina, etc, altra cos di cui discutere, certo). Più facile, insomma, eccellere in Italia, per tanti motivi, storici, culturali, politici e strutturali. Nonché linguistici. Non disprezzerei, però, il livello di gran parte dell’italianistica non italiana, anche se da questo punto di vista dovremmo aprire discussioni ancora più larghe e approfondite: mi limito a dire che l’italianistica straniera e quella italiana sono sempre più distanti, anche per motivi metodologici, il che fa sì che l’italianistica italiana, almeno al 50% chiusa sul recupero antiquario, l’impegno editoriale e la (ri)produzione di testi e manuali, sia completamente ignorata all’estero. Facile sentirsi al top se gli interessi sono linguistici, eruditi, archivistici, ecc, molto meno quando si ha a che fare con la storia delle idee, le interpretazioni, i contesti culturali, ecc. Argomento da approfondire, mi rendo conto.
Ultimo punto, davvero dolens: perché gli italianisti italiani all’estero vogliono tornare? Facile, sciovinistica risposta: perché in Italia si lavora meno. L’ho detta come provocazione e la lascio qui, ma l’argomento va considerato… Oltre a ciò, è chiaro, si entra nel personale: prima di tutto, essendo italiani, forse vogliono vivere, nonostante tutte le storture e incazzature, in questo paese odiatamato; poi molti hanno scelto l’italianistica perché in Italia la materia ha anche un valore politico e civile, che per forza di cose non ha altrove (e qui torna il problema della differenza tra i sistemi culturali); inoltre il contatto con la lingua, la presenza sulla scena pubblica, dalla libreria al giornalismo, l’italianità assoluta della disciplina non sono argomenti di poco conto. Bisognerebbe allora verificare quanti economisti o fisici o antropologi italiani all’estero desiderano tornare…
D’accordissimo sullo scetticismo, nonché assolutamente contrario a ogni celebrazione dello straniero in quanto superiore in quanto tale, resto convinto che, per il sistema di reclutamento, per la mediocrità diffusa, per l’etica della sopraffazione e della sottomissione, per la cultura delle affiliazioni più o meno occulte, spesso esterne ed estranee all’università stessa, l’università italiana, in questo momento storico, è di gran lunga PEGGIORE di quelle straniere (inglese, francese, tedesca, americana, spagnola, portoghese, quelle di cui so qualcosa).
Lettura suggerita @ tutti: Benedetto Croce, “Il caso Gentile, e la disonestà nella vita universitaria italiana”, Bari, Laterza, 1909 (stranamente l’unico libro crociano mai più ristampato, nonostante l’attivismo dei crociani militanti con edizioni nazionali, ristampe e collezioni, da Adelphi al Mulino).
mi rendo conto di non aver detto nulla sui “privilegiati”. A mio avviso i privilegiati in Italia sono quelli che lavorano all’Università, non perché ci siano entrati per privlegio acquisito, ma proprio perché ci sono entrati. In Inghilterra e in America ci si entra di più per privilegio acquisito, essendo la società classista, ma quando ci si entra si è molto meno privilegiati. Io resto cnvinto che il professore italiano goda di una libertà intellettuale e lavorativa che all’estero non c’è: è un bene o un male? Non lo so, ma è un altro punto di cui si dovrebbe discutere: qual è la funzione della cultura umanistica nella società non più del capitalismo avanzato, ma dei media e dell’informatica?
Grazie per l’appunto sull’Anglistica.
E per averci ricordato anche che gli italianisti delle università italiane sono cagati poco all’estero.
Ho letto anch’io l’intervento di Stefano Jossa e piu’ o meno corrisponde alla mia esperienza (vivo e insegno in Inghilterra da molto).
Piccole aggiunte: in parte e’ vero che se assumi un collega mediocre il dipartimento ci fa una brutta figura, ma quello che passa per la testa dei commissiari e’: “se assumo un collega che non ‘funziona’ (per vari motivi) poi ci devo convirere per anni!”.
Le ragioni per cui una nomina puo’ andare male sono diverse: la persona non vuole insegnare quello che aveva promesso, smette d’improvviso di fare ricerca, si rivela molto difficile, etc. Non e’ tanto o solo il giudizio dei pari, ma la verifica successiva. E’ ovvio che poi spesso ci si scontra in commissione sui vari candidati, perche’ in un qualche modo la nomina caratterizza il dipartimento, quindi, a parita’ di bravura, c’e’ chi preferisce andare in una direzione e chi in un’altra. Anche questo mi sembra fisiologico…
Trovo strana la vostra ricerca di un metodo perfetto per valutare il merito accademico. La vera differenza tra il sistema inglese e quello italiano e’ che qui se si fa un errore nell’assumere un collega, se ne pagano le consequenze. Non e’ affatto vero che hanno trovato il metodo perfetto per dare posti, ma hanno un sistema per cui si e’ responsabili delle scelte fatte. Questa e’, a mio parere, la vera differenza.
Va poi detto che anche qui capita che si facciano degli errori. Sarebbe ridicolo pensare il contrario. Inoltre, gli stipendi sono piu’ bassi che in Italia (giusto?) e quindi molti pensano bene di fare altro nella vita, magari professioni che permettono di scrivere libri stando fuori dal sistema. Qui esiste un mercato delle lettere ben piu’ vasto che in Italia!
Il sistema inglese ha certo dei difetti, che sono la mancanza di finanziamenti, l’aumento della burocrazia, e la costante spinta a trovare fondi esterni. Non trovo, almeno nel mio campo, ci sia la sindrone della “torre d’avorio”. Anzi, siamo spinti ad avere rapporti con quello che in Italia si chiama “il territorio”, spesso a spese di una ricerca teorica di lungo periodo.
Mi permetto una osservazione sociologica: non mi pare che i professori italiani abbiano davvero intenzione di cambiare il sistema che li ha prodotti e quindi temo che non vi saranno rivoluzioni di fondo.
Non mi risulta neppure che gli italiani che insegnano nella mia universita’ aspirino tutti a tornare in Italia, e il sistema americano e’ completamente diverso. mah
Ah, e concordo di nuovo con Jossa 2 (che non avevo letto). Ammesso che gli italiani vogliano tornare, il motivo semplice e’ che si lavora di meno e si guadagna di piu’. Vi sono poi motivi non intelletuali, come voler vivere nel proprio paese. La questione sollevata dal libro di Gandini non e’ che i profe ordinari fanno una vitaccia, ma che i meccanismi di reclutamento non sono trasparenti e onesti …
@Jossa, Fede
”Si lavora di meno, si guadagna di più”, suona un po’ apodittico e immotivato. L’anno accademico inglese, ad esempio, è più breve di quello italiano, e non so dire se sia effettivamente più intenso. Inoltre non esistono esami di fine corso, a quanto ne so. E questo fa una gran differenza, mi pare, a partire dal fatto che un corso di Letteratura italiana in Inghilterra è seguito da una trentina di studenti, a dir tanto, e in Italia almeno dal doppio, a dir poco.
A chi invece stigamtizzava un’eccessiva fiducia nei ”criteri”, vorrei far presente che il limite della nostra comunità scientifica è proprio quello di aver sempre considerato alcune dinamiche immutabili come leggi di natura (che pure cambiano, in verità). Questo è tanto più grave rispetto alla generazione dei 30-40 enni, arresi a meccanismi che li hanno soffocati e quasi cancellati come generazione atta a esprimersi, a esporsi, a mutare il già dato. Ciascuno aspetta paziente il proprio turno, e sono mancate quasi del tutto (salvo rari momenti di occasionale allarme di fronte all’ipotesi delle sciagurate ”riforme”) iniziative collettive di presa di coscienza, quanto meno, di un sistema che, ripeto, anche nella migliore delle ipotesi possibili, cioè gestito da docenti illuminati e al di sopra di ogni sospetto, non ha garantito fin qua un’autentica possibilità di un regolare cursus, a partire dalla quasi totale assenza delle borse di postdottorato o degli assegni di ricerca, che dovrebbero segnare le tappe di un progressivo avvicinamento all’obiettivo della docenza e della ricerca strutturata. Si sono invece moltiplicati i dottorati, sfornando quantità ormai incontrollate e ingestibili di studiosi, a volte iperspecialisti dal futuro quanto meno vacillante, per non dire inesistente.
Invocare sempre i cambiamenti dall’alto, senza mai arrivare a considerare che la controparte è costituita molto spesso da individui preoccupati solo della propria personale riuscita accademica e mai di sostenere se non proporre le ragioni di un mutamento radicale delle condizioni di crescita professionale, fa molto anime belle e contestatori a chiacchiere, e sa molto, al tempo stesso, di scarico di responsabilità. Gardini questo lo dice molto bene: chi arriva, dimentica tutto quello che gli è capitato, e si piega alle storture, se non commettendone in prima persona, almeno non denunciandole. Gardini stesso confessa di aver accettato il ”sistema”, per poi criticarlo perchè nemmeno alle condizioni umilianti cui si era sottoposto gli garantiva la possibilità di realizzare il suo obiettivo, e cioè insegnare all’università (fino al paradosso di percepire uno stipendio senza avere gli studenti, o di aver avuto l’idoneità senza la chiamata). Ma quanti potrebbero raccontare la stessa storia, e non lo hanno mai fatto, nè accetterebbero di farlo, mai?
…stigmatizzava (e altri refusi…)
Eccomi di nuovo. Concordo con Gilda P. Gardini solleva un aspetto interessante, che, detto in altri termini, e’ il seguente: il personale docente viene “filtrato” su una certa qualita’ o disposizione, cioe’ accettare il sistema. Chi non lo accetta e’ meno probabile che vi entri. In questo senso, il mondo accademico italiano non e’ dissimile da altre professioni. Il problema e’ che il filtro andrebbe “pulito” (per usare la stessa metafora …).
Si lavora di meno in italia? sospetto di si’, ma non voglio certo iniziare una rincorsa a chi si piange di piu’ addesso, era solo una possibile spiegazione del perche’ sembra che molti vogliano tornare, ma vi sono certo anche ragioni. Mi si dice che in Italia si puo’ insegnare solo un semestre (tre mesi), e mi si dice che le pensioni sono circa il 90 % del salario (qui sono il 50%). [Di certo questo governo ci pensera’ a ridurle …] Guarda gli stipendi medi di un university lecturer (£30,000) / reader / professor e vedi se sono piu’ bassi. vedi: http://www.jobs.ac.uk/
Esistono esami di fine anno scritti per tutte le materie, da correggere …
non e’ questo il problema sollevato da Gardini, ma l’impressione che si ha da qui e’ che i profe italiani, ma di piu’ quelli tedeschi e francesi, siano piu’ privilegiati e rispettati. magari e’ solo un’illusione …
in ogni caso, complimenti per la recensione! f
Belle discussioni, propositive e intelligenti. Ma non se ne uscirà mai quando la prassi poi si allontana drammaticamente dal pensiero. Un esempio personale. Un vs. collaboratore, persona di sinistra e di mente aperta e fustigatrice dei costumi (a parole), Carla Benedetti, contribuì anni fa a non farmi avere un posto di dottorato a Pisa: ero secondo, i posti erano due, ottimo orale, ma poi passò il candidato interno. Sic transit gloria mundi…
Grazie per la tua risposta, Stefano, e grazie anche a Fede per aver chiosato qualche aggiunta. Concordo con te: per entrare meglio nel discorso sulla qualita’ scientifica dell’italianistica o dell’anglistica in Italia o all’estero dovremmo approfondire molto, entrare in dettagli, fare esempi precisi. Ma non e’ questa la sede, scadremmo nel pressappochismo se ci provassimo. Dissento solo quando scrivi:
Facile sentirsi al top se gli interessi sono linguistici, eruditi, archivistici, ecc, molto meno quando si ha a che fare con la storia delle idee, le interpretazioni, i contesti culturali, ecc.
La mia impressione, al contrario, e’ che la debolezza ‘estera’ sia spesso piu’ marcata proprio nel secondo ambito ermeneutico. Alludo al dilagare talvolta degenere dei Cultural Studies et similia nei Dipartimenti di letteratura, per cui si conferisce la stessa importanza a qualsiasi insignificante testo o artefatto culturale, mettendo tutto sullo stesso piano. La stessa commistione disciplinare dei social studies che descrivi ( history, art, + cinema + mafia + calcio + cucina, etc,) non mi sembra il massimo. Sono curioso e aperto per natura, non mi piace disprezzare, ma posso dirti che il piu’ delle volte da letture di libri o ascolti di convegni santificati agli studi culturali o ai loro cascami sono uscito non solo non arricchito, ma francamente sconcertato. Forse e’ un mio limite, forse e’ colpa mia se non sono finora riuscito a comprendere l’innovazione rivoluzionaria di questi studi, ma cosi’ e’ stato nel mio caso. Ho provato spesso la deprimente sensazione di assistere all’azzeramento (per rimozione ignorante, non per ripensamento consapevole) di un’intera storia culturale, con i suoi limiti e le sue ricchezze, ma anche con tutta la sua stratificata e non ingenua complessita’ ; come un ritorno al primitivo, alla preistoria, dopo la cancellazione in blocco, per dimenticanza, di stadi pregressi e stratosferici di civilta’. Pero’, ripeto, dovremmo riparlarne in altre sedi e altri modi. Per cui finisco qua.
Mi sento invece di fare giusto una breve notazione in merito alla vostra accusa (anche di Fede) nei riguardi dei presunti privilegi dei docenti italiani. Dunque per voi non e’ il sistema universitario italiano nel suo insieme a andare male, ma solo il suo metodo di reclutamento? Da quanto scrivete mi sembra di capire che secondo voi chi ha avuto la fortuna di entrare nel sistema nazionale vive poi una condizione paradisiaca. L’eldorado, allora, e’ quello dei docenti italiani? Ma non era all’estero? I docenti italiani lavorano meno e guadagnano di piu’, scrivete. E sembrate deplorarlo. Stefano, tu addirittura ti poni un curioso dubbio amletico:
Io resto cnvinto che il professore italiano goda di una libertà intellettuale e lavorativa che all’estero non c’è: è un bene o un male?
E’ ovvio che se fosse cosi’, se il professore italiano davvero godesse di una liberta’ lavorativa e intellettuale inesistente all’estero, la cosa sarebbe solo e unicamente un bene. Ma che siamo masochisti? Vogliamo essere meno liberi sia sul luogo di lavoro sia, ancora peggio, nella nostra ricerca intellettuale? A me pare ovvio che sia sempre meglio essere piu’ liberi, e che sia meglio, per rispondere anche a Fede, lavorare meno, se per lavorare si intende, come credo voi intendiate, il monte ore dedicate alla didattica, che in Inghilterra e’ sicuramente molto piu’ alto (e piu’ routinario) di quello previsto per i docenti italiani. Il fatto che in Italia si possa anche tenere un solo corso in un solo semestre per avere diritto allo stipendio di base a voi sembra negativo? Ma a me proprio no! Magari fosse cosi’, o si potesse ancora continuare cosi’ laddove ancora lo e’. Si darebbe piu’ spazio alla ricerca destinando sistematicamente un secondo semestre allo studio, alla scrittura, alla sperimentazione laboratoriale ecc. La nuova universita’ burocratizzata e licealizzata ha tra i suoi tanti difetti anche quello di strozzare gli spazi e i tempi da dedicare alla ricerca. Che certamente andrebbe monitorata in modo piu’ rigoroso, ma che resta vitale anche a garanzia di una buona qualita’ della didattica. L’idea che gli italiani siano tutti sfaticati assenteisti non la condivido proprio. Mi e’ sempre sembrata uno stereotipo razzista. Sul guadagno non saprei, non credo sia vero che in Italia si guadagna meglio. Forse dipende dai casi, visto che le paghe sono variegate all’estero in base alle sedi e ai gradi. Sicuramente pero’ in Italia i fondi di incentivo alla ricerca sono molto meno pingui che altrove. Alla fin fine, dunque, non credo che la condizione dei docenti italiani sia privilegiata, non certo dal punto di vista economico, in ogni caso. Forse la nostra accademia resta ancora meno rigidamente organizzata di quella inglese e meno orientata sulla didattica, lasciando quindi piu’ tempo libero ai docenti (cosa da difendere, e semmai da tentare di esportare, non da accusare come segno di inefficienza e-o di scarso attaccamento al lavoro). Ma se il sistema e’ guasto, lo e’ a tutti i livelli. Se lo e’, non basta entrare per viverci bene. Forse anche qui si potrebbe provare a rovesciare la prospettiva del discorso. Magari promuovendo un questionario da sottoporre ai docenti di ruolo italiani in merito ai loro presunti tassi di desiderio relativi al trasferirsi all’estero. Ai bandi sul ritorno dei cervelli pare abbiano risposto migliaia di espatriati. Chissa’ quanti incardinati in patria risponderebbero a un concorso opposto per l’espatrio. Io penso che sarebbero molti. O mi risponderete che sarebbero pochi perche’ quasi tutti sono corrotti e conniventi con un sistema feudale di privilegi? Non so se cio’ sia quanto crede Gardini – il cui libro, come ripeto, non ho letto -, ma sarebbe un’ipotesi davvero massimalista e pregiudiziale. Le generalizzazioni sono sempre inutili e dannose. Come non si puo’ dire che all’estero si stia sempre e in tutto meglio, cosi’ non si puo’ dire che gli italiani siano tutti pigroni, delinquenti e corrotti. Ci sono tanti studiosi onesti e bravi in Italia, anche all’interno dell’universita’. Ricordiamocelo. In Italia c’e’ la mafia, ma non siamo tutti mafiosi, c’e’ Berlusconi, ma non tutti siamo prostituti del berlusconismo. Condivido l’invito di Gilda ad auto-responsabilizzarsi. Ognuno guardi prima di tutto se stesso, e quanto realmente fa per resistere al declino e al marcio, e per cercare di cambiare le cose, nel suo piccolo e dovunque. Che poi non esistano in questo momento punti di riferimento collettivi, gruppi o istituzioni capaci di alimentare movimenti di opinione e-o di protesta organizzati lo sappiamo, purtroppo, ne’ la cosa riguarda solo le universita’.
Con questo vi saluto evi ringrazio, augurandovi buone vacanze, dato che oggi parto finalmente per le mie. Non so se nei prossimi giorni potro’ ancora leggere e intervenire, dato che saro’ in viaggio, ma meditero’ ancora, pur con lo scetticismo che mi contraddistingue, sui tanti spunti interessanti emersi in questo blog. Ciao!
La situazione dell’Anglistica in Italia? Che dire, basta fare un salto a Villa Mirafiori a Roma. E penare che il più grande anglista italiano è Franco Moretti, cacciato da un “certo” Agostino Lombardo, alla cui morte è succeduta una corte dei miracoli, davvero poco illuminata. Prtoprio una scelta azzeccata, la sua. Qualcuno sostiene che un professore d’inglese abbia vinto il concorso non sostenendo la prova in lingua, perché non capace. Oppure di quella anglista repubblichina, grande scrittrice (sic!), che pur scrivendo di shakespeare parla esclusivamente di sé stessa. E l’elenco potrebbe continuare. Basta vedere il numero delle persone che va via…
Io, da secondo all’esame di accesso al dottorato sono stato “scavalcato” da altre persone, evidentemente più brave a ungere. E non scherzo. C’è chi va avanti a colpi di mozzarella di bufala.
Valga quanto sto per dire soprattutto come ringraziamento a chi è intervenuto in questa discussione con encomiabile competenza e passione mai trascesa in rissa (mirabile dictu).
Le testimonianze fin qua ricevute sono importanti, direi fondamentali, tutte, per le posizioni argomentate e i toni pacati, anche (soprattutto, direi) quelle anonime. Però questo dato, a posteriori, mi fa apprezzare maggiormente il libro di Gardini.
Nicola Gardini, appunto, non ”anonimo oxoniense”.
Questo, almeno questo, gli si può riconoscere, tutti?
anonimo scettico scrive: “E’ ovvio che se fosse cosi’, se il professore italiano davvero godesse di una liberta’ lavorativa e intellettuale inesistente all’estero, la cosa sarebbe solo e unicamente un bene. Ma che siamo masochisti? Vogliamo essere meno liberi sia sul luogo di lavoro sia, ancora peggio, nella nostra ricerca intellettuale?”
forse c’è un equivoco: per “libertà lavorativa e intellettuale” in questo caso si può intendere anche: assenza di controllo, assenza di verifiche, poco stimolo alla competizione, indipendenza tra la qualità e la quantità della produzione scientifica e l’avanzamento della carriera, etc. siamo ingenui?
lorenzo
Anch’io trovo, come Gilda, che il “dibattito” sia stato utile ed interessante e di certo fa onore al libro di Gandini (e all’autrice della recensione). Certo fa impressione che ci siano tanti “anonimi” addirittura “per sicurezza”.
In ogni caso buone vacanze a chi e’ andato in vacanza! tra poco tocchera’ anche a me … Magari ci possiamo vedere da queste parti, alla presentazione del libro di Gandini a Londra, se ci sara’ …. Federico
Aggiungo alla discussione su I Baroni di Nicola Gardini, un contributo di Roberto Gigliucci, uscito su L’altro di Sabato 1 Agosto 2009.
Nicola Gardini è un comparatista, ma è soprattutto un raffinato lettore e traduttore di poesia, e un poeta di limpida chiarezza, che attinge al verso greco e latino come a Auden, alle certezze cupe di Lucrezio come al lamento di Ovidio in esilio, si fa pensoso sul mito tragico di Ippolito e sa sciogliersi al sole epicureo della felicità. Insomma, un italiano che si fa valere.
Proprio come italiano, e come ex accademico dell’università italiana, esce ora alla ribalta, dopo la sua assunzione a Oxford, col romanzo-autobiografia I Baroni. Come e perché sono fuggito dall’Università italiana (Feltrinelli, pp. 203, euro 13,00) che sta facendo discutere i lettori e i curiosi e sta facendo quasi accapigliarsi gli addetti ai lavori e gli amici o anche semplici conoscenti.
Partirei da un’immagine del libro. L’autore è a Istanbul, fuori nevica all’infinito. Nel museo archeologico Nicola è davanti a una testa di Saffo. È davanti alla pietra che effigia la poesia stessa, e che reclama tacitamente un’interrogazione da parte degli uomini, promette «qualche rivelazione di una realtà immemorabile». Nicola è cioè davanti al senso stesso possibile della poesia, la sua irriducibilità al tempo, la sua compattezza di essere, e quindi davanti al senso possibile dell’esistenza di un poeta: di lui, Nicola. In questo momento che si vuole caricare di una semanticità quasi spaventosa – fuori la neve, dentro il volto senza occhi della poesia – Nicola riceve una telefonata al cellulare. È il professor Corona, la causa prima delle sue sofferenze accademiche: gli comunica che dovrà tornarsene all’università di Palermo, dove nessuno lo vuole e dove ha subìto una sorta di mobbing sfibrante, allucinante, quasi. Insomma, la crudeltà italica raggiunge Nicola nel momento in cui egli sta cercando e trovando se stesso.
Si tratta di una scena riassuntiva della vicenda narrata. Dall’università italiana l’autore ritiene di aver ricevuto solo ventate d’irrazionalità antimeritocratica e angherie più o meno sottili. E non si stenta a credergli. Il Barone è per lui il rappresentante antropologico compiuto del male accademico. Agli antipodi c’è il Poeta. «Il Poeta è l’opposto del Barone. Il Barone vuole a tutti i costi aver ragione. Il Poeta, al contrario, non fa nulla per aver ragione. La poesia è tutto tranne che ricerca di consenso. Il Poeta, come diceva Canetti, è cempre contro il suo tempo. Per questo non ha un ruolo nella società. Il Barone, invece, vive in funzione esclusiva della società; addirittura pretende di crearne una» e così via.
Capiamo che questo non è solamente un romanzo a chiave sull’università italiana e sulle disgrazie di una delle sue vittime (di casi analoghi sono pieni libri-inchiesta di recente pubblicazione, da ultimo lo sconcertante e sgomentante Parentopoli di Nino Luca, uscito per Marsilio). I Baroni è l’autoeffigie di un poeta (cioè versificatore, lettore di poesia e vocato alla poesia, insomma) nel mondo del lavoro universitario, dove l’ontologia poetica si sfracella sui muri delle ragioni accademiche, ragioni irragionevoli ma che costituiscono un sistema perfettamente autosufficiente e che regge a ogni terremoto, ancorché sia strutturalmente marcio. Quindi il libro è la scoperta di sé a sé che Nicola compie attraverso disillusioni laceranti (chi le ha conosciute sa di cosa parlo) ed esaltazioni che costruiscono la sua identità.
Sembrerà strano, ma questo è un romanzo sulla felicità e su come concepirla e compierla. «La felicità è un’opera o, ripetendo Aristotele, un’arte poetica. Chi la realizza scopre necessità e armonia là dove supponeva che si trovassero solo detriti e caos. Essere felice, per me, è contemplare, di colpo, come da un punto elevato, quel che è stato e, perciò, quel che sono». Se la felicità è un’opera, allora un uomo deve agire, perché è suo diritto essere felice ed è suo quasi-dovere muoversi e darsi da fare per godere appieno di questo diritto. Ecco il senso intimo del libro. Nicola, nella narrazione di sé che sviluppa per 200 pagine, non cela il proprio narcisismo, e forse fa bene, ma certamente racconta di come non ha voluto rassegnarsi all’infelicità propria o alla meschinità grottesca e autolesionista che anima la società italiana. Ha voluto di più, l’ha preteso subendo attacchi, ironia, accuse d’ingenuità, inganni, colpi bassi, alti, medi.
Non è un puro, non si dichiara un puro, si riconosce anche talora colpevole (e pure questo è narcisismo). Però non vuole essere neghittoso, non si ferma. Non solo gira per il mondo e assorbe altre lingue poetiche, ma cerca, semina, reagisce, e alla fine vince: ottiene un posto a Oxford sulla base dei suoi meriti. E vogliamo credergli. E siamo contenti per lui. E se il romanzo ha qualche ombra (la più vistosa mi pare quella di essere così autoreferenziale e lirico-saggistico da non caratterizzare per nulla i personaggi, soprattutto i grotteschi Baroni che sembrano più o meno tutti uguali, rinunciando così a una satira di tipo balzacchiano, per intenderci, e il materiale c’era), la cosa che conta è che l’obiettivo elegiaco (l’esilio in patria) e polemico (la rabbia stupefatta) è raggiunto.
E per chi resta in Italia cosa c’è in sorte? Nulla, se non la colpevolezza per tutti, conclude Gardini. Avrà ragione? Temo di sì.
Mi permetto di suggerire una risposta alla domanda di Gilda Policastro, che riporto:
“Detto diversamente: se l’introduzione di criteri oggettivi per la valutazione dei titoli (sia pur con tutti i limiti che l’attribuzione di un punteggio, per dire del più importante, a una pubblicazione in base alla sua sede) si deve (sic!) alla riforma Gelmini (peraltro non ancora in atto), e per decenni il criterio selettivo sono state invece prevalentemente le prove scritte di concorso, tu al posto di un docente che avesse i titoli e le competenze per giudicare un candidato (dunque nella migliore delle ipotesi, cioè al posto di un docente preparato e onesto), come ti saresti regolato di fronte alle prove pressoché equivalenti di un candidato interno e uno esterno, il primo dei quali avesse speso anni della sua formazione accanto a te e sotto il tuo magistero, magari collaborando, come da prassi, alla didattica, agli esami e tutto il resto: a parità di merito, ripeto, non avresti favorito il candidato interno?
La risposta, piuttosto ovvia è che nelle università – aimé soprattutto straniere – più intelligenti non fanno concorsi truffa come in Italia e, per rispondere più precisamente, se, come in Italia, organizzo un concorso truffa e poi devo scegliere tra un candidato interno e altri – a parità di punteggio per il tema del concorso, nelle università più decenti si sceglie quello che ha il CV PIU’ BRILLANTE. Anzi all’estero non si fanno per niente i concorsi disonesti che ci sono in Italia ma semplicemente si manda il proprio cv e se le proprie credenziali sono brillanti si è scelti per queste. In Italia i concorsi delle università sono perlopiù una presa in giro che costa molti soldi ai contribuenti, sono pilotati, anzi il vincitore è già stato scelto, il tema spesso suggerito, il concorso spesso costuito ad hoc sul cv della persona che ha già vinto prima di farlo e, last but first, non conta se uno ha un cv brillante. Se uno ha passato magari 10 anni in un brillante centro di ricerca negli USA, spesso viene superato da chi ha a malapena qualche modesta pubblicazione in riviste solo del proprio istituto. La Sig.ra Policastro lamenta che è difficile determinare criteri oggettivi per valutare quale siano le esperienze accademiche più brillanti? Poverina, davvero lacerante.
Un criterio di scelta è, ad es, le pubblicazioni a livello internazionale, che di solito valgono di più delle pubblicazioni che girano solo nel proprio istituto e che spesso sono fatte solo per avere una pubblicazione e che non valgono molto.
Che cosa farei se il candidato interno e quello esterno hanno passato con voti uguali? Sceglierei non il candidato interno, ma quello che ha il miglior cv, quello che fatto brillanti esperienza anche internazionali. Elementary, Watson!
Ho apprezzato moltissimo il libro di Gardini.
Roberta Barazza