ARRENDITI DOROTHY!
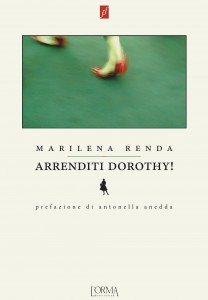
L’orma editore, collana fuorirformato, 19 febbraio 2015, Roma
C’è un crinale sottilissimo dunque che merita la nostra attenzione; le parole devono essere maneggiate con cura ma allo stesso tempo vissute, viste, assaporate, ascoltate.
Ecco:
«Fry
Rye
Die
Cry
My
My
My
My
My.»
Un triplo elogio al ritmo, al suono, al cibo. Non è forse questo, farsi trasformare dai fulmini delle parole?
Antonella Anedda.
Esce oggi, per L’orma editore, nella collana fuoriformato diretta da Andrea Cortellessa, Arrenditi Dorothy!, il nuovo libro di Marilena Renda. Ne proponiamo qui di seguito un estratto.
di: Marilena Renda

DI CALMA, DI AMORE O DI NIENTE
Una volta era diverso. Una volta i capelli, gli occhi, il collo e le mani stavano vicini, rispondevano agli ordini, erano riconoscibili come i capelli di, gli occhi di, il collo di, le mani di. Tutte le parti del corpo avevano un aspetto e un proprietario, e se le chiamavi accorrevano. Se fotografata, la faccia era la faccia di, chiunque la conoscesse l’avrebbe riconosciuta. Le parti stavano raccolte, cercavano di non disperdersi nel mondo, sapevano che altrimenti per loro sarebbe stata una specie di morte, perché il mondo reclama i suoi diritti ma non sai che forme ti fa assumere.
Poi è successo che le parti hanno ceduto di schianto. Si sono allontanate per le diverse direzioni dell’aria ognuna per suo conto, e ora non c’è parte che sia uguale a prima, che se la vedi la riconosci, che se la incontri dici: queste sono le mani di, sempre belle le mani di.
Le parti non si lamentano, l’hanno voluto loro di andare ognuna per la loro strada, ora non possono dire niente neanche se volessero, anche se certo, ogni tanto si spaventano.
Ogni tanto passano attraverso l’aria come se passassero sotto l’acqua, o si abbassano quando dovrebbero sollevarsi. Non dicono niente ora, né al mondo né alle altre parti. Ognuna sta in silenzio, e si prende la sua parte di freddo o di caldo, di fretta o di calma, di amore o di niente.

TU, CHE FAI RICORDARE AI VIVI CHE SONO VIVI
Se mi insegui ti verrò dietro perché voglio pagare i miei debiti e i tuoi, perché voglio riscuotere le chiavi che hanno smesso di suonare nel deserto.
Voglio andare nel tuo corpo che è un paese sconosciuto, voglio camminarci sopra con le dita e con le mani, e quando le mani e le dita avranno smesso di cercare fra la terra i gioielli che sono andati sepolti nei giorni che c’era la neve, allora non ci sarà altra terra da cercare oltre alla tua carne che vive nel centro perfetto dello spazio disegnato.
Il tuo corpo sarà il mio ultimo campo su cui correre, la giostra per i piedi affondati che hanno bisogno di fuoco, il denaro di chi ha perso gli occhi, una messa cantata per le ossa che non tremano e non sbattono. Farò con le tue ossa il gioco che facevo da bambina, quando alzavo e lasciavo cadere i nodi dei fili della tela intrecciata alle dita delle mani, che poi diventava un gomitolo con cui ricominciare a combattere ancora. I corridoi delle case che cadono saranno come le stanze d’albergo in cui i topi si perdono a guardare le briciole.
Tu, che fai ricordare ai vivi che sono vivi, costruisci una lingua oscura che non si può smettere di toccare perché nelle sue pieghe ci sono parole che vanno continuate a cercare. Stare zitti è un grido di vittoria accanto al tuo corpo che ha lo stesso odore, la stessa misura della luna che si compie quando finalmente il mondo è pronto. Allora saremo solo noi due a mandare in pezzi la luce quando sarà possibile girare su noi stessi e sciogliere i lacci che circondano le gambe fino alla testa vorticando come gli aquiloni che si vanno perdendo dalle mani perché hanno altri appuntamenti nell’aria.
Gli amanti che si sporcano guardano le luci che cominciano di nuovo, dopo che la terra si è perduta su un’altra terra. Gli amanti che si spogliano dei nodi per avere le mani libere ridono per l’aria che gli solletica le fessure, e devono scappare per salvarsi la vita, ma prima tornano nel corpo dell’altro per trovarci una memoria, un grammo d’oro.

UN INFERNO DI MEMORIE MUMMIFICATE
Nei suoi angoli più polverosi il palazzo riserva ancora sorprese sconcertanti. Tra i lumi settecenteschi statuine di ceramica laccata danzano amori di un’ora, nei cassetti la biancheria ingiallita e le lettere avvolte nei nastri si piegano senza volerlo agli intrighi del tempo, ai fastidi dell’aria che si allontana senza un rumore.
In un angolo estremo, sotto una lampada, una carcassa dice che il tempo è morto da troppo tempo; dai cadaveri delle poltrone, delle lampade, degli arazzi, dei fregi Bendicò il cane si staglia come creatura di un giorno di gloria, amata tra le foglie e i giochi di un altro secolo e poi morta ancora, morta che continua a morire e non si decide a morire per sempre, tumefatta e mai riparata, passato che si disgrega e diventa polvere gialla scomposta e fatua. La morte fa di pietra il cuore degli animali quando sono ancora vivi, e rende vero il calcolo degli astronomi quando ascoltano le stelle. I santi, invece, sono fantasmi, e gli ospiti della casa sono spiriti ubriachi del loro passare.
Chi si perde non torna, e chi ha paura dell’oscurità non esce dalla stanza delle mummie ammassate, ferme a riflettere la verità del trapasso e trasportarla qua. Il mucchio che una volta era stato zampe e muso e baffi è lo stesso animale morto tra le stelle contemplando una donna che non c’è. Potere e illusione si conservano per la durata di un giorno di follia, e cane e padrone ci mettono un secolo a morire.