In Bosnia. Viaggio sui resti della guerra, della pace e della vergogna
Ringrazio Cristina Babino per la segnalazione del libro e per avermi fornito tutti i materiali (ndf).
di Pierfrancesco Curzi
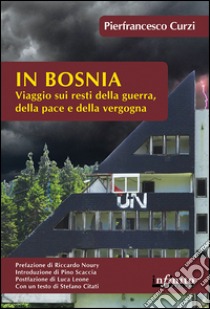
In Bosnia, a vent’anni dalla fine di una guerra sanguinosissima, nella quale – nel cuore dell’Europa – sono stati commessi i più gravi crimini contro l’umanità dalla seconda guerra mondiale e si è svolto il più veloce genocidio della storia, quello di Srebrenica, sono ancora troppo dolorosi i ricordi delle vittime e ancora ostinati i silenzi dei carnefici. Le prime e i secondi non di rado s’incrociano e questo già dice tutto sul mefitico clima d’impunità che si respira nel Paese. Il viaggio di Curzi è un viaggio nella memoria di coloro che, in oltre tre anni di guerra, hanno visto morire decine di familiari e amici, di coloro che sono sopravvissuti agli assedi, alla fame, agli stupri, alle torture. Quello di Curzi è però anche un viaggio della memoria. L’autore, foto e documenti d’epoca alla mano, va alla ricerca degli infami centri informali di detenzione disseminati in tutta la Bosnia per verificare cosa ne è stato di quella fattoria, di quel capannone industriale, di quell’albergo, di quel centro termale adibiti dal 1992 al 1995 a luoghi di stupro, tortura e omicidio di massa. Con risultati opposti: non c’è più nulla o è ancora tutto lì. Gli incontri con le persone sono raccontati con grande trasporto emotivo: con delicatezza e solidarietà quelli con i sopravvissuti, con indignazione quelli con chi stava dalla parte dei criminali, con chi da un giorno all’altro si è scoperto visceralmente serbo o croato e ha scoperto nell’altro, il suo vicino di casa, il nemico storico musulmano. Quella della Bosnia è stata una guerra enorme combattuta in piccoli, a volte piccolissimi luoghi: villaggi, frazioni improvvisamente assediati, gli abitanti rastrellati e uccisi o deportati, tutto demolito o dato alle fiamme. Fa bene quindi Curzi a percorrere in lungo e in largo il Paese, a entrare e a uscire dai confini interni artificialmente disegnati a Dayton, ad accostarsi alle frontiere internazionali con Serbia e Croazia. Così facendo ci ricorda che, oltre al genocidio di Srebrenica e all’assedio di Sarajevo (durato più di quello di Leningrado), vi sono stati tanti altri orrori: Višegrad, Žepa e, fuori dalla Bosnia, Vukovar.
(dalla prefazione di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia)
Pubblichiamo qui di seguito il capitolo conclusivo del volume.
CONFINI
Esco da Bihać e in venti minuti sono alla dogana di Klokot. Mi rendo conto, in colpevole ritardo, d’essere in procinto di lasciare la
Bosnia. Poco tempo per commuoversi. Per una volta spero in pratiche doganali lunghe. Pochi giorni fa in fila per un’ora alla dogana di Županja. E andavo di fretta. Oggi neppure venti secondi di anticamera. La doganiera croata intima di fermare l’auto, il controllo del bagaglio non serve, il sorriso sincero acconsente il transito. C’è poco da ridere. Me ne vado, consapevole di poter far ben poco per le sorti della Bosnia.
Sono di nuovo in Croazia, scenario intrigante, macchia mediterranea. Scalando alcuni tornanti montani trovo i ruderi di una chiesa meravigliosa. Solo il perimetro murario, i segnali timidi di una ristrutturazione dimenticata tra impalcature abbandonate e sacchi di cemento buttati qua e là. A fianco case mangiate dai bombardamenti. All’improvviso, dalle case diroccate, spuntano un branco di cani arrabbiati. Resto di ghiaccio. Sono a metà strada tra loro e l’auto. Inizio a muovermi, guardingo, loro avanzano. Di scatto inizio a correre all’impazzata. Colti di sorpresa, guadagno il tempo d’entrare nell’abitacolo e sgommare via.
I laghi di Plitvice sono tornati a essere attrattiva turistica di tutto rispetto. Io viro a sud. Invece di puntare verso Udbina, più a est, sede

del famoso aeroporto militare usato come base aerea serba, vado verso Gospić. Paesaggio brullo, roccioso, macchiato di arbusti, morbidi saliscendi. Luogo ideale per imboscate e battaglie cruente, confini irregolari. Appena uscito dal minuscolo abitato di Ljubovo, sulla strada trovo le lapidi di un memoriale croato. Sei gruppi marmorei eretti per onorare i caduti dell’Operazione Tempesta. Il maggiore ospita la lapide dedicata a otto soldati. Le date di nascita sono diverse, quelle di morte fissate al 4 agosto 1995, a parte due, trapassati il 16 agosto. L’area è recintata con ghiaia, fori e lumini, sopra la lapide un elmetto militare. Altra lapide, altre due vittime, morte il 5 agosto 1995. Poi lapidi singole per Davor Grginović, 25 anni, e Miljvoi Pogorelić, 30 anni, passati a miglior vita il 4 agosto. Infine l’ultimo gruppo, quattro mini-pietre tombali singole. Soldati uccisi, soldati che hanno ucciso.
L’Europa, tanto per cambiare, era ignara di cosa stava accadendo nei Balcani, quando nel distretto della Lika si andava da un massacro all’altro. Vendette, odio interetnico, cattivo vicinato.
Ottobre 1991. I serbi si sono allargati, vogliono continuare nel movimento di annessione e per farlo sfruttano la maggioranza della popola- zione. Due gruppi nazionali e due religioni inconciliabili, storie e culture diverse. Pari, a tratti soltanto nell’efferatezza dei crimini commessi. Siamo nella Croazia a maggioranza serba. Strage qui, massacro là, faida sopra e regolamento di conti sotto. Tradotto: continui bagni di sangue. Di cui pochi parlano. A chi poteva fregare in Europa se mandrie di pastori, contadini e trogloditi sgozzavano, squartavano, si sparavano addosso e non si fermavano davanti a nulla?
Gospić è parte della Krajina, vicina alla costa, un’ora di strada da Zadar. La conquistata autonomia da parte della Croazia cambia i connotati e i confini geografici della ex Jugoslavia, Pangea alla deriva, smembramento senza soluzione di continuità. Gospić non è più Jugoslavia, è Croazia, però la città e l’area circostante, fino ai confini bosniaci, sono storicamente state abitate in prevalenza da serbi. Il referendum sull’indipendenza riaccende vecchi rancori. Adesso non c’è più il maresciallo Tito, il duro col pugno di ferro, ora è anarchia totale.
Fuori dai circuiti dell’informazione. Del massacro di Gospić, infatti, si sa e si vuole conoscere poco. Sono i croati a mettere a segno il punto, quando tra il 16 e il 18 ottobre 1991 lasciano a terra decine di cittadini serbi. La storia di quegli anni racconta la partita infinita tra i due neo-Stati, fatta di violenza e repressione. Tre giorni prima del massacro di Gospić, il 13 ottobre, i serbi si macchiano di un fatto gravissimo ai danni di un piccolo villaggio nei dintorni del capoluogo. Intere famiglie vengono sterminate, 40 i morti. Non si fa attendere, ed è durissima, la vendetta croata. Fonti serbe parlano di almeno 150 persone uccise o scomparse. Ci vorranno dodici anni per vedere i responsabili ufficiali del blitz alla sbarra, il comandante dell’unità, Mirko Norac, e altri stretti collaboratori. Ecco cosa raccontò Miroslav Bajramović, membro dell’unità responsabile del massacro, molti anni dopo i fatti: «Abbiamo ucciso tra le 90 e le 100 persone in pochi giorni. L’ordine per Gospić era chiaro: pulizia etnica. Noi lo prendemmo alla lettera. Giustiziammo il direttore delle poste e quello dell’ospedale, proprietari di ristoranti e altri cittadini serbi assortiti. Omicidi sul posto, senza troppi pensieri, dovevamo fare in fretta. Ripeto, ordini dall’alto ci imposero di ridurre la percentuale di serbi a Gospić». Nonostante i sacchi pieni di cadaveri, il governo guidato da Tuđman ha sempre negato ogni evidenza. Solo il nuovo corso politico croato, dal 1999, ha portato a indagini e capi d’imputazione.
Corpi gettati dentro fosse comuni, all’interno di cisterne settiche, addirittura sotterrati da colate di asfalto. Indagini rese particolarmente difficili dalla popolazione civile, filo-nazionalista, per cui non c’era stato alcun massacro e, qualora si fosse verificato, era comunque stata cosa buona e giusta. Il sindaco stesso si oppose ad approfondimenti investigativi, scavi ed esami forensi. Nel 2001 i responsabili principali finirono in tribunale, spinti dall’ostinazione del nuovo presidente, Stjepan Mesić.
È facile capire come mai abbia trovato molte difficoltà per reperire una seppur tenue testimonianza del massacro di Gospić. Gospić la croata, come Foča la serba. Attualmente la stragrande maggioranza dei residenti è croata, i serbi sono attorno al 3-4%, mentre nel 1991 sforavano il 31% nella municipalità e il 42% in città. L’accoglienza è fredda, nulla di nuovo rispetto a quelle serbe. Fermo gente per strada, nessuno ha vo- glia di parlare con lo straniero inquisitore. Nazionalisti erano prima, tali dovrebbero essere rimasti. Quando all’interno del vocabolario inserisco la parola slava spomen, memoriale, un ometto basso e tarchiato con la coppola in testa indica il percorso. Appena sceso dall’auto, circondato da rigogliosa vegetazione, scopro che il memoriale è dedicato al dottor Ante Starčević. Politico e scrittore croato, nato nel sobborgo di Zitnik (Gospić) e morto nella casa di legno davanti ai miei occhi. È stato uno dei padri del nazionalismo croato. Me lo dovevo immaginare. Con le pive nel sacco, riprendo il viaggio verso Knin.

Il fronte della Krajina, quanto ad asprezza, non è stato secondo ai focolai divampati in Bosnia. Non mancano le analogie, cambiano solo i protagonisti dei massacri, i giocatori in campo. Gli odi sono congelati. E non lo penso solo perché qualcuno ha scritto con lo spray “četinski Kraj 1950”, i četnici della Krajina che hanno “perso la fede”, sul muro pericolante di un ex ristorante. È impressionante la frequenza delle case 211 sventrate. Per chilometri solo fantasmi di cemento; la vegetazione selvaggia presto coprirà gli ecomostri. Entro in un villaggio appollaiato ai lati della statale. Sono a circa 30 chilometri da Knin. Colpisce il silenzio tombale. Decido di fare due passi, il villaggio è disabitato, non c’è più nessuno, neppure la vecchietta gobba e sdentata tipica dei villaggi in capo al mondo. Hanno tolto pure il cartello del paese, ufficialmente non esiste più, restano gli scheletri.
Le montagne della Krajina sono splendide, a tratti aride e rocciose, poi morbide e vellutate, prive di vegetazione ad alto fusto. Panorami infiniti, nessuna cima svetta sulle altre, e la striscia d’asfalto corre senza sottile verso l’orizzonte. Non stona neppure il parco eolico. Lascio dietro villaggi semi-disabitati, Siroka Kula, Vukava, Nikšići, Dreskovići, Gaj, Odari. In fondo, all’orizzonte, l’ultimo colle prima della vista di Knin, la città contesa.
A piedi sotto il sole, una fumana di disperati in marcia verso una meta ignota. Estate ‘95. Gli italici network, colpevolmente assenti quanto a copertura del confitto nel cortile davanti casa, hanno confezionato pochi e annoiati servizi mostrando, solo per dovere di cronaca, orde di disperati. Serbi in buona parte. Gli innocenti hanno pagato per responsabilità altrui, ritrovandosi addosso l’immane peso delle colpe commesse dai loro vertici populisti. Serbi trapiantati dalla storia in terra croata, considerata la “loro” terra da secoli.
I profughi in fuga da Knin sono solo il microcosmo di un esodo continuo, transumanza di anime e di corpi, sofferenza, paura, avvilimento. È toccato a tutti scappare da qualcosa o da qualcuno nella ex Jugoslavia. I disperati, in molti casi, oltre alla casa non hanno più ritrovato le loro radici. Proprietà passate di mano, espropri (il)legalizzati. Le mura tra- sudano ancora sangue e sudore a fondo perduto. La morte mordeva le caviglie, tra sputi, insulti e rappresaglie dei nuovi eletti. Pareggio di conti.
Scherzi del destino. I serbi, per secoli zoccolo duro della popolazione balcanica, a Knin ce li hanno messi proprio gli ottomani. Mezzo millennio fa, nel 1522, le orde turche invasero la città e scacciarono gli odiati nemici croati. E per riempirla, baluardo dell’impero in seno all’Europa non ancora plasmata, pensarono alle migliaia di profughi serbi. Sedimento su sedimento, la maggioranza si è fatta serba, in territorio croato, con la Bosnia a due passi. Strana anomalia, senza peso durante la Jugoslavia federale di Tito. Il leader slavo teneva sotto controllo antichi bollori e odi sopiti.
I serbi crebbero, dunque, e i croati divennero minoranza. I secoli, tumultuosi, tra il ‘500 e il ‘900 scombussolarono le gerarchie colonizzatrici. Arrivarono i veneziani, cattolici, consentendo il ritorno dei croati alla guida del territorio. A fine ‘700 è la volta degli Asburgo, presto arriveranno i francesi e quindi gli austriaci. Il resto è storia moderna e contemporanea, dai confitti mondiali ai giorni nostri.
Knin, la città dei croati, del regno croato, del re Dimitar Zvonimir, cresciuta attorno alla sua splendida fortezza appollaiata in cima al monte Spas, costruita e rimodellata tra il secolo X e il XIII. Knin all’inizio degli anni ‘90 precorre i tempi. Con otto mesi di anticipo rispetto alla dichiarazione d’indipendenza della Croazia dall’ormai ex Jugoslavia, viene pro- clamata la Repubblica serba di Krajina. E Knin ne è la capitale. Ottobre 1990. Le autorità serbe fanno tutto da sole, se ne infischiano del mondo fuori e prima di Natale impreziosiscono l’opera con la dichiarazione di sovranità, ponendo al vertice un altro di quei lord di cui i Balcani sono ricchi: Milan Babić. Il nuovo Stato-fantoccio somiglia tanto al Kosovo, però manca l’interesse internazionale. La richiesta di riconoscimento alla Comunità europea, avanzata da Babić, non ottiene buona sorte. Babić, personaggio curioso: passato dalla cura di carie e otturazioni ad amministrare uno Stato. Entità basata sulla tensione interetnica. La strana coppia si completa con Milan Martić, ex poliziotto trasformato in difensore della patria e della razza. I due Milan godranno degli allori del tempo, l’effimero gusto del comando e il disegno folle di una terra libera da impuri. Il conto, tuttavia, arriva sempre. Martić è stato condannato dal Tpi a 35 anni di prigione per crimini di guerra, Babić si è suicidato a cinquant’anni all’Aja, in cella. Marzo 2006, ecco come muore un uomo eroso dai rimorsi.
Con la Repubblica sovrana dei serbi di Krajina i croati, già minoranza, diventavano mosche bianche, da far sparire. Partendo dal primo rilevamento noto, nel 1880, i serbi a Knin erano l’82,3%, i croati appena il 15,1. Per un secolo le percentuali sono rimaste quasi identiche (72,8% nel 1981 il punto più basso per la parte serba) e prima dello scoppio della guerra la percentuale ha toccato il suo massimo, 85,5%, con i croati appena al 10% e spiccioli. Dieci anni più tardi le proporzioni si rovesciano: sono i croati la maggioranza, 76,5%, con i serbi ridotti a presenza minoritaria, poco più del 20%.
«Sono fuggiti lasciando i soldi e le mutande sporche». Parole concilianti, proferite dal presidente croato Tuđman all’indomani dell’esodo serbo dalla Krajina. Senza acqua e cibo, 150-200.000 persone incolonnate. Solo una minoranza dei serbi di Knin ha ascoltato le parole di Tuđman alla radio croata: «Non abbandonate le case, garantiamo totale sicurezza a chi non si sia macchiato di crimini di guerra». Il messaggio, ripetuto fino a diventare litania, diffuso dagli altoparlanti; simile a quello diffuso a Srebrenica da Mladić. Mentre Tuđman tranquillizza, i suoi fanno piazza pulita di innocenti. Orde di soldati ubriachi, senza scrupoli, devastano vite e speranze: almeno seimila le vittime assassinate. Danni collaterali, senza distinzioni tra vecchi, donne e bambini. Purc hé siano serbi. Militari fuori controllo al comando di lugubri personaggi: Ante Gotovina, Ivan Čermak e Mladen Markac, ufficiali di “sua maestà” Franjo. I vertici militari serbi, venuti a conoscenza della barbarie, non sono certo rimasti con le mani in mano applicando lo stesso trattamento ad altri innocenti, croati residenti nelle zone al confine con Serbia e Ungheria.
hé siano serbi. Militari fuori controllo al comando di lugubri personaggi: Ante Gotovina, Ivan Čermak e Mladen Markac, ufficiali di “sua maestà” Franjo. I vertici militari serbi, venuti a conoscenza della barbarie, non sono certo rimasti con le mani in mano applicando lo stesso trattamento ad altri innocenti, croati residenti nelle zone al confine con Serbia e Ungheria.
Il 1995 è l’anno della resa serba, militare, territoriale ed egemonica. L’atteggiamento spavaldo di Karadžić e la coppia Babić-Martić comincia a scricchiolare in primavera, quando si cerca l’intesa tra le parti per fermare le schermaglie. Trattative lente e infruttuose. La pace ha un costo che nessuno vuole pagare. La proposta è tornare all’autogoverno croato nelle zone a maggioranza, come nel 1991, lasciando ai serbi Knin e dintorni. Tuđman si dice disposto a dare l’autonomia di Knin e Glina e chiede in cambio la cessione delle zone orientali della Slavonia, di cui i serbi si erano impadroniti a inizio confitto. Tutto inutile, i serbi di Krajina non accettano di veder cancellata la sovranità della neo-repubblica. Il patto salta. Intanto sul terreno la battaglia impazza. I serbi distruggono il celebre ponte di Maslenica, a sud di Knin, snodo strategico tra la Croazia centrale e la Dalmazia. I croati lo ritirano su e chiudono i nemici in una morsa inesorabile. L’autostrada Zagabria-Belgrado, la strada più importante della federazione jugoslava, ormai è chiusa dopo i gravi fatti dei mesi precedenti.
La vittoria croata è vicina e inizia a materializzarsi nel giugno 1995. Il mese successivo il crollo serbo è servito. Molti soldati disertano, il fronte resta sguarnito. Dalla Republika Srpska, Karadžić fa ciò che può, inviando in battaglia, col fucile in mano, pure donne e ragazzini. Non basta. Margine per trattare non ce n’è. Viste le dispari forze in campo, Zagabria preferisce puntare sull’azione bellica, fino in fondo. Karadžić abbozza. È vero, le Krajine sono perdute, tuttavia i serbi in fuga saranno convogliati nelle zone della Bosnia tolte ai musulmani e da ripopolare. La vittoria croata è inevitabile e un giorno ne identifica il trionfo, il 5 agosto 1995, l’apice dell’Operazione Tempesta, marchiato dai croati come il giorno dell’orgoglio nazionale (in realtà gli ultimi combattimenti si esauriscono tra il 10 e il 20 di agosto). La campagna di Krajina è un successo totale, Tuđman s’impossessa di territori persi pagando un tributo di sangue limitato: appena 409 morti e meno di 2.500 feriti. Knin è liberata. La conta dei danni è ancora al centro di vivaci discussioni, al punto da ipotizzare il lancio su Knin di un mix tra bombe reali e a salve. Operazione Tempesta soft, mascherata per preparare raid silenziosi. Altrimenti come spiegare gli appena 45-50 edifici, solo la metà di importanza militare e strategica, seriamente lesionati. In realtà il grosso delle distruzioni avverranno in una seconda fase, casa per casa: per ogni edificio conquistato viene posta la scritta “Hrvatska kuća”, casa croata.
Porto di Zara. Inchiodo le gomme a un metro dalla banchina. Sono euforico. Non dovrei esserlo. Dovrei avere il muso lungo, il volto scuro e lo sguardo ombroso per il viaggio ormai al termine. La notte si porta via i rimasugli del viaggio. La nave aspetta da ore, ormeggiata sul molo verso il mare aperto. Al di là c’è Ancona. Penso a cosa è stato e a cosa mi aspetta, pensieri in chiaroscuro. Tra poche ore sarò ad Ancona. Meglio dormirci su. A proposito Momi, Sretan Put.
*
Le fotografie sono di Piefrancesco Curzi
Pierfrancesco Curzi, IN BOSNIA. Viaggio sui resti della guerra, della pace e della vergogna, Formigine (MO), Infinito Edizioni, 2015.